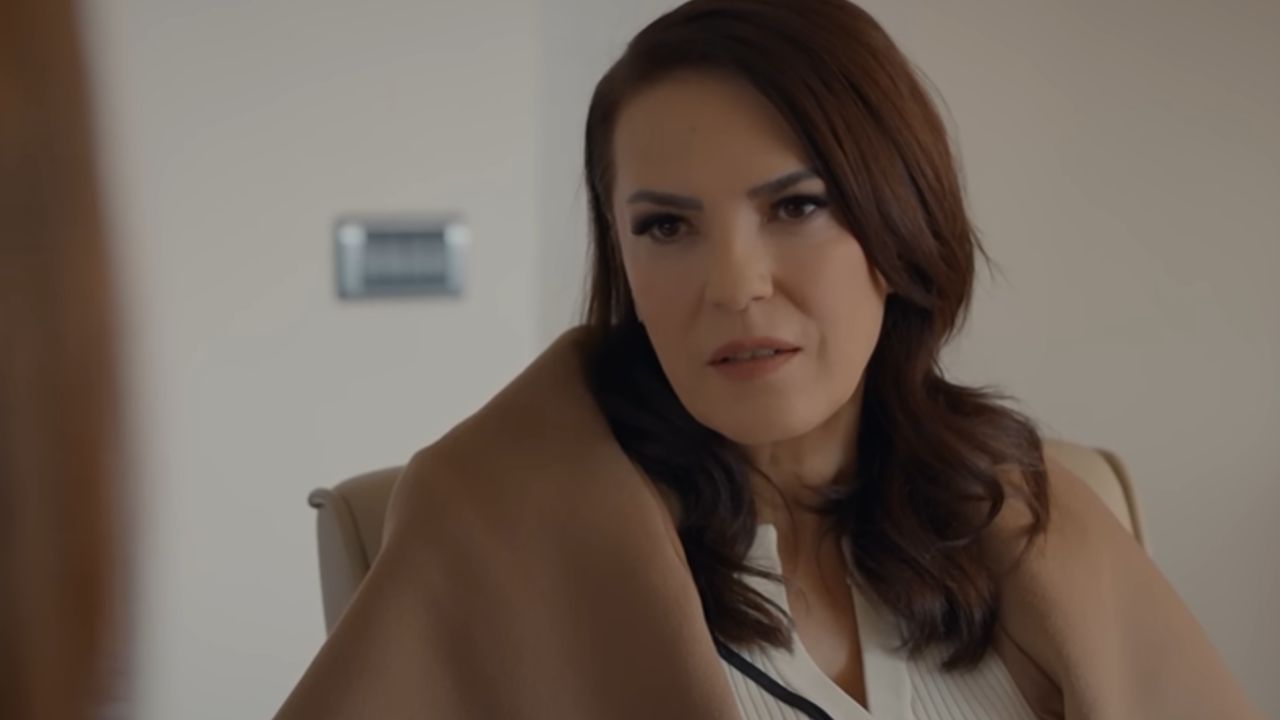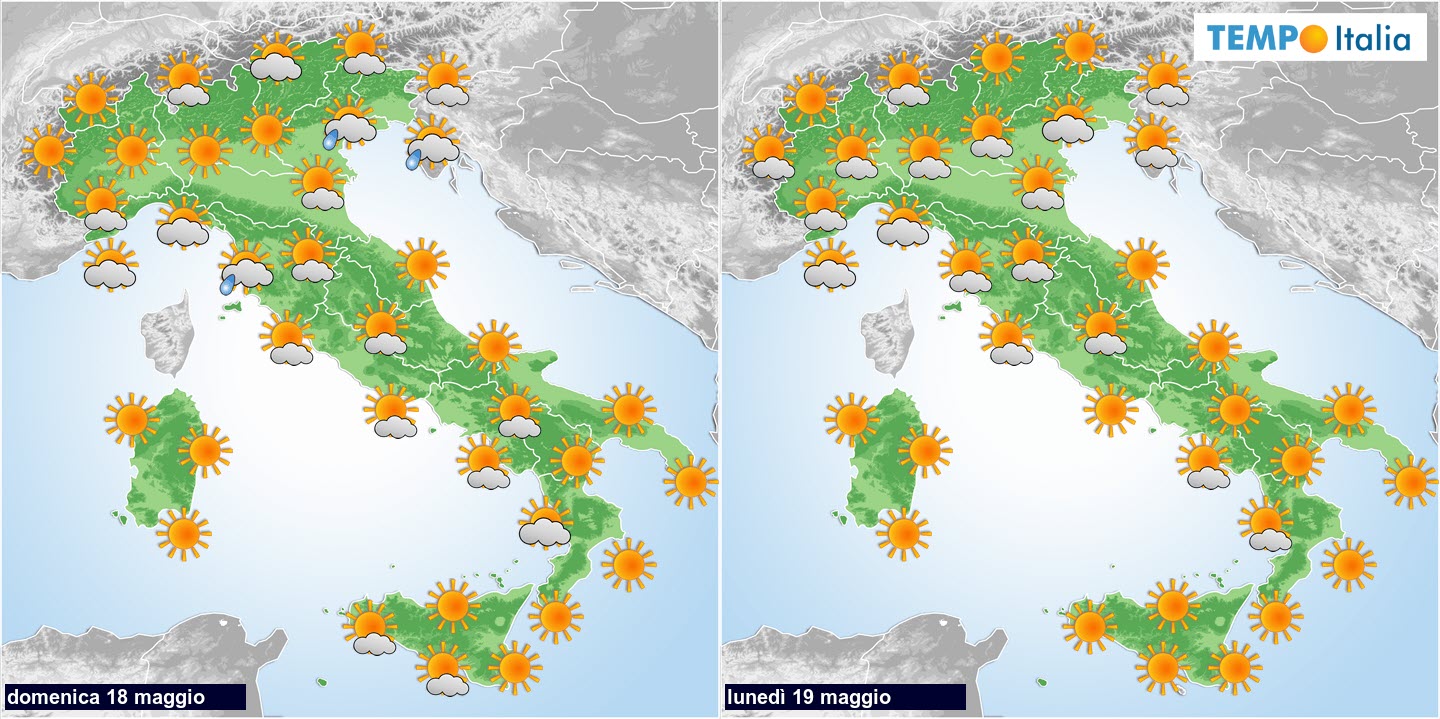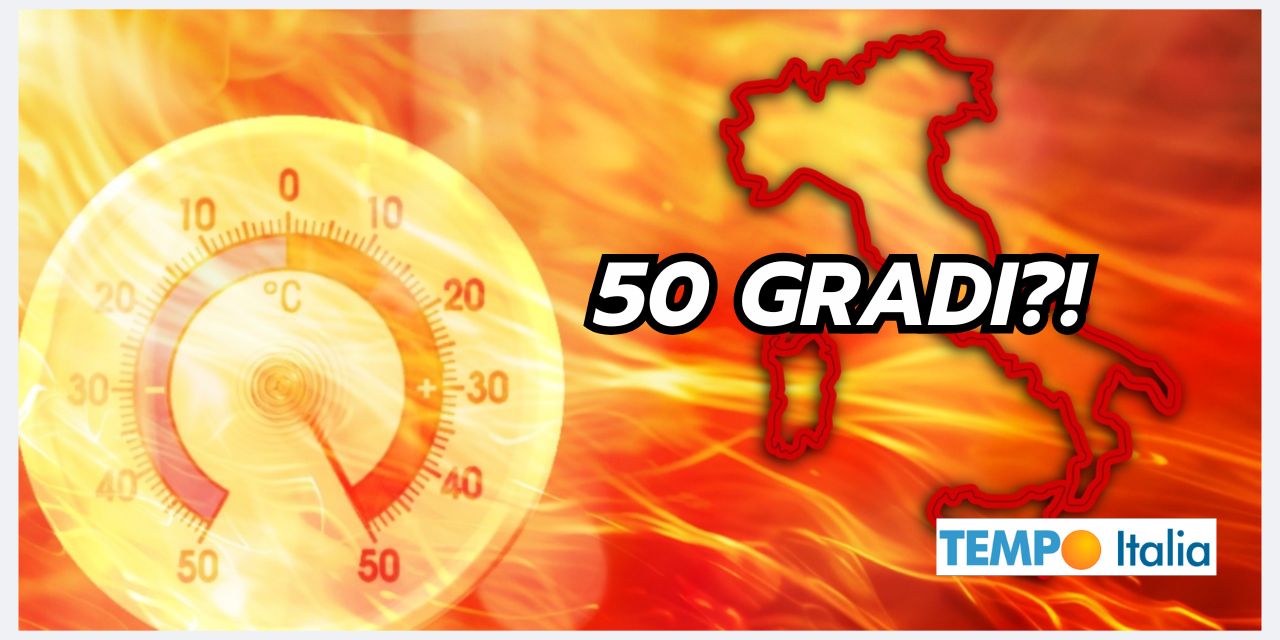Dentro le Parole | LGBTQIA+, un acronimo sempre più lungo?
LGBTQIA+: storia e significato di un acronimo che racchiude numerose espressioni appartenenti a dimensioni differenti: identità sessuale, identità di genere e orientamento sentimentale-sessuale. Lo spiega Alessandro Lucchini nella quarta stagione della serie sul linguaggio inclusivo

In collaborazione con Luca Stoppioni e Lorena Zerbin
La saggezza è saper stare con la differenza
senza voler eliminare la differenza.
Gregory Bateson
All’uscita dal cinema, Andrea e Fabrizio commentano Emilia Pérez, film pluripremiato e pluricandidato agli oscar 2025.
Fabrizio – Chissà se piacerà ai tuoi amici, quelli LGB…? Non me le ricordo mai tutte le lettere.
Andrea – Non scherzare, la sigla LGBTQIA+ rappresenta le diverse forme che possono assumere la sessualità e l’affettività umana, e ha ormai una lunga storia.
LGBTQIA+: storia e significato di un acronimo
Andrea – Racchiude numerose espressioni che appartengono a tre dimensioni differenti: l’identità sessuale (il sesso assegnato alla nascita), l’identità di genere (elemento psicologico e socio-culturale – come mi relaziono in base al genere assegnatomi alla nascita) e l’orientamento sentimentale-sessuale, verso chi proviamo attrazione affettiva e fisica. Le prime attestazioni in Italia, nella sua versione più breve LGBT, risalgono al 2000, come dice Treccani che nel 2014 lo inserisce fra i neologismi.
Fabrizio – Ah, quindi storia anche corposa, pensavo fosse un’espressione più recente.
Andrea – Si forma via via, per evoluzione. La storia ha inizio negli Stati Uniti fra gli anni ’60 e ’70 del Novecento; le prime lettere a comparire furono la L e la G, lesbiche e gay, ossia donne e uomini che provano attrazione verso persone dello stesso sesso. Presto si aggiunse la B per indicare le persone bisessuali. Nei due decenni successivi compaiono la T, persona transgender, ossia che non s’identifica con il genere assegnatole alla nascita (cisgender è invece la persona che s’identifica con il genere assegnatole alla nascita), e la Q per queer, termine ombrello per identificare tutte le persone che non si riconoscono nelle tradizionali etichette di identità, genere e orientamento.
In anni più recenti si aggiungono la I, per intersessuale, persona il cui corpo non è conforme alle combinazioni binarie delle caratteristiche sessuali e la A, per asessuale o anaffettivo, persona che non prova attrazione fisica o affettiva verso altre persone. Il + in fondo sottolinea il fatto che non si tratta di una realtà cristallizzata, ma aperta a includere tutte le altre esperienze, identità e orientamenti non descritti nelle lettere precedenti.
Custode di identità, promotore di visibilità
Fabrizio – Capisco che nominare le cose è fondamentale: solo così possiamo prendere consapevolezza e conoscenza delle cose. Come diceva Ludwig Wittgenstein nel Tractatus logico-pfilosophicus, «I limiti del mio linguaggio sono i limiti del mio mondo». Ma non è diventata un po’ troppo lunga la sigla?
Andrea – È perché contiene molti significati, rappresenta molti traguardi, frutto anche di lotte e rivendicazioni potenti. Una su tutte: i Moti di Stonewall. La notte tra il 27 e il 28 giugno 1969 la polizia irruppe per una retata nello Stonewall Inn, bar gay del distretto di Manhattan, dando vita a uno scontro violento. L’episodio, peraltro molto frequente all’epoca, è divenuto un simbolo: segna la nascita del movimento di liberazione gay moderno.
Fabrizio – È per questo che giugno è in tutto il mondo il mese del Pride LGBTQIA+?
Andrea – Esatto. Ma anche le altre lettere sono piene di storie, rappresentano le diverse comunità e le battaglie che hanno combattuto: basta pensare all’attivismo delle persone bisessuali o alle difficoltà affrontate dalle persone transgender. La ricchezza dell’acronimo, dunque, garantisce identità all’interno, ma anche visibilità delle diverse identità verso l’esterno, per una società ancora in gran parte modellata su schemi e stereotipi cisgender eterosessuali.
Prendiamo la ruota del potere – uno strumento messo a punto dal governo canadese che aiuta a identificare i privilegi legati alla propria condizione personale – e domandiamoci: io dove mi colloco? Ogni spicchio rappresenta una fetta della nostra vita, più ci avviciniamo al centro più ritroviamo elementi riconosciuti come elementi di potere, più ci allontaniamo più crescono diffidenza e discriminazione. Nella parte centrale incontriamo le caratteristiche di un’identità cisgender, ossia coerente con il sesso biologico e un orientamento eterosessuale. Questa rappresentazione nasce in ambito occidentale e non si può dire sia rappresentativa di tutte le culture, ma è senza dubbio un punto di riferimento. Ora, la ruota è formata da tantissime caselle, ognuna delle quali ha un’etichetta: potremo mai mettere in dubbio che la vita di ciascuno/a di noi sia composta da tutte quelle dimensioni? Ecco, No. La stessa cosa vale per l’acronimo: una multidimensionalità che ha l’esigenza di manifestarsi anche a livello linguistico.
Vantaggi e rischi nelle etichette linguistiche
Fabrizio – Siamo sicuri che ci sia bisogno di tutte queste etichette, quindi categorie, che creano separazione, forse più che inclusione? Penso a quel che dice Paul Murray nel suo ultimo romanzo Il giorno dell’ape, me lo sono annotato:
Ci viene insegnato che se non nascondiamo le nostre diversità, siamo destinati alla solitudine. A non essere amati. E così impariamo a coprire noi stessi con prodotti, etichette, maschere di questo o quel tipo.
Non sarà, anche questa sigla, un altro modo per nascondersi dietro un’etichetta, e uniformarsi a un gruppo, per paura della solitudine? Inoltre l’eccessiva granularità non diventerà un boomerang, specie verso l’esterno? Già oggi l’acronimo è spesso oggetto di sarcasmo.
Andrea – La sigla è in effetti complessa, difficile da ricordare e da pronunciare. In una delle sue versioni più lunghe conta ben 11 lettere: LGBTTQQIAAP. Una seconda T per le persone transessuali, che avvertono il bisogno di modificare il proprio sesso biologico; una seconda Q per le persone questioning, che s’interrogano sulla loro identità o sul loro orientamento; una seconda A per le persone alleate, ossia familiari, amici e supporter delle diverse comunità; e la P per le pansessuali.
C’è persino una versione con un “2” davanti, 2SLGBTQIA+, dove 2S sta per “Two Spirits”, termine usato all’interno della cultura indigena nordamericana, in particolare tra le comunità native dell’Isola di Turtle, per riferirsi a persone che portano nel proprio corpo uno spirito maschile e uno femminile.
Fabrizio – Certo che se una cosa fai fatica a nominarla, fai fatica anche a pensarla. Senza dimenticare che, sottolineando alcune differenze spigolose, si possono aumentare i rischi di armonia interna.
Andrea – Vero. Alcune difficoltà, tra le varie anime, ci sono. Fra queste identità ci sono state e ci sono a tutt’oggi tensioni e resistenze. Si pensi al fenomeno del gatekeeping (letteralmente “controllo all’accesso”) e alle sue varie manifestazioni, come la messa in dubbio dell’autenticità (non sei abbastanza queer), o l’esclusione di chi non si conforma a certe abitudini di quella comunità, o il disconoscimento di identità meno visibili o incomprese, come quella asessuale o intersessuale. O, ancora, alle persone lesbiche e gay accusate di avere troppa rappresentanza e pubblicità, proprio come accade ad alcune persone nere, disabili o migranti che denunciano discriminazioni all’interno della propria stessa comunità. D’altra parte, categorizzare, come c’insegna Aristotele, è un’attività umana indispensabile per chiarezza di pensiero e capacità di analisi.
Fabrizio – È anche generatrice di pregiudizi e discriminazioni (sei questo e non quello): facciamo tutte e tutti parte della razza umana, e lì ci sta dentro tutto. La nostra sessualità: dobbiamo per forza definirla? Scrive Lorenzo Bernini, studioso di filosofia politica e fondatore del Centro di ricerca PoliTeSse-Politiche e Teorie della Sessualità:
Freud insegna anche che il sessuale è una forza perturbante, che strutturalmente ostacola l’iscrizione del soggetto nella società. La morale eterocissessista e patriarcale tradizionale è stata un modo di governare il sessuale, un tentativo di dargli senso e dargli forma. E anche l’odierno proliferare di soggettività e identità sessuali non binarie, rappresentato dal + in fondo all’acronimo, è un tentativo (che sostengo con convinzione, non mi si fraintenda) di governare il sessuale, di dargli senso e dargli forma. Il punto, a mio avviso, è che il sessuale è l’ingovernabile per eccellenza, che una forma non ce l’ha e neppure un senso. Non può quindi che portare scompiglio.
Meglio QUILTBAG? Oppure “comunità arcobaleno”?
Andrea – Comunque è vero, è una sigla complicata, non intuitiva. Come per tutte le sigle, esprime senso solo se si conosce già il significato.
Fabrizio – Anche perché mancano le vocali. Averne almeno una l’avrebbe resa più simpatica, con un suono più simile all’italiano o all’inglese. Magari un suono familiare, un suono amico, un suono – (occhio alla stoccata ironica) – “eterocispatriarcale”: tipo mamma  Leggi Di Più
Leggi Di Più