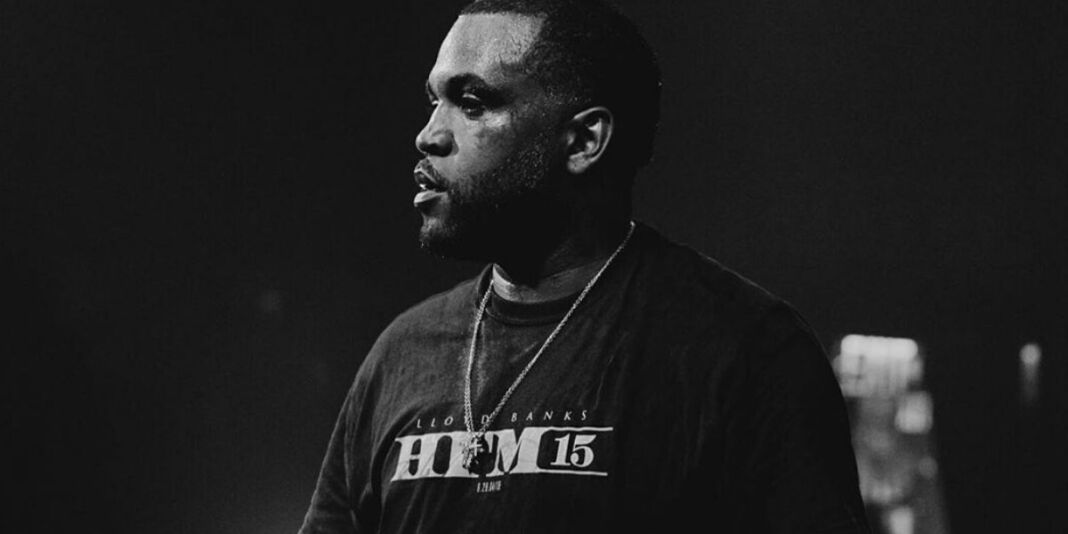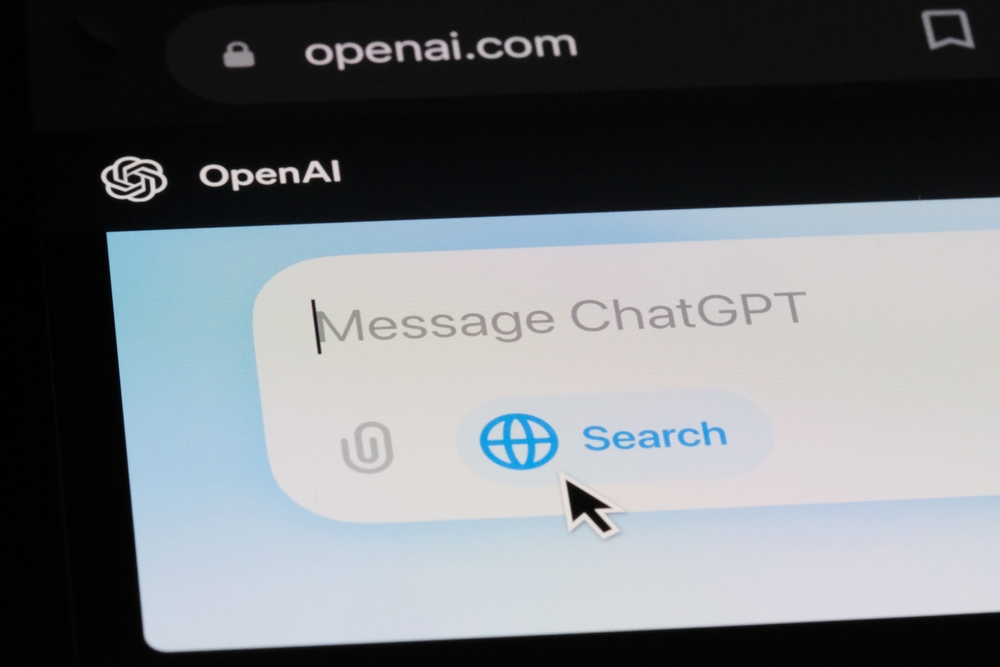Il fascino di Donald. Comprendere e capire come procedere
Se volessi esordire con una battuta crudele direi che oramai si smette di parlare di Donald Trump “ogni morte di Papa”. Tra dazi e tariffe, minacce ed uscite rancorose, promesse […]

Se volessi esordire con una battuta crudele direi che oramai si smette di parlare di Donald Trump “ogni morte di Papa”. Tra dazi e tariffe, minacce ed uscite rancorose, promesse incursioni geopolitiche e vere e proprie gaffe, solo la morte del Sommo Pontefice è riuscita a strappare a Trump la prima pagina dell’editoria italiana.
In altri contesti il rullo implacabile della ‘strategy’ non si è mai fermato. Recentemente, è tornata di moda sul web un’intervista del 2019 di Steve Bannon. In quell’occasione, l’ex teorico trumpiano spiegava dettagliatamente come il vero bastione del vituperato ‘mainstream’ non fosse il partito DEM, bensì i media. Per contrastarli Bannon proponeva una strategia semplice, simile a ciò che in crittografia si definisce “metodo di forza bruta”: la saturazione. Poiché i media sono «stupidi», possono dedicarsi ad uno, massimo due, vicende alla volta. Per avere mano libera e agire come meglio si ritiene è sufficiente ‘intasarli’ con una marea di argomenti: così mentre loro si concentreranno ad alimentare la polemica sull’argomento X, sarà possibile occuparsi senza opposizione di Y. Saranno poi i risultati di Y a farci amare dal ‘popolo’, che riconoscerà che abbiamo fatto ciò che avevamo promesso (quantomeno una parte).
Sin dalla sua prima campagna elettorale Re Donald si è innamorato di questa ‘raffinata’ strategia ed ha imparato che non si tratta solo della quantità, ma anche della qualità: non bisogna solo esasperare il numero dei ‘contenuti’ – orrenda espressione figlia del dominio dei social media – ma anche i contenuti stessi. In breve, più ne spari meglio è e ben venga se le spari grossa. In fin dei conti, si tratta di un classico tentativo di dominare la narrazione, di definire l’ordine del discorso. È certo vero che in un mondo popolato sempre più da percezioni riflesse – dallo schermo die nostri smartphone – si tratta di una strategia logica e funzionale: il modesto plebiscito del novembre 2024 è lì a testimoniarlo. Ma è tutto qui? Si può davvero riassumere la politica di massa in strategia e abilità abbinata a moderni mezzi tecnici? O forse nel seguito (perché siamo lontani dall’idea tutta liberale di consenso) di Donald Trump c’è un altro fattore, più importante e troppo spesso incompreso.
Un punto preliminare da sottolineare è che questa strategia non è certo una novità: non soltanto in generale, ma in particolare per la politica statunitense. Oggi i principali riferimenti della presidenza di Trump sono i presidenti Cleveland e Tyler: espansionisti, alfieri dell’americanismo, dell’eccezionalismo e, soprattutto, dell’estraneità degli USA dagli affari del mondo. Tuttavia, potrebbe non sfuggire ad alcuni che durante il suo primo mandato Trump è stato spesso associato al presidente Jackson: per alcune settimane si è addirittura parlato di “Jacksonian moment”. Jackson, simbolo di quella che è stata definita “l’era dell’uomo comune”, credeva e adoperava la stessa strategia. Durante gli anni ’30 del XIX secolo si fece simbolo dell’operoso neonato americano medio che lavorava con le mani e che si opponeva ad élite snob e alle loro colte riviste: i suoi social media erano decine di fogli di quello che oggi chiamiamo infotainment, ai tempi noti come “Penny Press”; il suo teorico era J. O’Sullivan, instancabile editorialista ed autore di bombe di informalità che mescolavano la schiettezza di T. Paine e il sentimentalismo di un Harriet Beecher Stowe, in un clima di paranoide opposizione. L’eredità immediata di Jackson fu l’egemonia del suo partito per altri 25 anni; il lascito nel medio periodo fu l’inasprirsi di alcuni presupposti che sfoceranno nella Guerra Civile del 1859.
La politica di massa statunitense è nata in questo modo: Trump sembra limitarsi ad incarnare un’eredità, per quanto pericolosa si riveli ogni volta. Tuttavia, è ancora più utile andare più a fondo, perché oltre ad una certa logica strategica si cela un’importante verità nell’idea di Bannon. Si tratta di qualcosa che le altre correnti politiche, su tutti i liberali, si ostinano tenacemente a non voler accettare e riconoscere. Mi riferisco alla scontata evidenza che, a prescindere dalla profilazione e dal controllo dei media, in politica la coerenza paga! E paga ancora di più quando sei tu a definire cosa sia coerente e cosa no. La coerenza di Trump sta nel suo abuso, nell’arbitrarie e discrezionale calarsi della sua scure. Non serve scomodare C. Schmitt per sapere come si individua chi ha davvero il potere. Senza tirare in ballo le Categorie del Politico, agli occhi delle persone il Sovrano è semplicemente colui che non ha nessuno al di sopra. Quando Trump minaccia le grandi università private, quelle Harvard e Yale che per noi sono più che altro ambientazioni delle serie televisive, di assoggettarsi al suo volere, pena la perdita dei fondi, quello che molte persone hanno visto è stata la necessaria tracotanza del potere. Alla domanda “perché veniamo governati?”, che molti statunitensi declinano in “perché subiamo il Governo Federale” Trump fornisce una risposta semplice ma elettrizzante: perché ha il potere, perché è il solo che può agire in modi per te impensabili. Cionondimeno, in questo sistema di arbitrio e decisione totale, anche tu, cittadino comune, hai un pezzettino di redine di questa bestia indomabile tra le mani: l’artificio della democrazia, dopotutto, è questo.
La radicalità del potere affascina, seduce e spinge gli esseri umani ad imbarcarsi in imprese. Si badi che non vi è nulla di negativo in ciò. In termini psicoanalitici la seduzione non è che riproposizione libidica dell’istinto di vita: viene difficile pensare a qualcosa di più vivo della politica, ossia l’organizzazione deliberata degli aggregati umani. La sinistra, e più in generale tutti noi, dovremmo smetterla di pensare che un culto dei deboli possa spingere qualcuno a seguirci. Si badi, a scanso di polemiche, che eradicare dalle nostre tendenze questo melenso culto del debole non ha nulla a che vedere con il riconoscimento delle debolezze: anzi, l’accettazione e l’impegno a superare i nostri limiti è una delle massime forme di coraggio. È necessaria la debolezza, il suo riconoscimento ed il suo superamento per creare uomini e donne forti. Il tracotante atteggiamento da bullo ai giardinetti di Trump fa presa principalmente per la mancanza di un’alternativa. Quando riconosceremo che gli eroi politici di ieri che rimpiangiamo amaramente erano più simili a Trump per caparbietà (per non dire carisma ahimè), che agli influencer che la sinistra liberista insegue; quando riconosceremo che empatia, morale e sapienza non possono non accompagnarsi a rigore ed un pizzico di decisionismo nel momento del bisogno, allora avremo fatto un piccolo ma importante passo in avanti per tornare a “sedurre” (nel senso migliore del termine) i cittadini.
Come disse uno di quelli a cui dovremmo guardare ancora oggi: «essere duri, senza mai perdere la tenerezza».