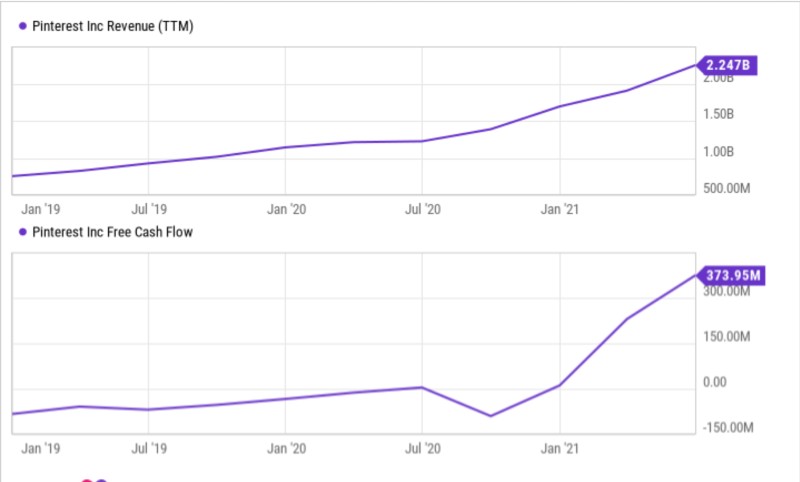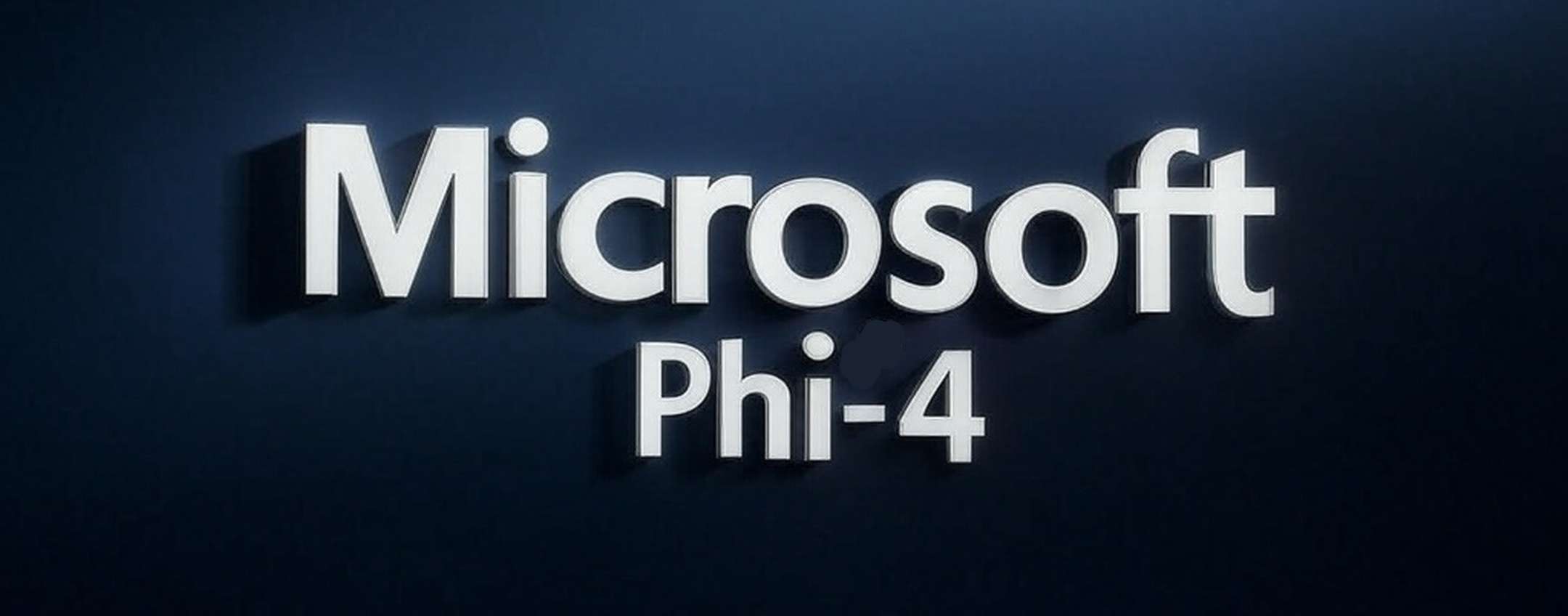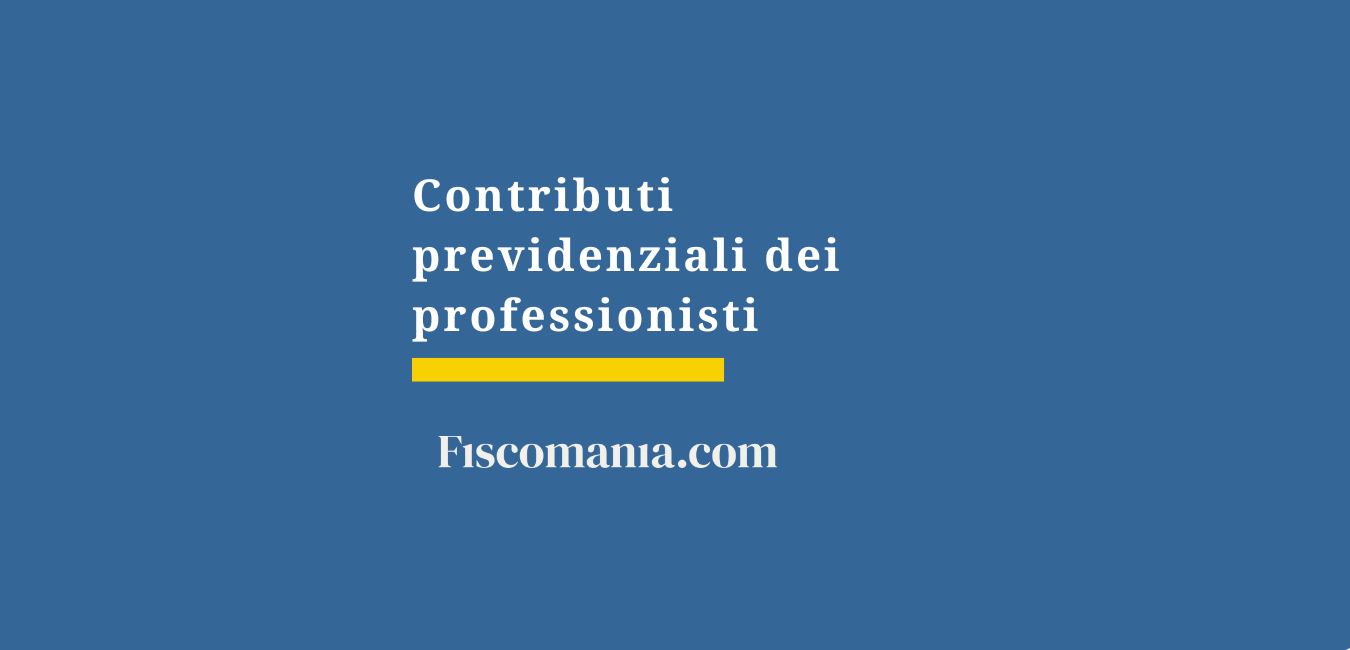Il romanzo visionario e scandaloso di Piero Salabè
Mortacci mia (La Nave di Teseo), a dispetto del titolo, è un romanzo estremamente letterario e metafisico, alla Bolaño, alla Cărtărescu. È un libro-mondo, uno dei più importanti del momento. Si tratta di più romanzi in uno. Piero Salabé firma un testo dove […]

Mortacci mia (La Nave di Teseo), a dispetto del titolo, è un romanzo estremamente letterario e metafisico, alla Bolaño, alla Cărtărescu. È un libro-mondo, uno dei più importanti del momento. Si tratta di più romanzi in uno. Piero Salabé firma un testo dove la complessità di una vicenda di reciproca incomprensione padre-figlio si trasforma nel corso della narrazione in una profonda comprensione che trabocca nello smarrimento di una somiglianza stupefacente.
Nel romanzo il rapporto con l’origine appare ambiguo: nel racconto il narratore Fabio, ad esempio, va in cerca del padre scomparso nell’ospedale abbandonato, ma non è chiaro se lo fa per riabbracciarlo o per liberarsi dalla sua ombra ingombrante. Nasciamo nel seno di una famiglia, restandone legati finché non giunge il momento del distacco; ci si rende conto di quanto sia difficile, forse impossibile, sciogliere quel legame profondo.
Fabio va a vivere all’estero, lasciando dietro di sé Roma, una città decadente, che non sembra offrirgli un futuro. Eppure, continua a tornarci, mosso da un’attrazione fatale. C’è una frase che lo ossessiona: A Roma si viene solo a morire. Ma di che morte si tratti non è certo: una morte reale o forse una morte simbolica per poter rinascere, liberi dal peso del passato irrisolto? È questo il tema del libro. Nel romanzo di formazione si narra il percorso di un eroe dall’infanzia all’adolescenza all’età adulta, in questo, invece, sembra prevalere la regressione, il non riuscire a diventare pienamente adulti. A un certo punto il narratore dice: La storia che segue si svolge nel tempo e ha un inizio e una fine, ma l’adulto che la racconta a tratti rimpicciolisce fino a tornare ragazzo, persino bambino. Il romanzo descrive la lotta fra sentimenti contrastanti, da un lato la voglia di liberarsi dall’ombra del padre e della città, dall’altro, invece, l’indulgere nostalgico.
Il padre, Pintor, è un medico, dedito alla ricerca, innamorato della scienza, che un giorno misteriosamente scompare, abbandonando i figli senza un perché. Il libro si configura come una ricerca da parte del figlio che si mette sulle tracce del padre scomparso. I riferimenti al legame tra medicina, alchimia, e simbologia del mistero fanno indubbiamente pensare che l’autore conosca bene la scrittura di Umberto Eco, e non solo, che sia questa una scrittura nata da un approfondimento della tradizione sapienziale, della Bibbia, del Vangelo di Giovanni. Ruoli che tornano a comporsi e a disfarsi. I pregiudizi del senso comune vengono smascherati. Quasi tutta la famiglia dà Pintor per disperso, ma Fabio e Lara (Aič), non smettono di cercarlo, non credendo alla notizia della sua morte. Alcuni diari del padre indirizzati ai figli spezzano e arricchiscono la narrazione. I figli si mettono sulle tracce del padre scomparso, prendendo in considerazione la possibilità che Pintor sia nascosto all’interno del labirinto del Minotauro rappresentato dal Policlinico, con l’intento di portare avanti i propri esperimenti. Quindi i due si avventurano in questi luoghi: laboratori sotterranei e padiglioni decaduti, in una Roma di miraggi, voci e visioni.
Tra i ricordi del figlio, una evocativa conversazione col padre sulla differenza tra medicina e scrittura, essendo la prima una scienza che dovrebbe rispettare il paziente, pertanto, con il giuramento di Ippocrate e il rispetto del segreto professionale, il medico coscienzioso non potrà mai permettersi di rivelare i segreti dei propri pazienti; al contrario, la scrittura lo fa per carpire il fondo oscuro di un’anima: l’esattezza è crudele, diceva Thomas Mann. Nonostante le differenze, il destino del padre si riflette nel figlio:
… tale padre, tale figlio, diversi come due gocce d’acqua, la fatica di tenerlo presente. Scrivere “io” o “lui”. Dire “io” per sua bocca, inventare, falsificare, fondersi, insinuarsi nella sua incomprensibilità. Il labirinto del figlio nel padre. “Lui”, invece, che sai di non conoscere – una dimostrazione di rispetto. Lui che resta lì, fumando senza parlare, più solo di te. Che forse come te vorrebbe che il suo “io” fosse il tuo, ma non lo dice, desiste come deve fare un buon padre. Lui è colui che sorride quando sente parlare di labirinto, ma basta aprire quell’unica porta che lui per errore di calcolo – o forse un errore d’anima – non ha chiuso a chiave. Il giorno che saprai usare solo “lui” sarai pronto per uscire. È ora di lasciare l’”io”, perché tu non saprai cosa abbia mai pensato. Eppure, verranno ricadute. Per non parlare della fastidiosissima interferenza del tu, un secondo io, più invadente, la tensione d’amore, la sua voglia di fusione, la sua enorme confusione…
L’amore del padre per il figlio, del figlio per il padre, è un labirinto, ma appunto anche un labirinto delle delizie, perché il primo amore (endogamico, famigliare), ci lega, trattiene, ma innerva anche i futuri (dis)amori. È impossibile esprimerlo, per questo il narratore lo avvicina accerchiandolo. Vi è un aspetto politico del romanzo, che non è solo un ritratto di Roma, non solo una storia di famiglia, ma anche un affresco di una certa epoca, rappresentata da figure ambivalenti. Possiamo scorgere sottotraccia anche la prospettiva sui marginali, il Libanese, il Libico e il Frocio di Frosinone.
Mi sono chiesta fin dal principio della lettura come mai un romanzo di tale levatura letteraria s’intitolasse Mortacci mia, ho trovato risposta a pagina 74:
Un anno dopo la morte della madre iniziarono i primi segni di offuscamento, le fughe. La chiamava, “Mamma, arrivo”, si leggeva sulle pareti di casa. “Mortacci mia.” Aveva noi, ma voleva la madre. Quelle parole scritte sui muri di casa qualcosa significano,
Nel corso del testo è sottolineato quanto la condizione di caduta morale del tempo presente si sia radicata. La figura del padre è a un certo punto tratteggiata come un uomo tendente al catastrofismo, per Pintor infatti non ci troviamo solo in un momento di decadenza scientifica, ma proprio alla fine dei tempi. Mancano i grandi maestri, per cui si è interrotta la catena della trasmissione del sapere. Figure come Gioacchino Ascoli o Paride Condorelli erano un tempo scolpite in busti che ornavano l’ingresso della IV clinica medica, ma i successori non furono all’altezza. Eppure, Fabio è assalito dal dubbio che dietro al rigore del padre si nascondesse un micidiale seduttore, che egli fosse talmente assetato di vita che, come Faust, voleva berla fino all’ultima goccia.
Leggendo questo libro si ritrovano concetti fondamentali della mitologia, della mistica, della psicoanalisi: alcuni passaggi di diario potrebbero ricordare la grande paura dell’uomo dei lupi: il corpo mangia il corpo e nell’immenso corpo del mondo si muore soli. D’altronde, l’intero libro oscilla tra psicoanalisi e noir, con uno sguardo a Goethe, un altro a Eco, infine Freud e Jung: La diagnosi è troppo chiara e perciò indicibile, invisibile a occhio nudo: la sua malattia – non sa vivere e non gli resta che vivere.
La prospettiva del narratore è regressiva, dato che quella era la sua infanzia, vorrebbe tornarci, anche se in realtà, e questo il romanzo lo fa capire, è un mondo assurdo e inumano. La nostalgia è appunto, un sentimento molto ambiguo, come dice la radice greca della parola, è il dolore del ritorno: si soffre lo stare via da casa. Il narratore è malato di nostalgia, come rivela nella prima pagina del romanzo: lui, che vive all’estero, continua a tornare nella sua città. La città era sempre là, immutata. Ancora una volta, l’aveva vinto, l’aveva fatto ritornare inerme, bambino. Il ritorno corrisponde a una sorta di regressione, qualcosa per cui il narratore prova vergogna. Spera allora che raccontando la sua storia, possa liberarsi finalmente dal sortilegio della nostalgia. Ecco che inizia a rievocare il suo passato nella città, nella casa, nella famiglia. Il romanzo descrive, dunque, una lotta contro la nostalgia: il bilancio è incerto, non è chiaro come finisca questa lotta che forse non produce che un ulteriore avvinghiamento nella nostalgia. Una soluzione ci sarebbe, forse, come emerge in una scena del romanzo, quando il narratore Fabio partecipa con la sorella Aič a un gioco, una strana mosca cieca: Vince chi riesce a uscire per primo dalla casa, a togliersi per sempre la benda, a non volere mai più tornare.
Ulteriori spunti di riflessione sono offerti dal rapporto fra il fratello e la sorella, Fabio e Aič, che cercano il padre scomparso. Nel romanzo, nel capitolo 18, si dice che sono gemelli siamesi con due teste e un solo cuore. È una metafora per indicare la complementarità. Sono, infatti, le uniche due persone nella famiglia a credere che il padre sia ancora vivo, mentre gli altri lo danno per morto, e nella loro ricerca hanno bisogno l’uno dell’altro. Forse più Fabio di Aič, nonostante lei sia più piccola. Fabio ha paura di dormire da solo nel buio, vuole che nel letto accanto ci sia Aič, che è ben più coraggiosa di lui. Sarà sempre la sorella la prima ad avventurarsi nei cunicoli, nei passaggi più infidi che conducono verso il padre: è lei la vera forza propulsiva della ricerca. Una forza irrazionale, passionale, non mediata da pensieri e calcoli; è più altruista, mossa da amore puro verso il padre, anche se il fratello critica il suo attaccamento che definisce morboso. Fabio, invece, è descritto come più egoista, persegue la ricerca per motivazioni proprie, fa esperimenti dell’anima, e la sorella intuisce che la sua fedeltà al padre non è assoluta come la sua. Nel testo affiora in certe scene oniriche anche un’attrazione di Fabio verso la sorella: fra cento sorelle quest’una / che mi mangia il cuore e io il suo, cita lo scrittore austriaco Robert Musil, che aveva sviluppato un concetto utopico di Geschwisterliebe, fusione fra fratello e sorella. È certo che Fabio e Aič si potrebbero interpretare come le due parti di un unico personaggio, dove il fratello rappresenta il maschile (animus) e la sorella il femminile (anima), ma non bastano tali categorie per cogliere il rapporto tra i due, caratterizzato da dolcezza, affetto, ma anche da un latente desiderio di sopraffazione da parte del fratello.
Vi sono, si diceva, anche personaggi secondari, che formano un secondo romanzo nel romanzo: Il Frocio di Frosinone, il Libico, il Libanese. Il Frocio è un personaggio che conosce a menadito i collegamenti segreti e i bassifondi di Roma. L’autore necessitava di una figura che aiutasse Fabio e Aič, a trovare un passaggio per l’ospedale chiuso. L’ha battezzato Il Frocio di Frosinone perché attratto da una particolare marginalità, qualcuno che conoscesse la città venendo da fuori. Il Frocio, si fa chiamare lui stesso così, non è, dunque, dispregiativo, tutto il contrario: è una figura profonda, che dopo una crisi ha fatto un radicale mutamento esistenziale. L’autore ama giocare con i nomi, così anche con quello del Libico, Abu Ridou, un biologo fuggito via mare dalla Libia in guerra, che all’Università di Roma trova solo un impiego in nero, nella stanza delle fotocopie. Abu Ridou, letto di fila, in spagnolo significa annoiato (aburrido). Il Libico è annoiato dalla vita, una noia esistenziale, perché approdato in Italia con la speranza di una vita migliore, si vede relegato, malgrado sia una persona di grande cultura. Sono destini comuni dei rifugiati, spesso vittime di pregiudizi. Come nel caso del Frocio, l’autore vuol dare dignità alle figure della marginalità. Il Libico, con il suo pessimismo radicale si oppone a una certa tendenza edificante del romanzo. L’intero testo celebra la ricerca di un senso umano, ma il Libico ci ricorda che questo senso forse non esiste, non è null’altro che una nostra costruzione consolatoria. Infine, il Libanese, da tecnico del suono, può aiutare Fabio a interpretare meglio i rumori dietro alle pareti del Policlinico abbandonato. Questa figura, in realtà un ebreo ungherese di nome Gluckstern, veniva chiamato il Libanese perché da giovane vagheggiava di un luogo, in Libano, dove pensava si trovasse la folgore bianca dell’Ognidove. È un mistico che crede nell’esistenza di una frequenza in cui tutti i suoni, del presente e del passato, convergano e dunque nulla, della vita, vada perduto.
È interessante notare come il padre sia insieme estremamente umano ma anche reificante, forse a causa della sua stessa ricerca, della rabbia, del desiderio di comprendere l’incomprensibile. Quando erano bambini, Pintor trattava persino i suoi figli come pazienti, diagnosticando, curando, tenendo d’occhio ogni minima variazione dei valori interni con analisi di vario genere, fonendoscopi, misurando le pulsazioni, i battiti, il respiro. L’amore di un padre narcisista, troppo preso dalla sua brama d’ascesa sociale – o di comprensione di una realtà che non gli è data – barattato con il controllo scientifico, medico, di ogni singola mutazione nell’esistenza biologica dei figli.
Cosa resta di quell’amore mancato? La sparizione, forse, da una vita che finisce per reclamare sempre il conto. La sparizione. La ricerca dei figli. L’esperimento in quanto vita, la vita in quanto esperimento che collima con la morte. Eppure, la morte, che è la grande ombra che incombe su questo romanzo, a partire dal titolo “Mortacci mia”, viene sconfitta proprio nella scrittura, nella capacità di ritrovare, rivivere il passato come presente. Ecco il merito di questa opera destinata a rimanere nel tempo – il cui scandalo è rappresentato, come in quello della fede, nel fatto di opporsi a tutte le mode, di recuperare l’essenza stessa della letteratura, perché ogni libro scritto con l’onestà intellettuale della vera letteratura non può far altro che scandalizzare in quanto accede mediatamente all’ignoto, in quanto dice l’indicibile, come qui accade, non solo nel contesto famigliare, ma in senso molto più ampio, nella disamina dei rapporti di potere.