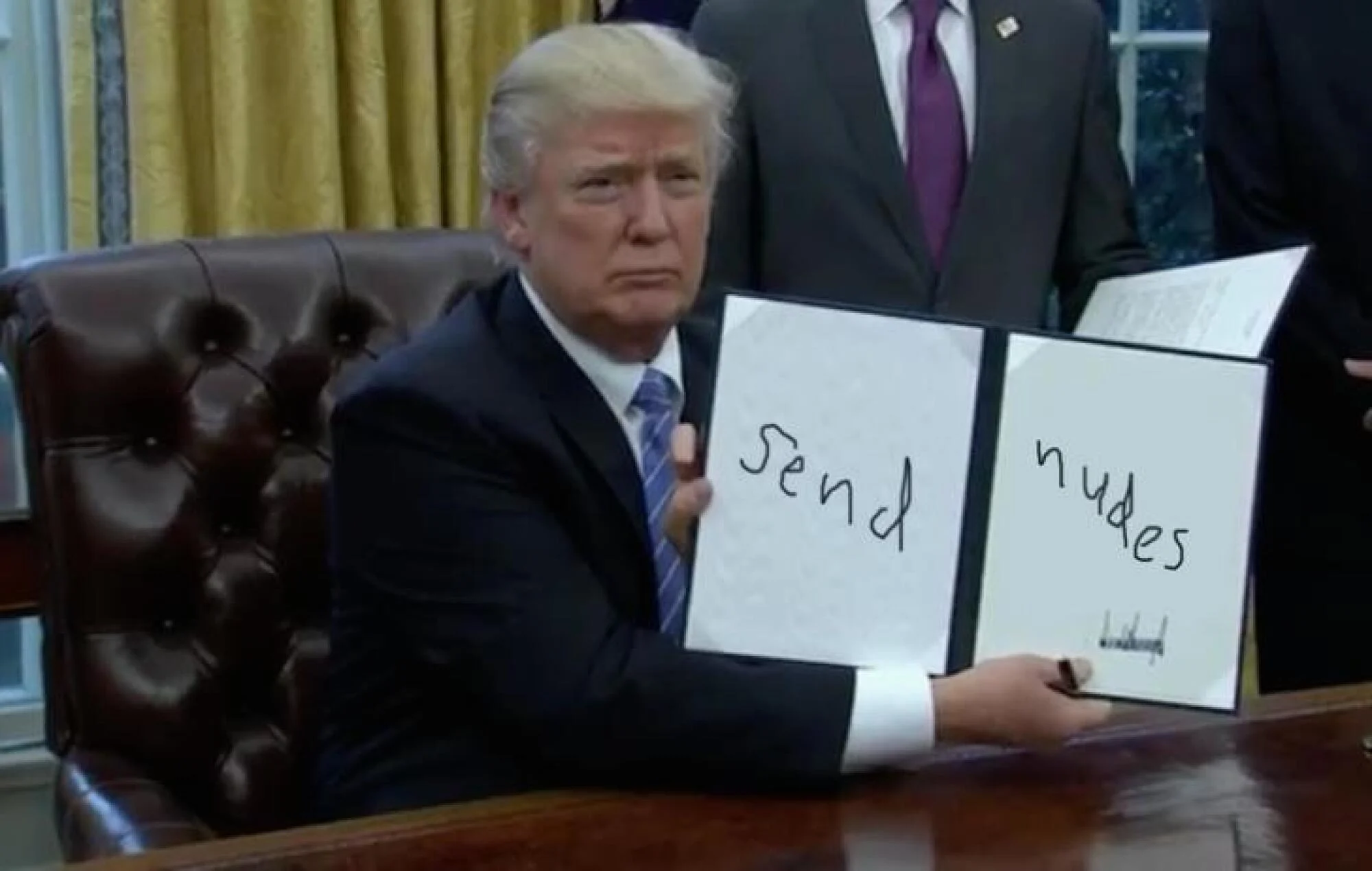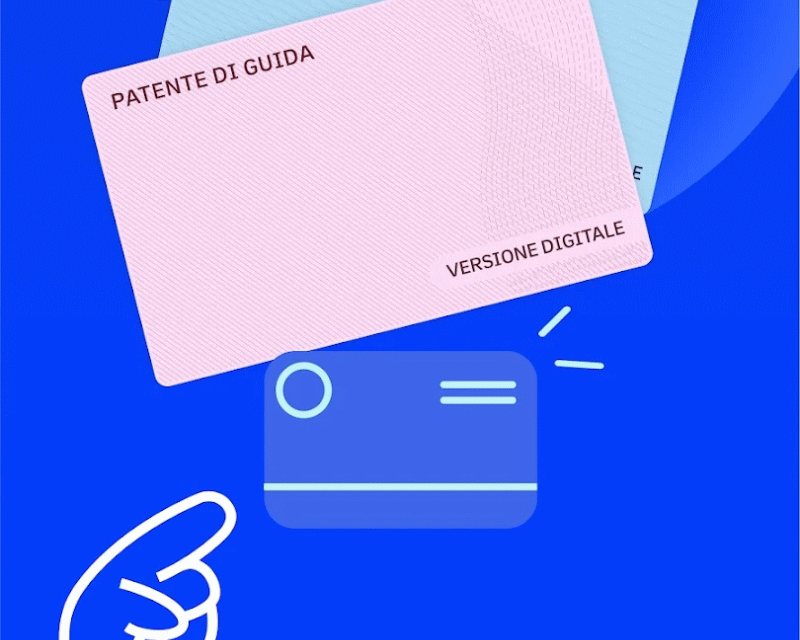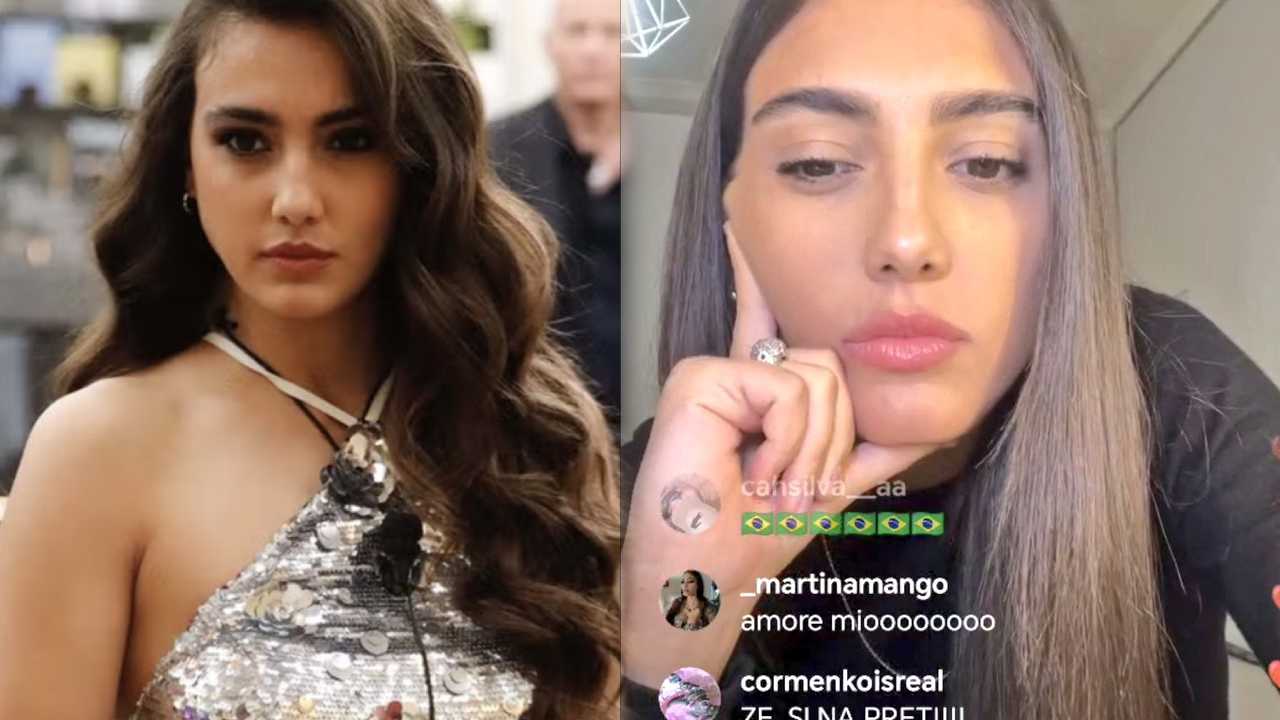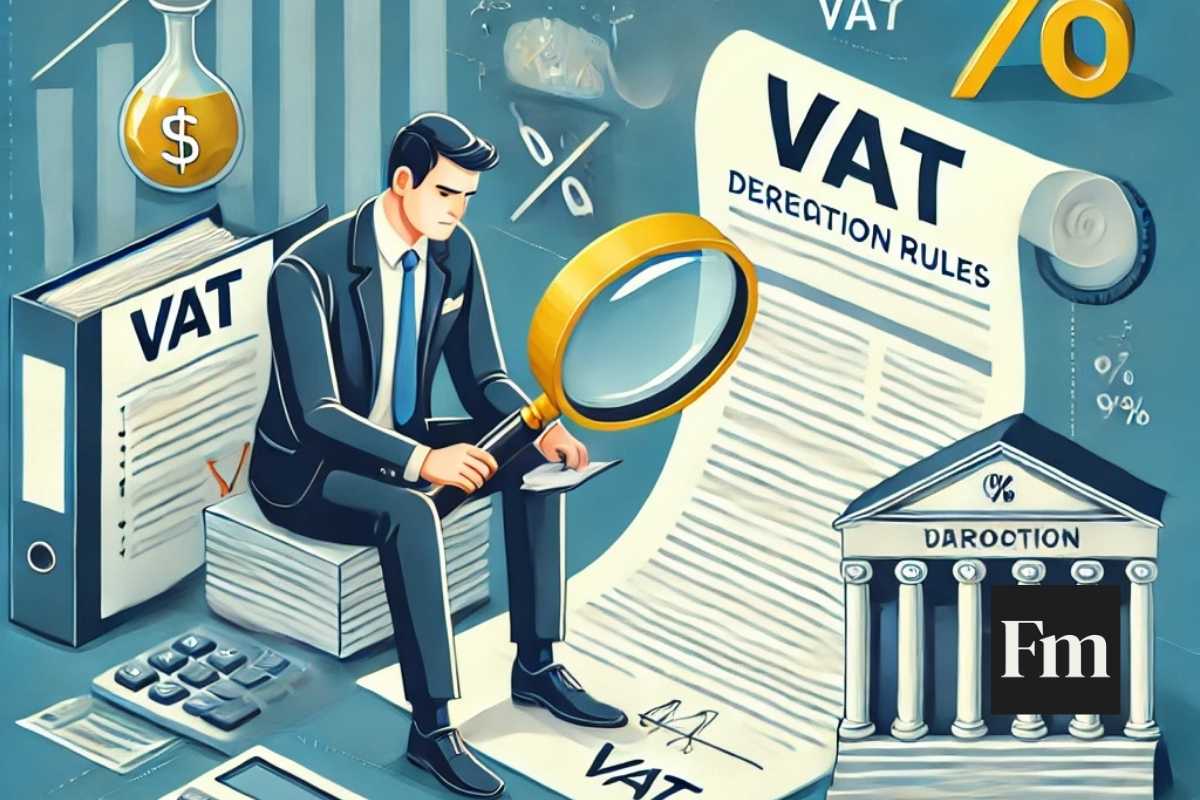Transumani ma sempre più fragili
Eccola la scuola, quella “croce o delizia” di qualsiasi amministrazione, a prescindere da luogo ed epoca. L’ultima notizia, infatti, in ordine di tempo, è la volontà del presidente Donald Trump […]

Eccola la scuola, quella “croce o delizia” di qualsiasi amministrazione, a prescindere da luogo ed epoca. L’ultima notizia, infatti, in ordine di tempo, è la volontà del presidente Donald Trump di sopprimere il Dipartimento dell’istruzione statunitense a livello centrale per trasferire le competenze ai singoli Stati e in tal modo lasciare ai singoli governatori locali la scelta se cancellare o meno le borse di studio con finanziamenti federali. In pratica, ogni Stato americano potrebbe avere la libertà di decidere quale tipo di istruzione garantire ai propri studenti.
Ma la mossa del tycoon ha tutt’altro che un’impostazione liberale: l’intento, infatti, è quello di combattere in modo capillare la cultura woke e la diffusione delle “teorie gender”, soprattutto in quelle aree direttamente governate dai Repubblicani, e contrastare così le politiche progressiste dei Democratici.
Tuttavia, sarebbe sbagliato vedere dietro questa scelta politica l’assenza di una strategia culturale di più largo respiro, all’interno del secondo mandato di Trump, soprattutto per quel che riguarda le prerogative in materia di formazione.
Perché, purtroppo, c’è una corrente di pensiero che si sta affermando in modo chiaro all’interno del variegato firmamento di pensatori che appoggia queste risoluzioni, con un crescendo di consensi che appare sempre più inquietante. Lo sostiene con valide argomentazioni Marco Bardazzi sul Foglio del 22 febbraio: “Un fenomeno culturale, originario della Silicon Valley, da tenere d’occhio è l’insieme delle idee post-umaniste che sembrano affascinare soprattutto Musk. Un mix di movimenti che hanno in comune l’idea che l’umanità sia in crisi e quindi vada potenziata (con l’intelligenza artificiale, per esempio) o trasferita altrove, magari su Marte con le navicelle di SpaceX. È un arcipelago variopinto, che viene riunito sotto l’acronimo di TESCREAL, che sta per Transumanesimo, Estropianesimo, Singolaritanismo, Cosmismo, Razionalismo, Altruismo Efficace e Lungotermismo”.
Dunque, dovremmo considerare il transumanesimo come un pensiero che voglia mettere in primo piano il fatto che l’attuale umanità sia una generazione in crisi e che quindi sia urgente attuare dei piani per riscattarla. Lo strumento principale per tale forma di “riscatto umano” non potrebbe essere altro che il ricorso alla tecnologia e all’intelligenza artificiale.
Questa, in sintesi, è la weltanschauung che anima la nuova classe dirigente attorno a Donald Trump, anche solo a partire dal primo intento di voler sostituire parzialmente il dollaro con le criptovalute, tanto per dirne una. E che prosegue in modo naturale con la destrutturazione dell’istruzione, lanciando un chiaro segnale di volontà di indottrinamento di future generazioni sempre più imperniate sul metaverso digitale.
Ma quanto questa ottica transumanistica sia realmente presente nelle aule degli studenti, non solo americane, e quanto possa davvero contribuire a una crescita psicologica e comportamentale dei nostri ragazzi, non solo nell‘acquisizione di nuove competenze o nuove conoscenze, questo non è dato sapersi.
Quello che invece appare certo è la delineazione di una fragilità sempre più diffusa, a più livelli: emotivo, etico, cognitivo e infine valoriale. Se dunque lo scopo è quello di configurare il futuro uomo vitruviano smaterializzato, adesso invece abbiamo a che fare soltanto con un’esilità di ciascun individuo che palesa la propria vulnerabilità proprio in quello che dovrebbe essere il più consistente punto di forza: lo strumento digitale e, per antonomasia, lo smartphone.
C’è un libro abbastanza recente di Juan Carlos De Martin dal titolo eloquente: Contro lo smartphone. Scrive l’autore: “Le macchine digitali sono sempre più fisicamente attaccate ai corpi degli umani, monitorando il loro stato organico e l’ambiente in cui sono immersi, influenzando il comportamento umano. Le macchine digitali modellano – come altre tecnologie in passato, ma probabilmente con più pervasività e più intimità – ciò che gli esseri umani percepiscono, pensano e sentono”.
Questa invasività delle macchine digitali oramai non ci sorprende più, neanche linguisticamente: non a caso da alcuni anni si usa sempre più di frequente il termine “nomofobia” per indicare la nostra dipendenza dai social, dalla rete e dunque dallo smartphone.
Resta il dato innegabile: senza gli smartphone o molti device che ci portiamo appresso, la nostra vita sarebbe migliore, sia in termini di sanità fisica sia per quel che riguarda la nostra psiche quotidiana.
Per quanto riguarda la sanità fisica appunto, c’è su Internazionale del 7 marzo 2025 un articolo di Christopher Bonnen (pubblicato in originale su Der Spiegel) che ci ricorda i nostri dolori a collo, braccia e schiena in seguito all’uso prolungato del telefono. Nello specifico, Bonner ha interpellato Patricia Tegtmeier, ricercatrice dell’Istituto federale tedesco per la sicurezza e la salute sul lavoro, che così ha risposto: “La nostra testa pesa circa cinque chili e può poggiarsi verticalmente sulla colonna vertebrale senza problemi. Ma non appena la incliniamo, il peso che deve sostenere il collo aumenta. A causa della gravità, con un’inclinazione di soli quindici gradi, cinque chili diventano circa dodici. A quarantacinque gradi, il peso supera i venti chili”.
Ma è il secondo aspetto, quello della psiche, che dovrebbe maggiormente interessarci.
Torniamo all’istruzione, perché da questo punto di vista è innegabile quanto la scuola sia oggi in continua e incessante trasformazione, soprattutto per l’influenza prima dei dispositivi, dell’Intelligenza Artificiale poi. Un’influenza che sta lasciando un’impronta indelebile. Tale trasformazione è così incisiva, come detto, da essere già cominciata da qualche decennio e da lasciare i suoi segni oggi di stagione in stagione. Facciamo un altro esempio: prendiamo i libri di testo degli ultimissimi anni, per non dire proprio dell’anno in corso. Una volta, le pagine scritte dei manuali di qualsiasi disciplina si presentavano caratterizzate da una lunga esposizione di parole che riempivano la pagina bianca, con l’aggiunta, al più, di qualche immagine a spezzare la monotonia espositiva. Oggi, invece, un manuale scolastico è molto di più, perché è decisamente più articolato e strutturato: è diventato un vero e proprio “ipertesto” in formato cartaceo, dove la parte scritta è limitata a una piccola sezione del foglio, intervallata da molteplici immagini, disegni, fumetti, link di richiamo, riquadri di tipo interattivo (cioè con un inevitabile collegamento alla rete) e sempre più di frequente i qr code, ovvero quei codici grafici (a quadretti bianchi e neri, per capirci) in grado di memorizzare le informazioni che possono poi essere decodificate in seconda istanza tramite lo smartphone.
Ciò ha essenzialmente la funzionalità di privilegiare un tipo di lettura che sappia fronteggiare una quantità esponenziale di dati, informazioni, immagini e pure suoni e filmati, anche se tale lettura si presenta, per ora, solo su base cartacea. Tale tipo di approccio è inoltre pensato per andare incontro allo studente in quanto pensato per spezzare la fluidità dell’esposizione verbale, favorendo una didattica “a salti”, come quella dello scorrimento (scrolling) delle pagine e delle immagini che solitamente si fa, in modo rapidissimo, con uno smartphone in mano.
Tuttavia, siamo certi che questa sia soltanto una fase di passaggio della didattica: avverrà prima o poi la scomparsa del cartaceo, a esclusivo vantaggio della dematerializzazione e dell’ingresso diretto nel metaverso dello studente, mediante la sostituzione di penne e fogli con le stringhe di algoritmi e con l’incessante flusso di dati attraverso ripetitori nell’etere o cavi di cablaggio a terra.
O di satelliti nello spazio, per ritornare a Musk, uno dei padri di questa nuova filosofia transumanistica.
A conferma di tutto questo, ci sono alcuni numeri che parlano chiaro. Un recente sondaggio di Review.org (vedi educazionedigitale.it) ha preso in considerazione un campione di mille americani di diverse età, negli anni 2022-2023. Tale sondaggio ha messo in luce come il 57% degli intervistati abbia esplicitamente dichiarato di sentirsi dipendente dall’uso del proprio cellulare. All’interno di questo campione, poi, il dato percentuale più alto è quello della Gen Z (28,57%) mentre, di tutti gli intervistati, ben l’89% ha ammesso «di controllare il proprio telefono entro i dieci minuti dal risveglio, con una crescita rispetto al 2022 pari ad oltre il 10%».
Lo sapevamo, alla fine, che il fenomeno è ormai diffusissimo – e incontrollabile – non solo tra i componenti delle nuove generazioni. Eppure, il dato americano è riproducibile anche nella nostra società e non si tratta soltanto di far alzare gli occhi dei nostri ragazzi, inchiodati sugli schermi.
Si tratta di un fenomeno più profondo, che nasconde un malessere che la scuola fa sempre più fatica ad arginare: la crescita di ansia delle nuove generazioni. Quella stessa inquietudine che, a mio giudizio, oggi è occultata dietro i banchi dell’istruzione dell’Italia “millennial”.
A tal proposito ha destato molto interesse un saggio uscito l’anno scorso intitolato La generazione ansiosa. L’autore è uno psicologo americano di nome Jonathan Haidt che si è soffermato in particolare sul concetto di “riconfigurazione dell’infanzia” che stanno vivendo tutti i giovani del Terzo millennio, causata dalla crescita vissuta assieme allo smartphone. Se per Haidt le prime conseguenze immediate di questa formazione umano-tecnologica si presentano sotto forma di disturbi legati all’ansia, privazione del sonno, frammentarietà dell’attenzione e solitudine soggettiva, a lungo termine emergono però conseguenze di ben più grave entità: “Una vita basata sul telefono in genere attira le persone verso il basso. Cambia il modo in cui pensiamo, percepiamo, giudichiamo e ci mettiamo in relazione con gli altri. È incompatibile con molti dei comportamenti che praticano le comunità religiose e spirituali, alcuni dei quali invece favoriscono la felicità, il benessere, la fiducia e la coesione del gruppo”.
Rispetto, dunque, al superuomo transumanistico l’individuo dei nostri tempi è un essere che ha perso anche il senso del sacro e della spiritualità. Ma Haidt ci lascia anche alcuni consigli da convertire in regole, per cambiare l’attuale stato delle cose, soprattutto tra i giovani: 1. niente smartphone prima delle scuole superiori; 2. niente social prima dei sedici anni; 3. a scuola senza cellulare; 4. più gioco (senza supervisione genitoriale) e più indipendenza.
Poche ma buone regole sensate, altroché l’incomprensibile TESCREAL di cui abbiamo parlato sopra. Ma è ancora possibile oggi applicare queste regole? Qual è il tratto caratterizzante oggi dei giovani?
La risposta sembra darcela proprio lo scrittore statunitense Stephen Amidon che è intervenuto venerdì 7 marzo alla manifestazione “Lèggère trasformazioni”, la stagione dei diciotto anni della Fondazione Circolo dei lettori, in collaborazione con la Scuola Holden (traduzione apparsa come articolo sul Domani martedì 11 marzo): “La convinzione di poter cambiare il mondo non è più così diffusa tra i giovani americani. Come vi dirà qualsiasi insegnante, la loro deliberata ignoranza riguardo al passato della nazione lascia sgomenti. Stanno creando un vocabolario, una cultura e una tecnologia tutte loro per esprimere il nichilismo americano, che permette di vivere in una sorta di perpetuo qui-e-ora. Questo eterno presente si riflette nella tecnologia di questa generazione, poiché le introduzioni dell’iPhone nel 2007 e di Chat Gpt nel 2022 continuano a cambiare il modo in cui si formano i giovani cervelli”.