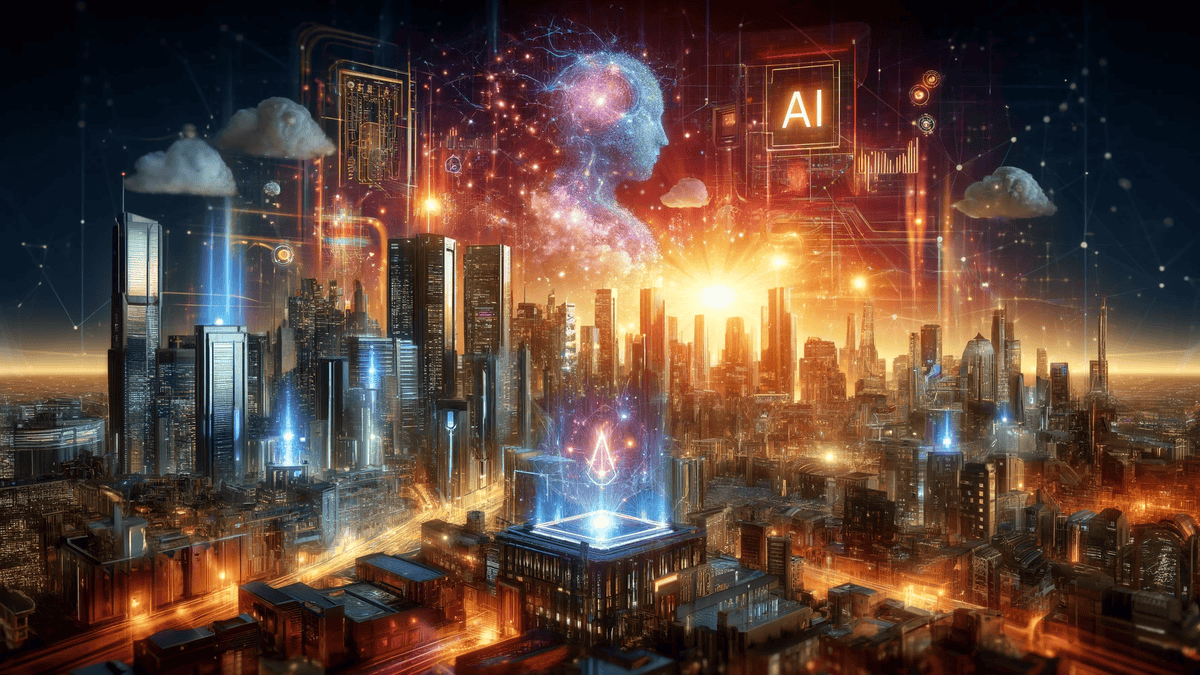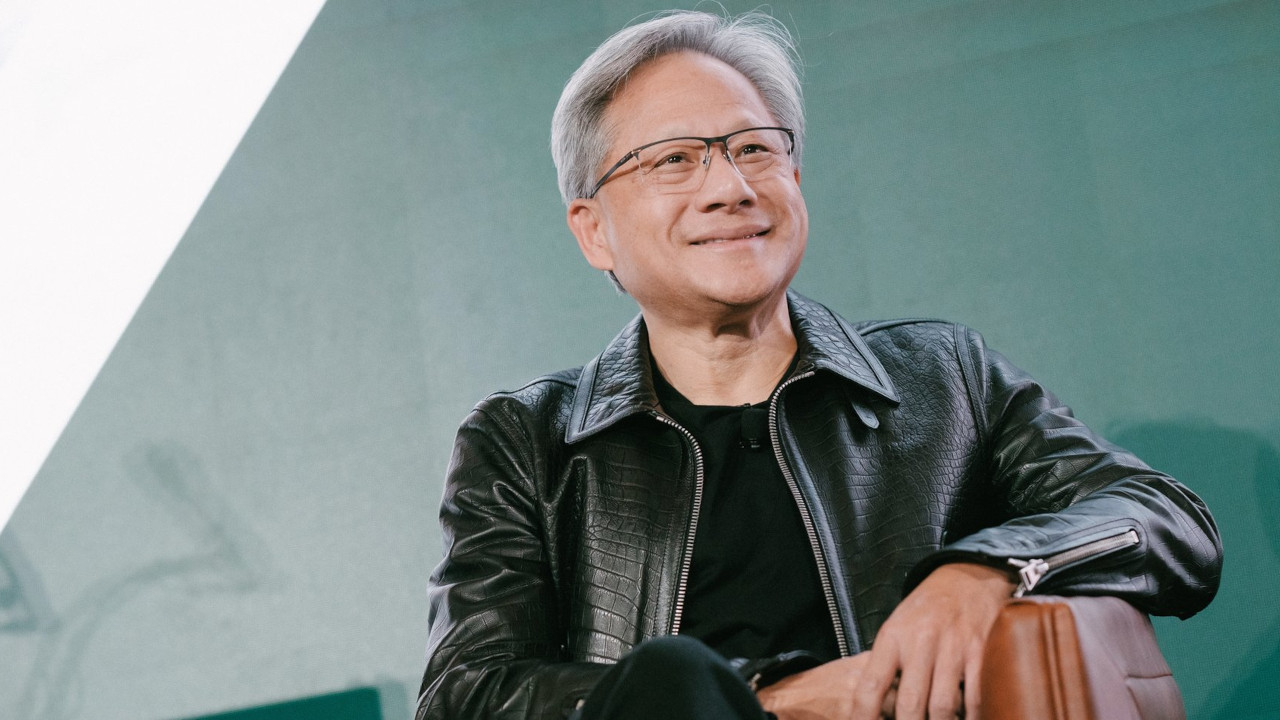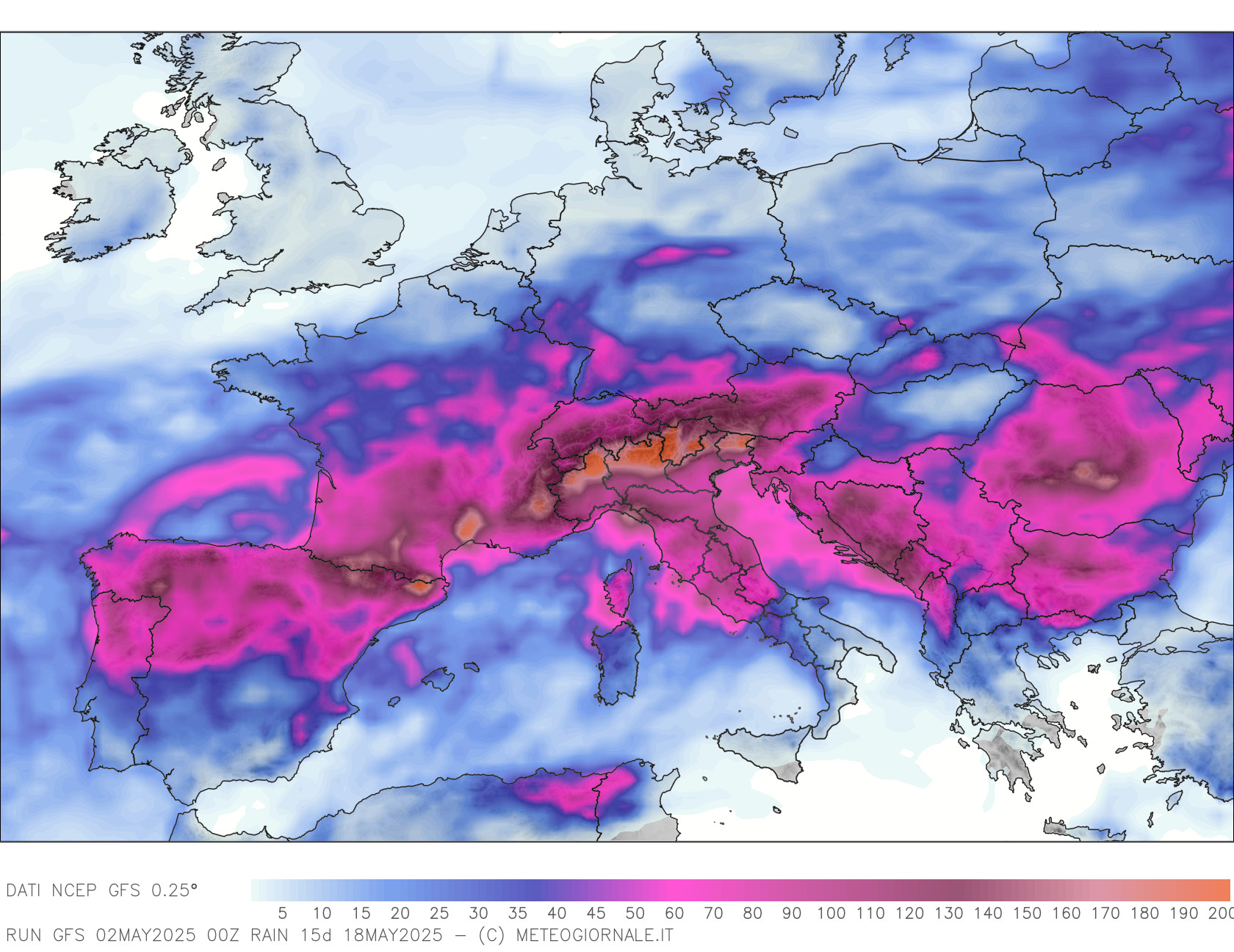Un problema di qualità: le polemiche woke non spiegano gli insuccessi Disney
Dalle polemiche contro J.K. Rowling alle vere ragioni dietro i flop dei più recenti remake in carne e ossa. La parola a Marina Pierri: “Il pubblico vuole prodotti nuovi, non semplici operazioni cosmetiche”

Firenze, 30 aprile 2025 – Harry Potter diventa una serie tv per Hbo - data d’uscita fine del 2026 o, molto probabilmente, inizio del 2027-, ed è già polemica. Tra i fan in rete, ancora prima
dell’ufficializzazione del cast, giravano dei “rumors”, che riguardavano principalmente la scelta
dell’attore che interpreterà Severus Piton (nel film l’indimenticabile Alan Rickman). Il 14 aprile si è
avuta la conferma: sarà Paapa Essiedu, 34enne britannico di origini ghanesi, a vestire i panni
dell’inquietante professore di Hogwarts. Le titubanze sul nuovo Piton riguarderebbero il fatto che
l’attore scelto è black, quando l’ “originale” viene descritto nei romanzi come un uomo pallido,
addirittura giallognolo. Apparentemente dunque non si tratterebbe di perplessità dettate dal
razzismo, ma da ragioni di fedeltà alla saga, alle sue icone e ai ricordi. Di contro, c’è chi ha già
individuato nella scelta di un protagonista nero un necessario “segnale di inclusione”, a fronte delle critiche piovute su J.K. Rowling in seguito alle sue esternazioni contro le persone transgender. La scrittrice infatti si è battuta affinché passasse una legge nel Regno Unito che stabilisce - per l’applicazione dell’Equality Act – che la definizione giuridica di “donna” vale solo per le persone biologicamente di sesso femminile e quindi non le donne trans, neanche quelle con documenti femminili. Negli ultimi giorni Rowling è stata fortemente criticata per le sue posizioni da Pedro Pascal, star della serie The last of Us, che l’ha definita «un’odiosa perdente». L’attore, attivista per i diritti LGBTQ+, ha una sorella transgender che lo accompagna spesso sul red carpet e a febbraio aveva dichiarato su Instagram che «un mondo senza persone trans non è mai esistito e mai esiterà». Ha poi aggiunto: «Non riesco a pensare a niente di più vile, piccolo e patetico che terrorizzare la più piccola e vulnerabile comunità di persone che non vogliono nulla da te, tranne il diritto di esistere». Per questo, indignato dagli atteggiamenti della creatrice del maghetto, ha invitato il pubblico a boicottare qualunque prodotto che faccia parte della saga firmata Rowling.
Alcuni membri del cast della nuova serie di Harry Potter hanno subito attacchi online in risposta al
loro coinvolgimento. Tuttavia, tutti e tre gli attori chiave finora rivelati hanno anche interpretato ruoli LGBTQ+ di riferimento. John Lithgow, che interpreterà Albus Silente, ha ottenuto molti consensi per la sua interpretazione di una donna transgender in Il mondo secondo Garp del 1982. Janet McTeer, che interpreta la professoressa McGranitt, ha interpretato un uomo trans in Albert Nobbs del 2011, mentre lo stesso Paapa Essiedu ha spesso interpretato ruoli queer, in particolare in I May Destroy You (2020) e nel cortometraggio Femme (2023), in cui interpretava un drag performer gay.
Non è la prima volta che scelte di cast ritenute “non adeguate” dal pubblico fanno scaturire grandi
polemiche nel web. Tra l’altro anche Harry Potter e la maledizione dell’erede - dramma teatrale del2016, ambientato diciannove anni dopo il romanzo Harry Potter e i doni della Morte (l’ultimo della saga di Rowling) – aveva avuto problemi analoghi, facendo scaturire discussioni animose tra fan e non. La ragione? L’attrice che interpretava Hermione, ovvero Noma Dumezweni, è nera.
Ma il caso emblematico più recente è quello del remake Disney di Biancaneve.
Il 21 marzo è infatti uscito nelle sale cinematografiche italiane Snow White, il live action di
Biancaneve e i sette nani diretto da Marc Webb. Controversie e contestazioni hanno
accompagnato il film dal 2020, anno in cui sarebbero dovute cominciare le riprese, poi posticipate, a causa di problemi dovuti alla pandemia. Bollata come la Biancaneve «woke» e «politically correct», è Rachel Zegler, attrice di origini latinoamericane, a interpretare la principessa Disney “dalla pelle bianca come la neve”, che in questa nuova versione non cerca l’amore, ma sogna – come affermato da Zegler - di “diventare la leader che sa di poter essere”. Una versione della fiaba dei fratelli Grimm a prima vista più inclusiva e femminista. Queste scelte hanno scatenato reazioni negative da parte dei critici conservatori, che hanno ritenuto inadatta Zegler per il ruolo di protagonista e non hanno approvato la svolta moderna della trama, sostenendo, come nel caso dello scrittore e opinionista Ben Shapiro, di voler trasformare il film in una storia da “girl boss”.
Un’accusa simile coinvolse, nel 2023, l’uscita del live action de La Sirenetta di Rob Marshall.
Anche in questo caso, le lamentele principali erano rivolte all’interprete della protagonista Ariel,
ovvero l’attrice e cantante afroamericana Halle Bailey.
Tanto Snow White quanto La Sirenetta, sono stati un disastro (totale nel primo caso, mezzo nel
secondo) al box office. L’insuccesso di Biancaneve ha peraltro indotto la Disney a sospendere le
riprese di quello che sarebbe dovuto essere il prossimo remake (Rapunzel). E molto rumore fanno le voci di chi sostiene che le cause di questi flop siano da ricollegarsi alle “accuse woke” mosse dal pubblico.
Ma è davvero così? Una risposta affermativa risulterebbe semplicistica. E per quanto versioni di
questo tipo piacciano molto, poiché semplici da comprendere e facili da accettare, riducono il
mondo a una bidimensionalità che non gli è propria.
Per fare chiarezza e ricostruire le reali ragioni dietro gli insuccessi di questi prodotti
cinematografici, dobbiamo prima di tutto capire che cosa si intende per “woke” e di conseguenza
per “accusa woke”.
Che cos’è il "woke”?
Come affermato dalla sociolinguista Vera Gheno in un episodio (69) del suo podcast Amare parole, dal titolo Ma cosa diavolo è il woke?, «il termine “woke” viene spesso usato senza avere idea di che cosa significhi» ed è peraltro una parola che non si è mai davvero affermata nel dibattito italiano. Insieme ad essa solitamente si fa ricorso ad altre espressioni che rientrano più meno nello stesso campo semantico, come “politicamente corretto” oppure “cancel culture”. Negli stessi Stati Uniti l’aggettivo “woke” e il sostantivo “wokeness” sono parole sempre meno usate, se non con una chiara connotazione dispregiativa. “Woke” deriva dallo storpiamento vernacolare afroamericano dell’inglese “awake” (sveglio) e non è davvero traducibile in italiano: vuol dire qualcosa come “consapevole”. Originariamente indicava l’atteggiamento di chi presta attenzione alle ingiustizie sociali, legate principalmente a questioni di genere e di etnia, solidarizzando ed eventualmente impegnandosi ad aiutare chi le subisce. La sua diffusione risale principalmente all’ambito delle proteste di Black Lives Matter, per esprimere la consapevolezza su una serie di questioni e problemi legati al razzismo e al sessismo sistemico – ovvero radicati nelle istituzioni e nelle dinamiche sociali – della società americana (e per estensione di quelle occidentali). Si definivano “woke” per esempio le persone (perlopiù della cosiddetta generazione dei “millennial”, i nati tra gli anni Ottanta e l’inizio dei Novanta) che facevano attivismo in piazza e sui social network. Coloro che partecipavano alle proteste antirazziste o alle marce per i diritti delle donne e chi sensibilizzava l’opinione pubblica sull’importanza di utilizzare un linguaggio rispettoso e ampio per riferirsi alle minoranze.
Di recente però, “woke” è diventata sempre meno una parola rivendicata dalle persone che
teoricamente dovrebbe descrivere e sempre più usata dai loro critici, spesso conservatori
americani, per indicare quella che considerano una pericolosa tendenza della sinistra (dei
progressisti e più in generale dei Democratici). Con “woke” la destra americana intende tutto quello che identifica come un atteggiamento di dogmatismo censorio, applicato nei confronti delle parole e delle idee che vanno contro le più moderne sensibilità sulle questioni delle minoranze e dei diritti civili.
È il caso delle accuse, prima menzionate, a Rachel Zegler, la cosiddetta «Biancaneve woke»; e
«woke» non solo per il colore della sua pelle, ma anche per il tentativo di dare alla principessa una veste più moderna. Sotto l’etichetta di “accusa woke” rientrano anche quelle rivolte a Halle Bailey (Ariel) e a Paapa Essiedu (futuro Piton) e Noma Dumezweni (Hermione nella Maledizione
dell’erede).
Come sostenuto dalla scrittrice e narratologa Marina Pierri - che tra le varie cose si occupa anche di analisi dei media - ricondurre i problemi dei casi di flop al cinema a “motivazioni woke” è del tutto errato, in quanto «la cultura woke è sentiment». Cioè, spiega Pierri: «non si avranno mai dati precisi, né una quantificazione completa, che dimostrino esattamente quante persone non sono andate a vedere quei film per quei motivi lì. Io credo che un dibattito intorno all’audiovisivo, generalmente, sarebbe meglio se lasciasse completamente perdere tutti i discorsi che riguardano
lo spauracchio della cultura woke. Che alla fine è uno spettro che viene evocato a piacimento per
nascondere la bassa qualità di un prodotto. Oppure quando c’è la necessità di giustificarne uno,
che comunque non ha convinto il pubblico».
Inclusione: quale e perché?
Sempre Pierri propone una definizione di inclusione molto nitida: «Inclusione è pluralità. Una
parola molto spesso usata a sproposito, che finisce per non significare più niente. Il motivo per cui
si usa è perché esiste un linguaggio che rappresenta una voce egemone, identificabile soprattutto
con quella bianca, o meglio dell’uomo bianco eterosessuale. Lavorare con qualcosa che sia
inclusivo significa invece avere uno sguardo che contempli il più possibile altre visioni, non
egemoni. La presenza femminile, quella di persone razzializzate, di persone con disabilità, o con
corpi generalmente non conformi».
E che cosa significa questa “presenza di”? «Significa – specifica sempre la scrittrice - la capacità
nel cinema e in generale nell’audiovisivo, di tentare di avere voci non egemoni, ma che stanno ai
margini. È chiaro che dire, per esempio, che le donne siano ai margini è un paradosso –
considerando che costituiscono metà (se non più) della popolazione - ma questo è un paradosso
che conosciamo molto bene».
La necessità di un approccio più inclusivo nel mondo del cinema dunque deriva dall’esigenza di
dare spazio a quelli che la scrittrice Kübra Gümüşay definirebbe come i “nominati”. Nel suo
romanzo Lingua e essere, l’autrice immagina la lingua come un museo straordinariamente grande, nel quale viene spiegato il mondo che c’è fuori. Ci sono oggetti, esseri viventi e piante da tutti i continenti, ma anche idee e teorie, pensieri e sentimenti, fantasie e sogni. Di un passato molto lontano, ma anche estremamente attuali. In questo museo, ci sono due categorie di essere umani: i nominati e gli innominati. Gli innominati, ovvero coloro che non hanno ricevuto un nome, sono gli esseri umani la cui esistenza non viene analizzata. Sono lo standard, la norma, il metro di paragone. Sono loro che curano l’esposizione del museo e sono anche coloro che esercitano il
potere di denominare. Cioè sono loro che attribuiscono le etichette a tutto ciò che è diverso da loro e, gestendo il museo, decidono quanto spazio lasciare al diverso. Quanta rappresentanza,
potremmo dire.
Includere significa dunque creare uno spazio ampio, in cui voci non egemoni abbiano la possibilità di essere sentite. In un campo come quello dell’audiovisivo, questo si traduce nella rappresentanza di coloro che sono e si sentono meno rappresentati. E che hanno il bisogno e il diritto di esserlo.
Ma i film oggetto della nostra analisi sono davvero così inclusivi?
Anche questa volta la risposta è negativa. Sempre la narratologa Marina Pierri spiega che quando facciamo riferimento ai remake live-action della Disney, stiamo parlando di oggetti culturali estremamente esposti al flop. Tutti i rifacimenti in carne e ossa sono storie già ampiamente assorbite dall’immaginario collettivo. Questi oggetti culturali sono delle rimasticazioni, non sono dei prodotti nuovi. Sono solo dei prodotti in cui vengono introdotte delle novità al fine di renderli accattivanti a un pubblico, che si immagina sia un pubblico che spende. Ogni volta viene ipotizzato quello che il pubblico potrebbe volere. «Ma – afferma la scrittrice - se ci fosse una certezza assoluta di quello che il pubblico desidera, sugli scaffali delle librerie ci sarebbero solo best seller. E tutti i film sarebbero campioni al botteghino». Quello che si può fare è ragionare ogni volta su quello che potrebbe piacere a un pubblico. Ma questa non è una scienza esatta.
«Se Disney ha fatto un investimento – sottolinea Pierri -, ha fatto un’operazione di novità su
copioni noti e già rimasticati. Non è una questione di Biancaneve nera, o Sirenetta nera. La questione è che abbiamo a che fare con operazioni di rimasticazione, che non aggiungono niente
di nuovo se non la cosmesi. Stiamo parlando di semplici operazioni cosmetiche».
Se dunque questi film non sono nemmeno così inclusivi come vogliono farci credere, allora le
accuse “woke” o di fedeltà alla trama lasciano il tempo che trovano. E le “polemiche woke”, caduta la maschera, si rivelano spesso essere tentativi (anche mal riusciti) di mistificazione di razzismo.
Ma al di la di questo, la cosa più importante è che non avendo dati certi su quanti hanno boicottato i film perché troppo “woke” o inclusivi (e quindi di sinistra), non si può con sicurezza affermare che queste siano le motivazioni degli insuccessi al botteghino.
Un problema di qualità
«Ci vuole un po’ di materialismo quando ci si occupa di pluralità dello sguardo, bisogna impugnare un discorso sul tema della qualità, se no si rischia di essere sempre attaccabili». Questo ha affermato Pierri per introdurre le ragioni del flop dei remake. Quando c’è un investimento importante su un prodotto che poi non funziona, è ovvio che si vada a guardare dove si è fallito. «Qui il punto è che pochi sono andati a vedere questi film perché sono poco interessanti», ha dichiarato la scrittrice.
La grande assente sembra quindi essere la qualità dell’opera. Il problema di questi prodotti è che
non aggiungono niente di nuovo, se non una cosmesi. Mentre la qualità dell’opera si ottiene
attraverso vari fattori, tra cui una buona regia e sceneggiatura che deve, oggi più che mai, saper
guardare alla pluralità. Se l’industria dell’audiovisivo fa dei grandi investimenti su film come i
remake, allora non può limitarsi a operazioni essenzialmente solo cosmetiche e sperare che
attraggano il pubblico. «Se vuoi scrivere una Biancaneve che sia davvero femminista – afferma
Pierri - la fai scrivere per esempio a Emerald Fennel (nota per aver co-scritto la serie di successo
Killing Eve) o a Diablo Cody (premio Oscar per la miglior sceneggiatura nel 2008 con il film Juno).
A voci riconosciute, che sappiano guardare dentro l’universo femminile».
La qualità dell’audiovisivo passa attraverso quella della scrittura. E dalla valenza di questa,
«all’esperienza immediata del corpo nel mondo, che idealmente viene costruita a partire
dall’esperienza di autori oppure avvalendosi di consulenti». La qualità discende da uno sguardo
plurale e maturo sulla storia che viene raccontata. Se in ballo c’è sempre la stessa storia, la cui
unica differenza è che i protagonisti hanno la pelle di un colore diverso, allora ne deriva un
prodotto di scarsa qualità. «Che non è di richiamo per l’immaginario collettivo contemporaneo»,
chiosa Pierri.
Un ulteriore fattore che contribuisce alla buona riuscita di un’opera è anche «la scelta di un casting che generi un bel clima nel set», dove ci sia serenità e tranquillità. Nel caso del remake di Snow White il set non era sereno: Zegler è pro-Palestina mentre l’israeliana Gal Gadot (la ReginaCattiva) sostiene posizione sioniste. E le due attrici sono state al centro di voci su liti dietro le quinte, proseguite a colpi di post su X in riferimento alle loro opinioni opposte sul conflitto israelo-palestinese. «E a risentirne, anche in questo caso, è stata la qualità», conclude Pierri.
A partire dal loro inizio dunque, l’operazione dei remake Disney è un’operazione che è «un po’
come un tavolo che ha una gamba più corta: c’è sempre qualcosa che traballa». Ma è la qualità
dell’opera il reale problema e la vera motivazione degli insuccessi. Il terreno su cui si gioca la
partita è tutto qui.