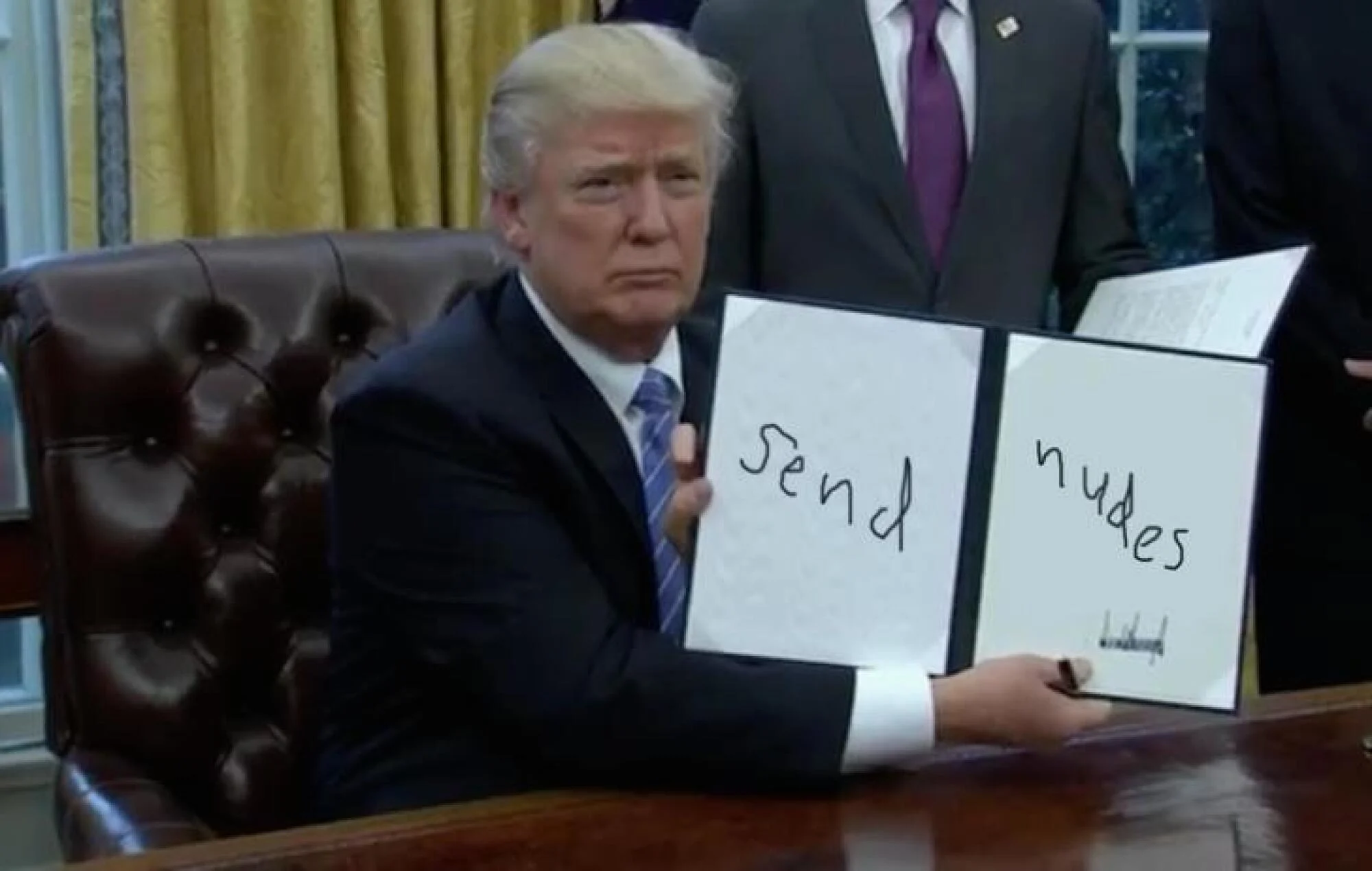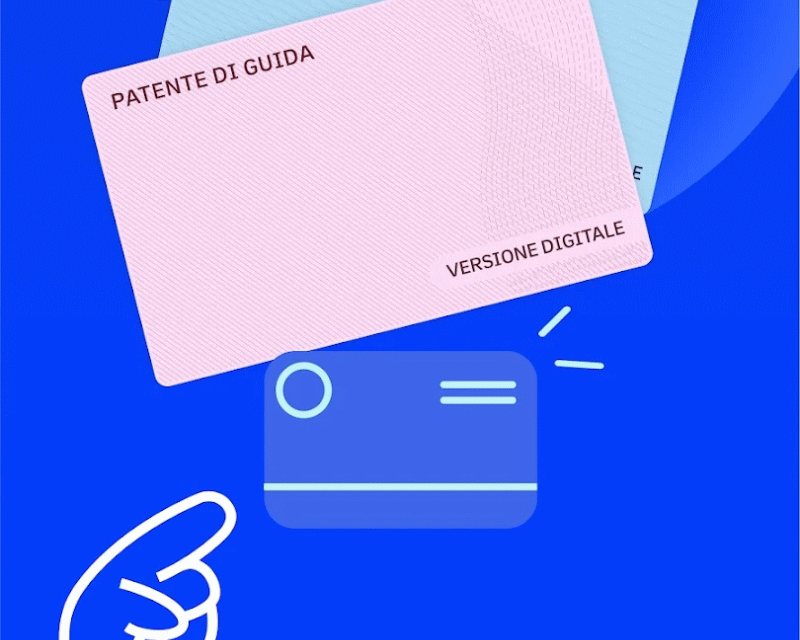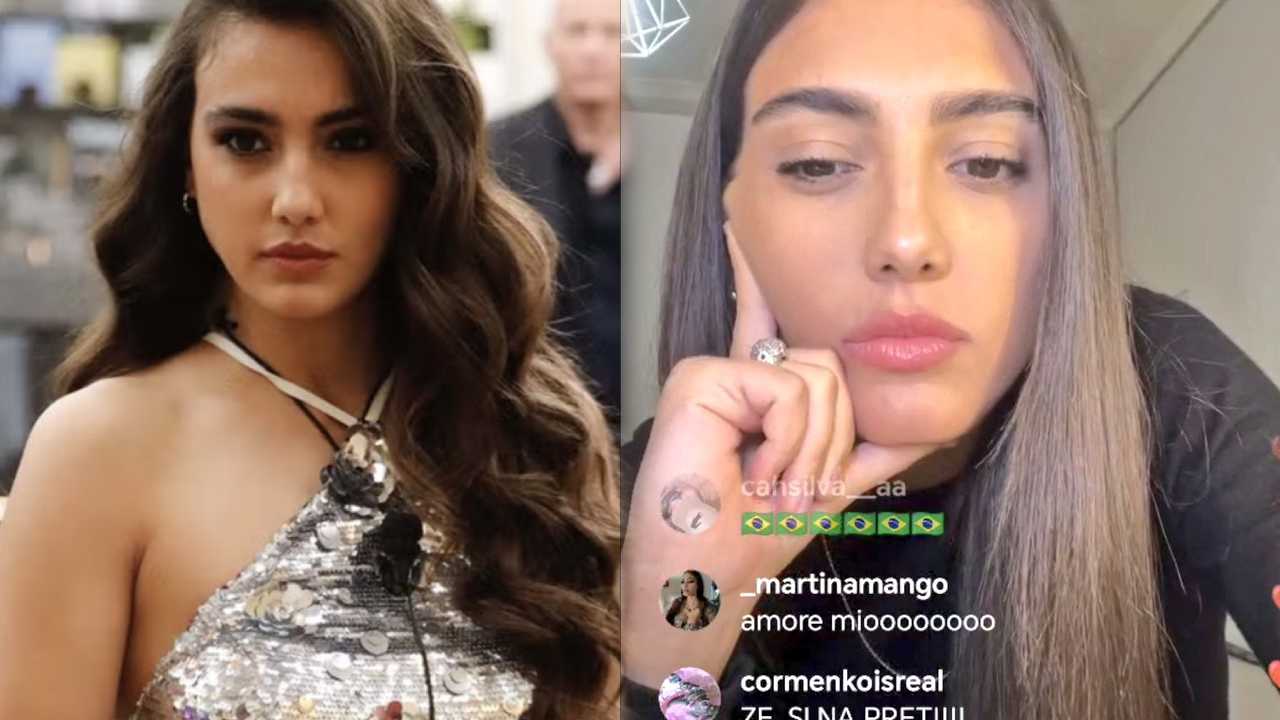Tutte le sfide del ddl nucleare
Il disegno di legge per il rilancio del nucleare in Italia: una primissima analisi giuridica. L'intervento di Francesco Piron, partner di CBA Studio legale e tributario.

Il disegno di legge per il rilancio del nucleare in Italia: una primissima analisi giuridica. L’intervento di Francesco Piron, partner di CBA Studio legale e tributario
L’introduzione di un nuovo disegno di legge per il rilancio del nucleare in Italia rappresenta una svolta epocale, soprattutto se si considera il contesto storico e normativo del nostro Paese. Dopo decenni di scetticismo e di un forte orientamento verso fonti rinnovabili, l’adozione di un framework normativo specifico per il nucleare si configura come una risposta strategica alla crescente domanda di energia sostenibile e alla necessità di diversificare il mix energetico nazionale.
Contesto storico e normativo
Il panorama italiano in tema di energia nucleare è stato segnato da eventi storici di grande rilevanza, tra cui il referendum del 1987 che portò alla chiusura delle centrali nucleari e a una marcata polarizzazione dell’opinione pubblica.
Tuttavia, l’inasprirsi della crisi energetica globale e la necessità di rispettare gli impegni climatici imposti dall’UE hanno contribuito a rinnovare l’interesse verso il nucleare, ritenuto capace di garantire una produzione energetica stabile e a basso impatto di emissioni carboniche. Questo nuovo DDL si inserisce in un quadro normativo volto ad armonizzare la disciplina italiana con le direttive comunitarie in materia di sicurezza nucleare e sostenibilità ambientale.
I punti chiave del Disegno di Legge sul nucleare
Gli interventi normativi e organizzativi previsti sono finalizzati a creare un ambiente favorevole agli investimenti nel settore nucleare.
Tra i punti principali, si evidenziano:
- Istituzione di una Autorità amministrativa indipendente: il provvedimento prevede la creazione di una authority con compiti di regolazione, vigilanza e controllo sulle infrastrutture nucleari; un soggetto indipendente e in grado di garantire standard elevati di sicurezza e trasparenza.
- Procedure amministrative semplificate: riducendo i tempi e le complessità burocratiche, il legislatore intende favorire l’accesso a investimenti strategici e ridurre il rischio di contenziosi amministrativi, garantendo al contempo il rispetto dei requisiti di sicurezza e di tutela ambientale.
- Integrazione con la normativa ambientale: particolare attenzione viene posta all’integrazione tra le normative relative alla sicurezza nucleare e quelle inerenti alla tutela dell’ambiente. Vengono introdotti strumenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) e studi di fattibilità, indispensabili per bilanciare interessi economici e salvaguardia del territorio e della salute pubblica.
Analisi giuridica e implicazioni amministrative
Dal punto di vista giuridico, il rilancio del nucleare solleva questioni complesse inerenti alla compatibilità dei nuovi provvedimenti con il quadro normativo esistente.
Tra gli aspetti di maggiore rilievo, si segnalano:
- Compatibilità con il Diritto Europeo: Il legislatore deve garantire che il nuovo assetto normativo rispetti i principi di proporzionalità, trasparenza e partecipazione, evitando conflitti con i regolamenti comunitari in materia di sicurezza e tutela ambientale
- Garanzie procedurali e tutela dei diritti: Le procedure amministrative di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio delle centrali nucleari devono essere concepite in un’ottica di efficienza senza compromettere il diritto di accesso all’informazione e alla partecipazione dei cittadini.
- Responsabilità e sicurezza: La definizione di un quadro di responsabilità ben delineato è essenziale per gestire i rischi connessi all’attività nucleare. Ciò implica non solo il rafforzamento dei controlli pre-esercizio, ma anche l’istituzione di meccanismi di intervento rapido in caso di incidenti, con conseguenti implicazioni in termini di responsabilità civile e penale.
Un punto cardine del ragionamento giuridico riguarda il principio secondo cui un referendum abrogativo vincola il legislatore solo in assenza di un mutamento sostanziale delle circostanze politiche e fattuali. (questo viene espressamente detto nel punto 5)
A tal proposito, la Corte Costituzionale con sentenza n. 199/2012 aveva stabilito che:
«[…] un limite discendente dalle precedenti abrogazioni referendarie potrebbe rilevare solo se, nel corso del tempo, non si fosse “determinato, successivamente all’abrogazione, alcun mutamento né del quadro politico, né delle circostanze di fatto”»
Questo orientamento si fonda sul principio di adeguatezza normativa in un contesto in continua evoluzione.
Il legislatore, infatti, ha il compito di rispondere alle mutate esigenze della collettività e alle innovazioni tecnologiche, operando un aggiornamento del quadro normativo anche in settori in cui in passato si era optato per l’abrogazione tramite referendum.
La distinzione tra il “nucleare tradizionale” e il “nucleare sostenibile” evidenzia come l’attuale intervento legislativo possa essere orientato a favorire lo sviluppo di una tecnologia che, per i suoi caratteri innovativi e per il profilo di sicurezza e sostenibilità, non rientra nel medesimo ambito di rigetto politico e normativo che aveva interessato la precedente configurazione tecnologica.
In questo contesto, il principio della neutralità tecnologica riveste un’importanza primaria: le politiche energetiche e ambientali non devono favorire a priori una o più tecnologie specifiche, ma stabilire obiettivi chiari (a partire dalla riduzione delle emissioni di gas climalteranti), lasciando al mercato e agli operatori la scelta delle opzioni tecnologiche più efficaci e competitive. Tale principio è esplicitamente riconosciuto, tra l’altro, dall’art. 19, lettera a), del Regolamento UE 2020/852 sulla Tassonomia delle attività sostenibili.
Alla luce di quanto sinteticamente esposto, sembra dunque che il nucleare sostenibile, per i suoi avanzamenti rispetto alla tecnologia rifiutata in passato, non possa essere equiparato a quella abbandonata tramite referendum. La giurisprudenza costituzionale d’altro canto, , riconosce la possibilità di un intervento legislativo quando si evidenzia un mutamento sostanziale delle circostanze politiche e fattuali. Pertanto, l’intervento del legislatore in materia di nucleare sostenibile è giuridicamente legittimo e non è ostacolato dai precedenti vincoli referendarî, poiché tali ultimi si configurano come limitanti solo in assenza di mutamenti significativi.
Opportunità e sfide
Il rilancio del nucleare potrebbe rappresentare un’opportunità strategica per l’Italia, diversificando il proprio mix energetico e riducendo la dipendenza da fonti esterne.
Tuttavia, il percorso normativo e amministrativo non è privo di sfide, tra cui ricordiamo:
- Resistenze sociali e ambientali: è indispensabile adottare un approccio trasparente e partecipativo che coinvolga tutte le parti interessate, al fine di mitigare le preoccupazioni della società civile e delle associazioni ambientaliste.
- Investimenti e competitività: La semplificazione delle procedure e la definizione di criteri chiari di responsabilità giuridica possono favorire l’ingresso di capitali privati e di investitori internazionali, elementi fondamentali per il successo di progetti di tale portata.
- Coordinamento istituzionale: L’efficace implementazione del disegno di legge richiederà un coordinamento sinergico tra le istituzioni a livello nazionale e regionale, nonché una stretta collaborazione con gli organismi di controllo europeo, per garantire una corretta applicazione delle norme e un costante aggiornamento dei protocolli di sicurezza.
- Costi elevati e tempi lunghi: La realizzazione di nuovi impianti nucleari, soprattutto nelle economie OCSE, comporta costi elevati e tempi di costruzione prolungati. Questo si traduce in oneri per l’energia prodotta che può avere specie in una prima fase dei prezzi per MWh molto elevati, rendendola meno competitiva rispetto alle fonti rinnovabili come il solare e l’eolico.
- Concorrenza con le rinnovabili: La decisione di puntare sul nucleare potrebbe rallentare gli investimenti nelle rinnovabili.
- Regolamentazione rigorosa: Il settore nucleare è soggetto a una regolamentazione rigorosa, che può comportare procedure complesse e tempi di approvazione lunghi.
Prossimi passi
L’ art 1 del DDL definisce le finalità del disegno di legge e disciplina il procedimento di adozione dei decreti legislativi (entro 12 mesi) per disciplinare la produzione di energia nucleare in Italia, anche ai fini della produzione di idrogeno. Si precisa inoltre che entro 24 mesi dall’entrata in vigore di ciascun decreto, il Governo potrà adottare uno o più decreti legislativi con disposizioni integrative e correttive, così come si prevede che l’esercizio della delega potrà avvenire anche mediante il compimento di un’opera di codificazione (testo unico).
Un quadro normativo-regolatorio completo (fondamentale per i rilevanti nuovi investimenti) con ogni probabilità non sarà definito nel corso dell’attuale legislatura.
Ciò detto, il nuovo disegno di legge si configura come un provvedimento ambizioso e complesso che mira a creare le condizioni per una rinascita di un settore strategico. L’armonizzazione con il diritto europeo, la semplificazione delle procedure amministrative e la rigorosa attenzione alla sicurezza e alla tutela ambientale sono elementi essenziali per garantire che tale riforma possa tradursi in una concreta opportunità di sviluppo energetico e tecnologico per il nostro Paese.
Posto che il primo passo sarà la creazione di un’Autorità amministrativa indipendente di settore rimane fondamentale mantenere aperto un dibattito approfondito con tutti gli stakeholders ed una costante verifica dell’implementazione tecnologica e sull’evoluzione delle best practices in materia di sicurezza nucleare e sostenibilità ambientale.