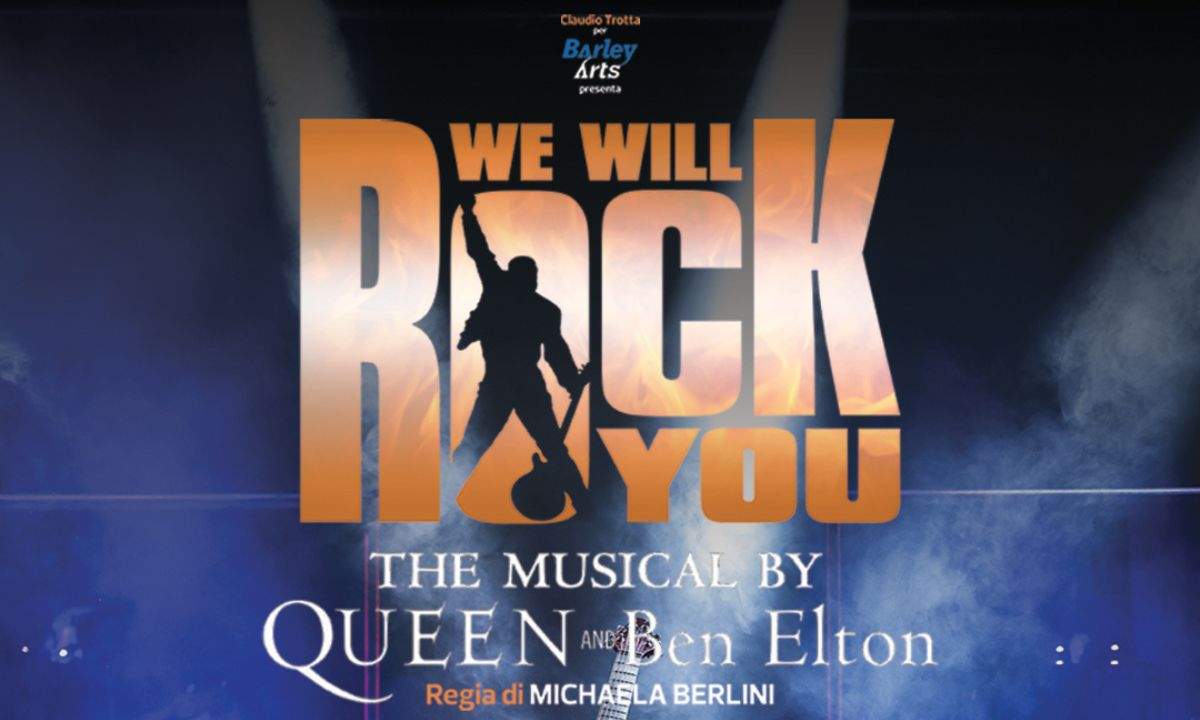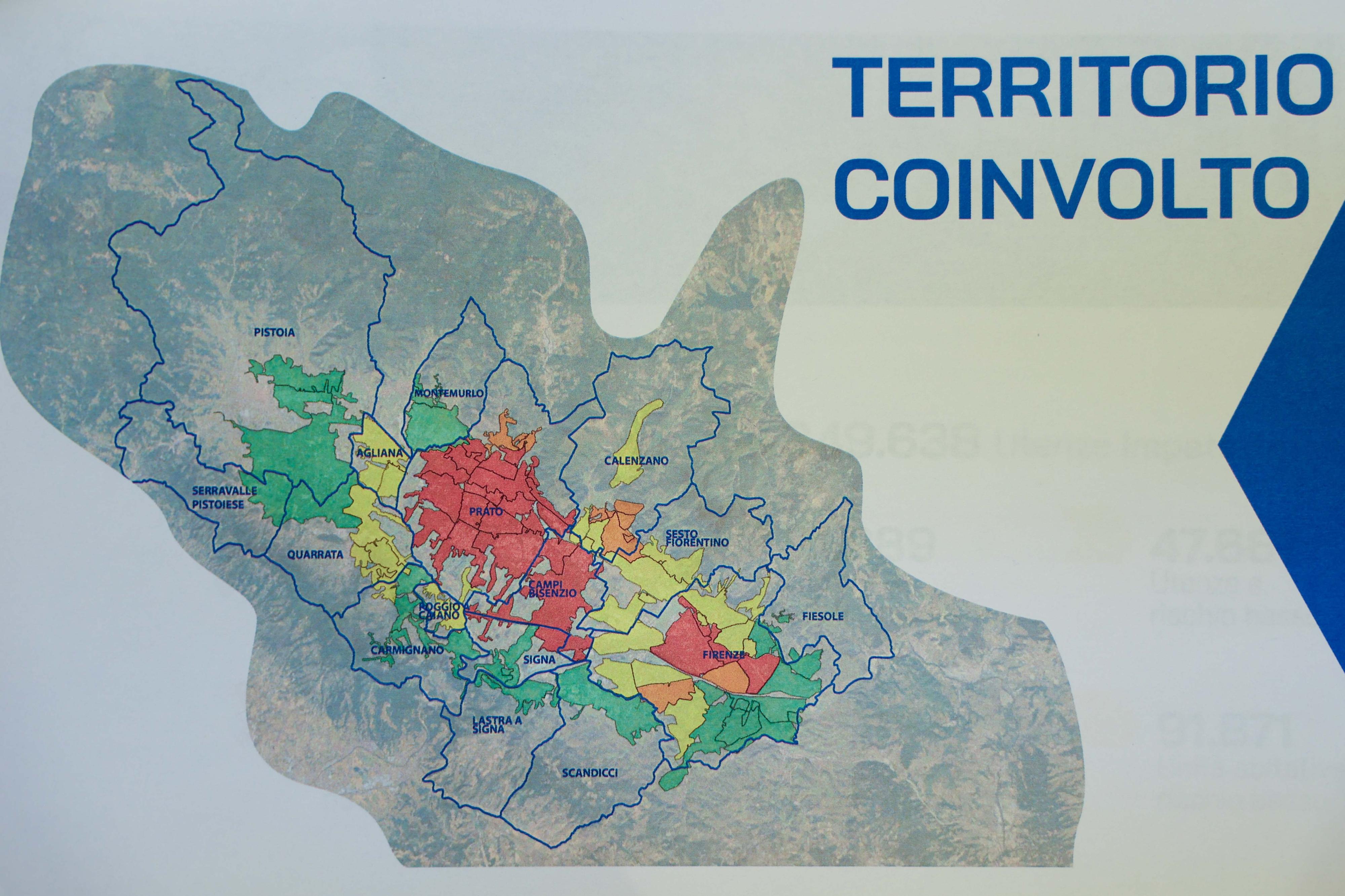Non è l’#ultimogiornodigaza. Gaza vive e questo trend mi offende
Il 9 maggio è la Giornata dell’Europa, una ricorrenza simbolica che celebra l’unità del continente dopo la Seconda Guerra Mondiale. In questa data, un gruppo di intellettuali italiani ha lanciato una campagna online e offline per “rompere il silenzio su Gaza”. L’invito è a esprimere il proprio dolore attraverso contenuti social, iniziative pubbliche e gli […] L'articolo Non è l’#ultimogiornodigaza. Gaza vive e questo trend mi offende proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il 9 maggio è la Giornata dell’Europa, una ricorrenza simbolica che celebra l’unità del continente dopo la Seconda Guerra Mondiale. In questa data, un gruppo di intellettuali italiani ha lanciato una campagna online e offline per “rompere il silenzio su Gaza”. L’invito è a esprimere il proprio dolore attraverso contenuti social, iniziative pubbliche e gli hashtag #ultimogiornodigaza e #gazalastday.
L’iniziativa si presenta come un atto collettivo di lutto e consapevolezza. Ma a me sembra l’ennesima performance simbolica che dice poco e serve ancora meno. Questa non è una presa di posizione. È un rituale d’espiazione per coscienze europee in crisi d’immagine e di senso.
L’hashtag #ultimogiornodigaza è il sintomo perfetto di questa retorica tossica: non è l’ultimo giorno per Gaza. Gaza vive. Gaza resiste. Gaza continua a generare vita, sapere, cultura, lotta. Parlare di “ultimo giorno” è un modo rassicurante per certificare una fine, per trasformare un popolo in simbolo astratto, e un genocidio in specchio del disagio europeo.
È l’ennesima narrazione che decentra la Palestina e ricentra l’Europa.
Nel manifesto si legge: “Ed è altrettanto vero che senza Gaza siamo noi a morire. Noi, italiani, europei, umani”. Questa frase è emblematica dell’autoreferenzialità occidentale. Il focus non è Gaza, non sono i palestinesi. È l’Europa. Sono le coscienze ferite degli europei, non i corpi lacerati dei palestinesi. È un’autocelebrazione mascherata da empatia. Un pianto specchiato, autoreferenziale, dove la sofferenza altrui diventa un’occasione per elaborare il nostro spaesamento. “Guardarci negli occhi”, “riscoprire la nostra umanità”: parole altisonanti che, a mio avviso, sfuggono ogni responsabilità storica. Ma non è guardandoci negli occhi che cambieremo qualcosa. È guardando Gaza per quello che è: una vittima di un progetto coloniale violento e sistematico che noi abbiamo aiutato a creare e che abbiamo potenziato, anche tramite la diffusione di informazioni false nei media e di narrazioni pietiste e tossiche come questa.
Molti dei promotori dell’iniziativa – tra cui Paola Caridi, Claudia Durastanti, Tomaso Montanari, Giuseppe Mazza – non sono mai stati silenziosi sulla Palestina. Alcuni hanno prodotto lavori seri e importanti in un contesto italiano ostile. Il mio non è un attacco personale, né di una delegittimazione delle singole voci che hanno cercato, con onestà, di raccontare la realtà palestinese. Proprio per questo, trovo ancora più deludente che la narrazione che emerge da questa campagna finisca per appiattire tutto in un registro pietista, depoliticizzato, ambiguo. Un dolore condiviso, sì — ma neutro, disinnescato, incapace di nominare con chiarezza responsabilità storiche europee e strategie di resistenza del popolo palestinese.
Altri dei firmatari, invece, hanno sempre mantenuto un approccio estremamente prudente, retoricamente sterilizzato: mille premesse, mille cautele, mille formule vaghe per non dire da che parte si sta davvero. E ora che Netanyahu è agli sgoccioli della sua carriera politica, ora che criticare Israele costa meno, escono con questa iniziativa simbolica e comunque problematica.
Alcune di queste persone, nei loro interventi pubblici, nei dibattiti, nei media mainstream, hanno sì evocato la sofferenza palestinese come un trauma universale, mai come il risultato diretto, sistematico e continuo di un progetto coloniale europeo.
Il loro discorso resta confinato nella solita cornice umanitaria: si piange, si compatisce, ma non si sostiene; si denuncia la “violenza” in astratto, si rimuove la legittimità della resistenza palestinese. In nome del coinvolgimento del maggior numero possibile di persone, si firmano comunicati ambigui, pietisti, depoliticizzati. Coinvolgere più persone. Ma a che prezzo? A prezzo della verità. A prezzo dei principi.
Io, da palestinese, non ci sto. Mi sento offesa. E, da essere umano che si informa su questi temi e che lotta ogni giorno per la giustizia e la verità, sento disgusto. Gaza viene ridotta a una ferita simbolica da contemplare, non a un soggetto politico vivo, consapevole, organizzato. Questo schema — anche quando non dichiarato — è ciò che l’iniziativa riproduce su larga scala. E in questo senso, il trend del 9 maggio non rompe alcun silenzio. Prosegue lo stesso schema retorico dominante da mesi: dare la colpa solo a Netanyahu; evitare di nominare la resistenza palestinese per non turbare equilibri accademici, editoriali, politici; evitare tutto ciò che potrebbe davvero incrinare il privilegio di chi parla da europeo.
Gli europei piangono. Piangono per Gaza senza dire chi ha ridotto Gaza in questo stato. Si illudono che sia solo colpa di Netanyahu — un singolo uomo, ormai scomodo persino per loro. Piangono “da umani”, non da complici. Ma non siamo solo “umani” esterni a tutto ciò: siamo parte di un sistema politico, culturale ed economico che finanzia, legittima e protegge chi Gaza la devasta.
Allora cosa fare, invece? Invece di commuoverci solamente davanti ai corpi martoriati, iniziamo a riconoscere l’umanità piena dei palestinesi. Non solo vittime, non solo affamati, non solo morti: soggetti politici, consapevoli, organizzati. Con visioni, voci e strategie. Non hanno bisogno della nostra pena, ma del nostro sostegno. Sostegno senza condizioni, senza filtri, senza proiezioni rassicuranti. Smettiamola di chiederci quanto possiamo piangere; iniziamo a domandarci come possiamo sostenere davvero la loro lotta. Questo significa ascoltare e amplificare le richieste dei movimenti palestinesi; sostenere il boicottaggio economico, culturale e accademico di Israele (BDS); smettere di criminalizzare la resistenza; denunciare con chiarezza le complicità italiane ed europee nel genocidio in corso.
Solidarietà non è solo empatia. È alleanza. È rischio. È scelta. Fino ad allora, #ultimogiornodigaza resterà solo l’ultimo tentativo di salvare la faccia — non Gaza.
L'articolo Non è l’#ultimogiornodigaza. Gaza vive e questo trend mi offende proviene da Il Fatto Quotidiano.