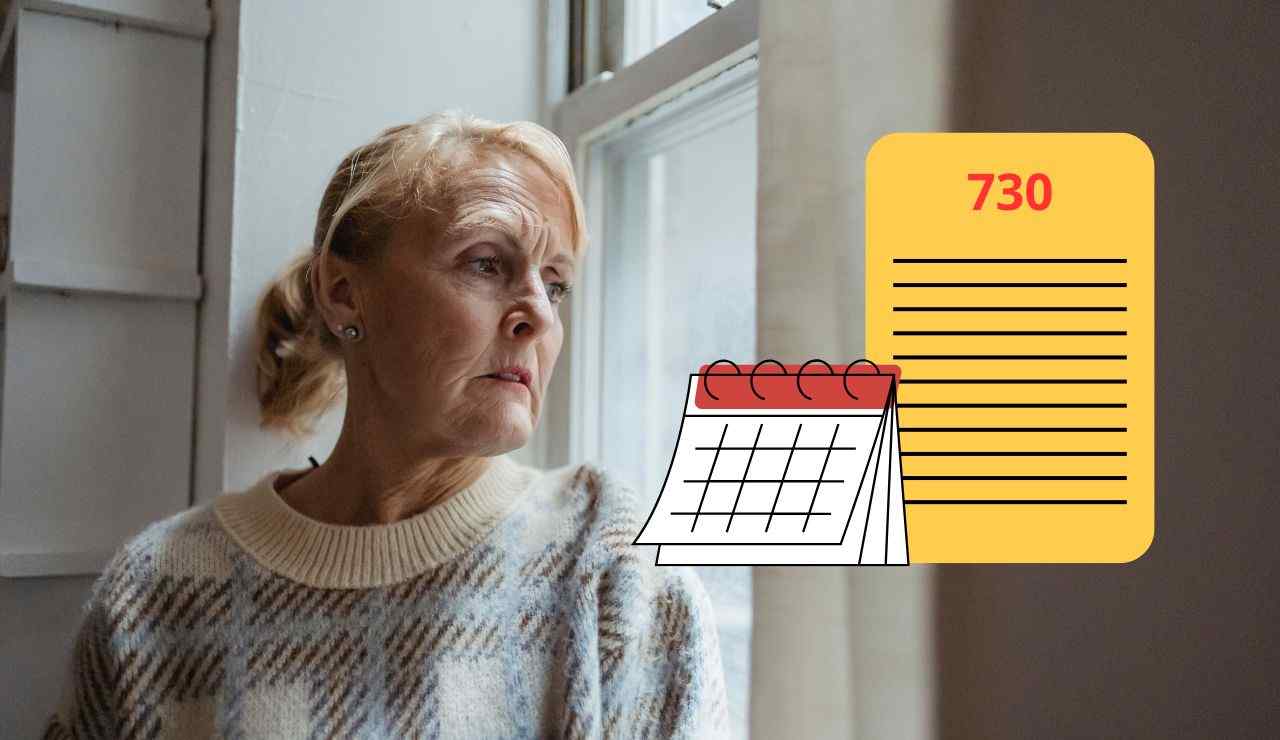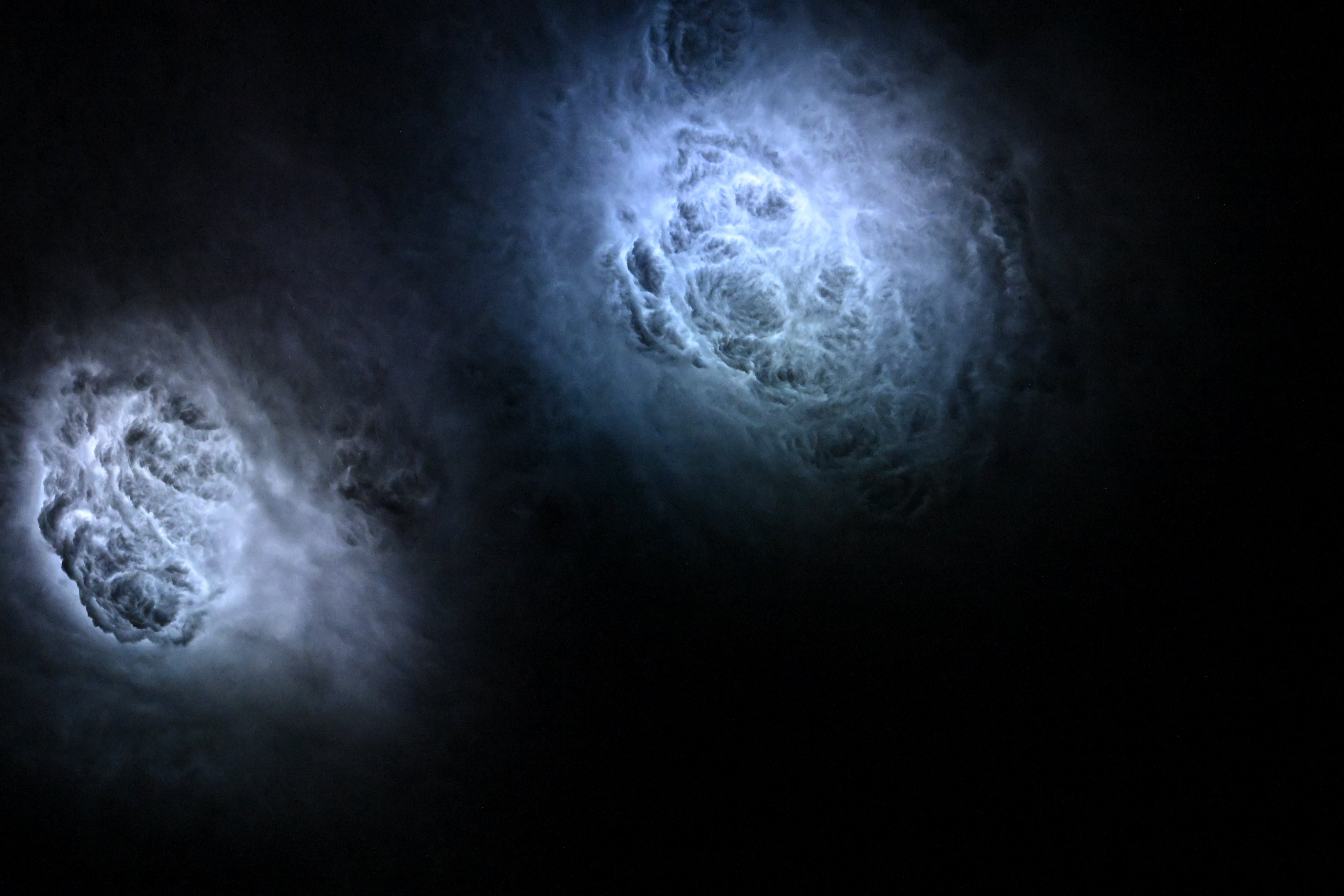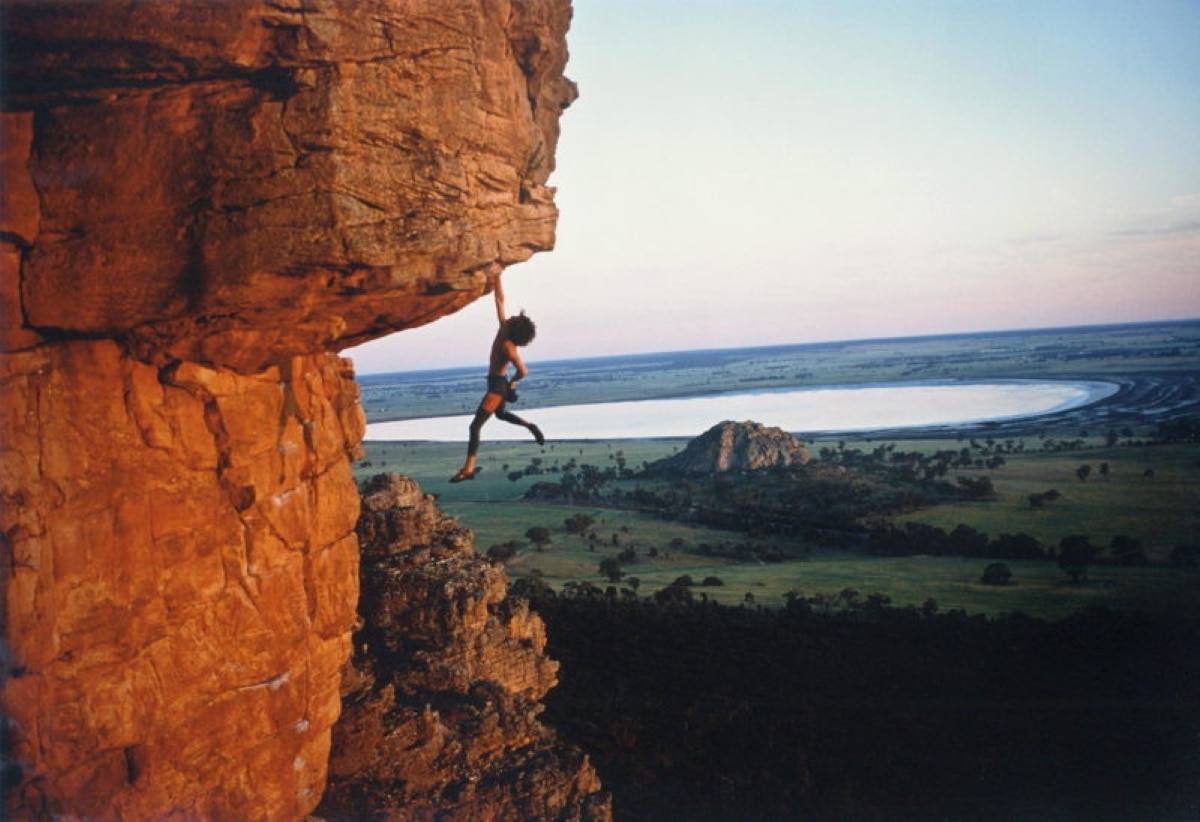Le opportunità della filantropia
di Alessandra Losito, country head Italia di Pictet Wealth Management La gestione patrimoniale è chiamata oggi a evolvere in una direzione più responsabile e consapevole. Come? Integrando la filantropia imprenditoriale all’interno del portafoglio degli Hnwi. In questo modo, da un lato si apre un’opportunità per gli imprenditori di restituire valore alla società, trasformando... Leggi tutto

di Alessandra Losito, country head Italia di Pictet Wealth Management
La gestione patrimoniale è chiamata oggi a evolvere in una direzione più responsabile e consapevole. Come? Integrando la filantropia imprenditoriale all’interno del portafoglio degli Hnwi. In questo modo, da un lato si apre un’opportunità per gli imprenditori di restituire valore alla società, trasformando il loro successo in un’eredità duratura. Dall’altro, promuovere la filantropia come parte della gestione del patrimonio significa riconoscere che la vera ricchezza non è solo quella materiale, ma anche quella etica e sociale. Una visione che, se abbracciata su larga scala, potrebbe generare un impatto positivo duraturo, contribuendo non solo al benessere delle comunità locali, ma anche alla stabilità globale. E, ultimo ma non meno importante, i filantropi ne trarrebbero un vantaggio anche in termini di efficienza del portafoglio.
Il gap da recuperare
Ma perché ciò avvenga è necessario che l’Italia recuperi il gap filantropico che la separa dai suoi omologhi europei, promuovendo maggiormente una cultura della finanza che abbia come finalità ultima il bene comune.
La filantropia in Italia ha un ampio potenziale inespresso. Nonostante l’ingente ricchezza privata disponibile e la presenza di strumenti innovativi, nonché di importanti agevolazioni fiscali, le donazioni restano ancora limitate rispetto ad altri paesi. Per colmare questo divario, è necessario aumentare la consapevolezza sulle opportunità di investimento che si possono cogliere facendo del bene, promuovendo una maggiore trasparenza degli enti del Terzo Settore e sviluppando nuovi strumenti come i Donor-Advised Fund. A tal fine, un impegno coordinato tra privati, aziende e istituzioni finanziarie potrebbe rappresentare una svolta decisiva.
Negli ultimi anni la filantropia ha registrato una crescita significativa nel nostro Paese, con un valore economico totale delle donazioni individuali che ha raggiunto i 10 miliardi di euro; una cifra che rappresenta tuttavia appena lo 0,2% della ricchezza finanziaria complessiva del Paese, stimata in 5 mila miliardi di euro . Pur mostrando segnali di crescita, tuttavia, il valore del comparto è ancora distante dai livelli raggiunti da altri paesi avanzati.
La tradizione Usa
Il confronto con gli Stati Uniti, ad esempio, risulta particolarmente svantaggioso: gli americani, pur essendo sei volte più numerosi degli italiani, donano ben 48 volte di più. Ma anche rispetto a paesi “vicini” come Regno Unito, Germania e Francia, la filantropia italiana si trova qualche passo indietro. Secondo una recente ricerca del Fondo Filantropico Italiano, solo il 5% degli HNnwo ha effettuato donazioni superiori ai 100 mila euro e in nessuna fascia di ricchezza la percentuale di patrimonio destinata alle donazioni ha superato l’1%. Tra le categorie analizzate, gli imprenditori si distinguono per un maggiore impegno filantropico con una donazione media di 12.350 euro annui. Quest’ultimi utilizzano diversi canali di donazione: il 22% dona a titolo personale, il 15% attraverso le aziende, mentre il 63% adotta una combinazione di queste due modalità. L’impegno degli imprenditori si riflette anche nella partecipazione attiva a iniziative filantropiche: il 71% dichiara di essere coinvolto in attività di volontariato e il 49% organizza raccolte fondi ed eventi benefici.
Il ruolo cruciale degli imprenditori
In Pictet Wealth Management abbiamo approfondito il rapporto tra imprenditori e attività filantropiche studiando l’evoluzione degli ultimi anni, definendola come l’era dei “philanthropreneurs”. Il termine indica l’applicazione della mentalità imprenditoriale alle iniziative filantropiche, combinando visione strategica, abilità nella risoluzione dei problemi e risorse finanziarie per affrontare le sfide globali. In particolare, la filantropia imprenditoriale non si limita a interventi caritatevoli immediati, bensì punta a trasformare sistematicamente le cause profonde dei problemi sociali e ambientali. Spesso gli imprenditori trovano in questo campo una nuova vocazione dopo aver lasciato il mondo degli affari: il desiderio di creare un’eredità duratura li spinge a investire in progetti significativi, spesso coinvolgendo le loro famiglie per trasmettere valori di responsabilità e servizio.
Massimizzare l’impatto sociale
Inoltre, un approccio imprenditoriale alla filantropia può massimizzare l’impatto sociale. Gli esempi a riguardo non mancano: da un imprenditore europeo che, dopo aver venduto la sua azienda tecnologica, ha deciso di impegnarsi nella creazione di un’organizzazione che sviluppa soluzioni innovative per portare acqua potabile nelle aree più remote dell’Africa, a un ex ceo di una multinazionale che ha creato una fondazione volta a garantire l’accesso a un’istruzione di qualità ai bambini delle aree rurali dell’America Latina tramite un modello di micro-finanziamento con il supporto di donatori privati e istituzionali. Ancora, un gruppo di imprenditori ha lanciato un’organizzazione che fornisce cure mediche a basso costo nelle aree rurali dell’India, adottando un modello di business sostenibile. Tutte queste iniziative hanno seguito un percorso standardizzato, a partire dall’identificazione di opportunità mirate – come avviene nel business – focalizzandosi su un’unica causa alla volta per massimizzare l’impatto, e facendo poi leva sulle proprie competenze imprenditoriali e network per sostenere le organizzazioni no-profit create. Inoltre, serve misurare l’impatto delle iniziative filantropiche così come si misurano i risultati di un’azienda e, ove preferibile, collaborare con altre organizzazioni per evitare duplicazioni e inefficienze. Infine, è indispensabile adottare una visione sistemica, mirando a cambiamenti strutturali, promuovendo politiche di lungo termine e coinvolgendo le nuove generazioni, per rafforzare i legami interni tra familiari nella gestione del patrimonio ed educare i figli alla consapevolezza sociale, trasformando la propria ricchezza in uno strumento di bene collettivo piuttosto che in un simbolo di privilegio.
Doppia linea di azione
Come detto, ad oggi in Italia lo spazio di crescita degli investimenti in attività filantropiche è enorme ma, dall’altra parte, è necessario agire sia sul piano culturale che su quello pratico per favorirne uno sviluppo sostenibile e duraturo nel tempo. La stessa conoscenza degli strumenti filantropici, ad esempio, risulta ancora limitata da noi rispetto ad altri paesi: il trust è lo strumento più conosciuto tra i grandi donatori, che affermano di utilizzarlo o di volerlo adoperare in futuro, mentre le fondazioni di famiglia sono maggiormente diffuse tra coloro che possiedono patrimoni compresi tra 500 mila e 1 milione di euro . I Donor-Advised Fund (Daf), al contrario, sono pressoché sconosciuti: negli Stati Uniti esistono oltre 1,2 milioni di Daf, con un totale di 234 miliardi di dollari gestiti. Anche in Europa, i Dad stanno guadagnando popolarità: in Belgio la King Baudouin Foundation ne gestisce più di mille per un totale di un miliardo di euro, mentre in Francia la Fondation de France ne conta oltre 950 con un patrimonio complessivo di 1,4 miliardi di euro. La Svizzera, pur avendo introdotto i Daf più recentemente, registra già 75 fondi attivi con un totale di 300 milioni di euro gestiti. In Italia i Daf sono ancora poco noti e utilizzati sebbene rappresentino una soluzione interessante per migliorare l’efficacia delle donazioni e favorire una maggiore partecipazione dei privati alla filantropia.
Tra investimenti e sostenibilità
L’ultimo punto su cui accelerare è il connubio crescente tra investimenti responsabili e filantropia. In Pictet Wealth Management abbiamo calcolato che, se solo l’1% della ricchezza finanziaria mondiale (oggi a 250 mila miliardi di dollari) fosse destinata a investimenti a impatto, si farebbero passi avanti significativi verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Onu. E le iniziative filantropiche, che raccolgono globalmente 1.500 miliardi di dollari, sono a impatto. Ma perché su di esse si riversino capitali è necessario che siano inserite in un continuum del capitale privato, un modello che colloca le varie forme di utilizzo del capitale lungo un asse che va dagli investimenti puramente finanziari a quelli interamente filantropici. Lungo questo continuum si distinguono diverse categorie: investimenti tradizionali non Esg, investimenti con criteri ESG integrati, investimenti a impatto positivo e, infine, la filantropia catalitica volta a risolvere problemi complessi mediante un approccio sistemico e innovativo.
Un aspetto cruciale è l’idea che filantropi e investitori debbano collaborare per accrescere l’efficacia delle rispettive azioni. Iniziative come la finanza mista, in cui fondazioni filantropiche offrono capitali iniziali per progetti ad alto rischio, consentono ai capitali privati di entrare successivamente in gioco una volta che il modello si dimostra sostenibile. Fondazioni di impresa e venture capitalist, ma anche gestori di patrimoni, possono lavorare insieme per sostenere imprese che affrontano problemi sociali, con benefici per tutte le parti coinvolte: l’azienda riceve il capitale, il filantropo realizza i propri obiettivi sociali e l’investitore ottiene un ritorno finanziario sostenibile.