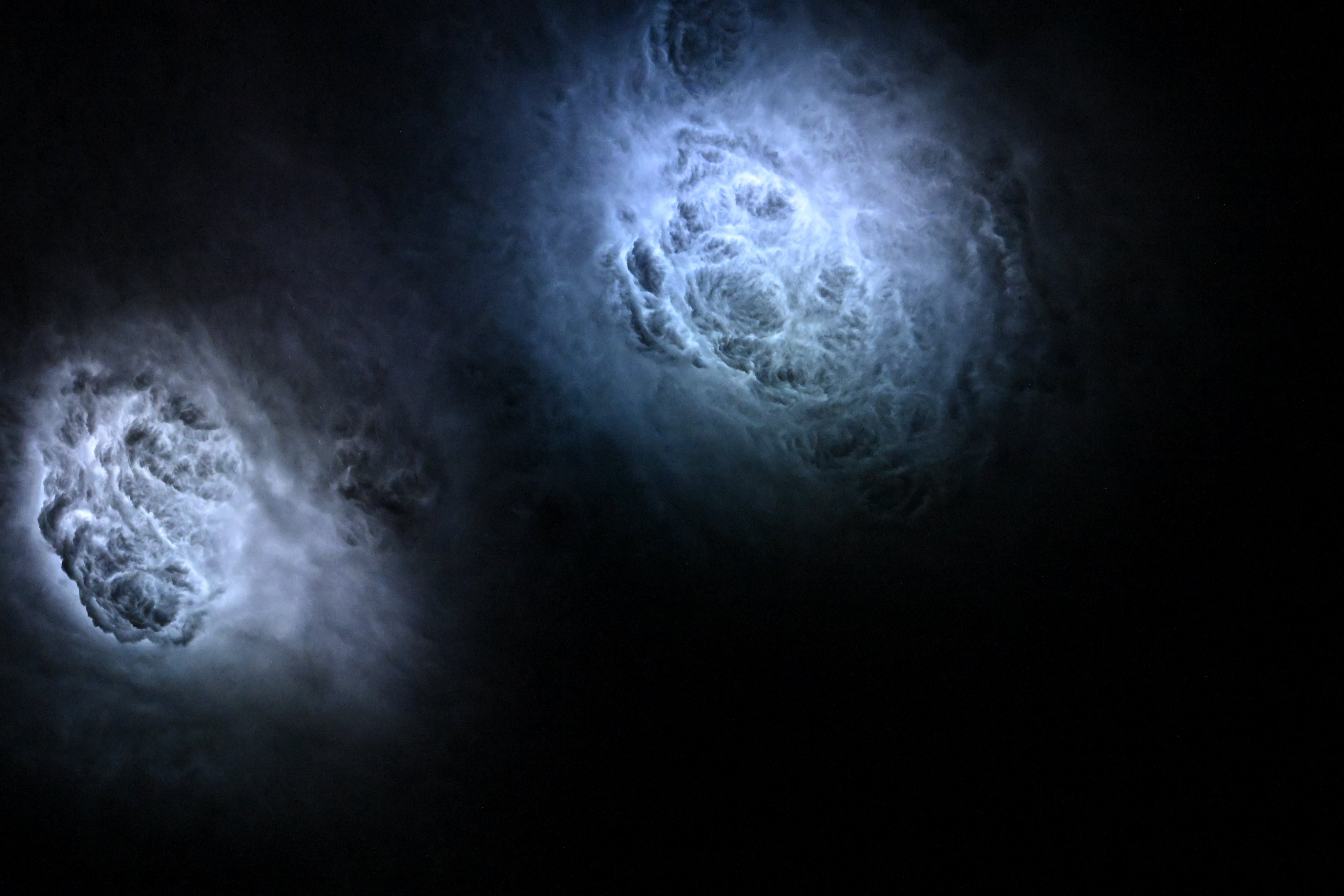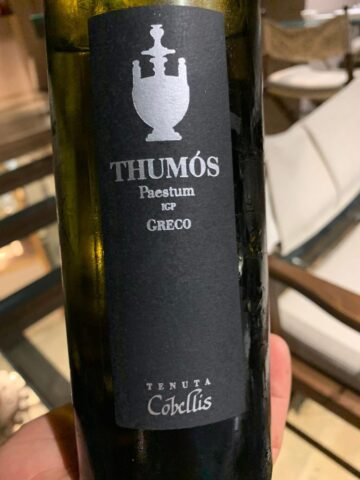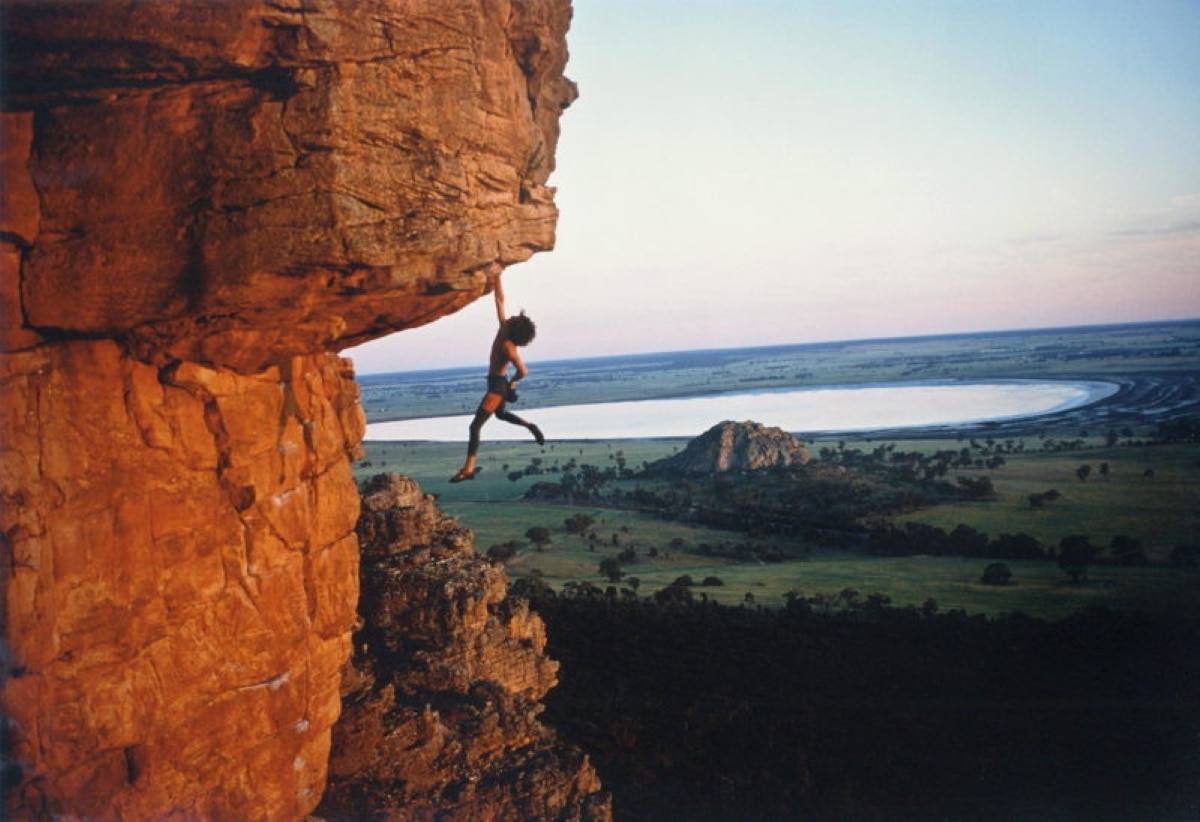Nobiltà del mecenatismo al femminile: il poeta e la principessa
In una fiaba scritta dalla principessa Maria della Torre e Tasso la cui trama è lo svolgimento di un tea party animato da personaggi fantastici che incarnano, a ben vedere, le figure del mondo di amici che ruotava attorno Maria e alla sua dimora preferita, il castello di Duino. Qui, il poeta Rainer Maria Rilke, […] L'articolo Nobiltà del mecenatismo al femminile: il poeta e la principessa proviene da Economy Magazine.

In una fiaba scritta dalla principessa Maria della Torre e Tasso la cui trama è lo svolgimento di un tea party animato da personaggi fantastici che incarnano, a ben vedere, le figure del mondo di amici che ruotava attorno Maria e alla sua dimora preferita, il castello di Duino. Qui, il poeta Rainer Maria Rilke, avvertì, dopo ripetute incursioni del suo male oscuro, la voce della divina ispirazione. Come le elegie del poeta, anche la fiaba fu scritta a Duino. In quel periodo la loro amicizia si era pienamente consolidata, non solo durante il lungo soggiorno del poeta al castello, ma anche nei viaggi compiuti insieme, nella vicina Venezia, dove la principessa possedeva un mezzanino nel quale Rilke fu più volte ospitato. La contiguità tra Duino e Venezia, relativa dal punto della distanza spaziale, fu così intensa dal punto di vista affettivo e mentale che le due “dimore” divennero per il poeta parte di uno stesso paesaggio interiore, al punto che in diverse lettere della corrispondenza i due luoghi si sovrappongono in un unico richiamo all’indicibile: “Car la parole -scrive Rilke citando un Sonetto di Francesco I- est toujours réprimée quand le sujet surmonte le disant”.
Questo vissuto profondo che accomuna due personalità così lontane per età, origini sociali, percorsi biografici e tratti caratteriali è nutrito, nei giorni della vicinanza, durante i brevi viaggi compiuti insieme, ma soprattutto nei soggiorni veneziani, da piccoli gesti quotidiani come la ricerca di oggetti d’arte, di edizioni rare di libri e manoscritti, la contemplazione condivisa e, dunque, gioiosa di opere d’arte famose, e poi le mattinate musicali all’aperto, il comune lavoro di traduzione di Dante e Petrarca, le conversazioni al tramonto sulla terrazza del castello o nel boudoir tappezzato di piccole e grandi storie, della principessa. Una vita dove ogni piccolo gesto ha volutamente, i caratteri dell’eccezionalità, é parte di una fiaba che lo deve racchiudere e separare da tutto ciò che non può essere trascritto nel linguaggio che gli é proprio. Sotto questo profilo la fiaba scritta dalla principessa è un modo di trasmettere il codice di accesso a quel linguaggio ed è innanzitutto un’allegoria della vita al castello, un castello di cristalli e d’argento dove la protagonista, la signorina Luna, riceve ragguardevoli personaggi, il figlio del Sole, la regina delle Nevi, il lampionaio delle Stelle, il signor Fulmine. Quest’ultimo è un vero guastafeste, è indisciplinato e capriccioso, molesta gli ospiti, confonde i loro nomi ed è pure un po’ ingordo. È insomma l’opposto speculare del dolce Dottor Serafico, il nome con cui la principessa ed i suoi amici erano soliti chiamare Rilke, le cui intemperanze al castello ci fanno pensare, un po’ maliziosamente, che fosse proprio il poeta, o per lo meno certi comportamenti del poeta ad essere rappresentati nelle vesti del Signor Fulmine. In questo personaggio che alla fine verrà cacciato dal castello, mentre il dottor Serafico vi sarà si accolto con tutti gli onori, si deve tuttavia ritrovare soprattutto la rappresentazione di forze ben più minacciose dei capricci e delle intemperanze di Rilke. La fiaba fu scritta infatti sull’orlo del precipizio, che lentamente incrinava un’armonia ritenuta intangibile e che, repentinamente, la guerra trasformò in una voragine in cui insieme al castello venne inghiottito quel mondo, restituendocelo solo attraverso la memoria delle corrispondenze.
Una memoria in cui l’idillio è in parte perduto e l’armonia del convivio si intreccia con le nevrosi ossessive di alcuni dei convitati, ossessioni generate soprattutto dalla ricerca esasperata del superamento dei confini che separano la banalità dell’esistere dalla divinità dell’essere e in cui solo la “Creazione” poteva avere dimora.
Per Rilke significativamente quelle ossessioni si tradussero in un itinerario mai pienamente compiuto di ricerca della “dimora creatrice”, una dimora che, come si è detto, doveva essere radicalmente separata – ed è questa la seconda grande minaccia che grava su quel mondo incantato – dalle contaminazioni indotte dalla mercificazione dell’arte, dalla banalizzazione del godimento artistico. Questa sensibilità che avvicinava in modo profondo il poeta e la principessa e che ricorre costantemente nella corrispondenza soprattutto nel periodo posteriore alla guerra (“le temps d’admirer est revolu mais qui alors jouira de l’art pour qui produira-t-on?” – si chiedono all’unisono i due amici) è anche il punto di intersezione tra la storia sospesa, aerea che ho evocato e tematiche di più ampio respiro che possono condurci attraverso la guida dei due personaggi a riflessioni che riguardano aspetti di una transizione sociale in atto, evocando pero anche gli aspetti profondi del mecenatismo quando esso è connesso alol’amicizia e alla nobiltà non solo di appartenenza sociale ma di cultura e d’animo. In questa prospettiva profonda e universalistica il mecenate agisce come una sorta di demiurgo che illumina l’intelligenza creatrice ed è il vero protagonista di una relazione in cui taora compare l’affinità ed l’amicizia
In questo passaggio il patronage che caratterizzava il mecenatismo al maschile si arricchisce di nuove forme che derivano dall’irruzione sulla scena dei personaggi femminili e dal delinearsi di modelli di relazione in cui il potere si trasforma in tutela, in protezione e l’ amicizia è piuttosto passione (non necessariamente in senso amoroso) comprensione, maternage. Il caso di Rilke e della Principessa di Duino è da questo punto di vista esemplare e assume una connotazione di reciprocità .
L’artista dona e a lui va la gratitudine della mecenate. Nella corrispondenza con Rilke è la principessa a ringraziare il poeta per il dono della sua arte che lei sente come una fruizione esclusiva. Il poeta riceve in cambio una protezione che non é solo di ordine materiale e intellettuale (“le dimore creative”) ma di ordine affettivo e profondo. Il poeta che nel rapporto con la principessa é libero dalla ossessione del possesso, quel possesso che governa invece i suoi rapporti con le innumerevoli “amate” e che lo fa fuggire ogni volta che il demone imperioso della creatività entra in conflitto con la sua capacità di amare, instaura con lei, un rapporto di tipo psicoanalitico. Rapporto piuttosto sorprendente se si considera non solo, come nota Kassner che “Maria della Torre e Tasso era del tutto estranea alle considerazioni psicoanalitiche e non aveva alcun interesse per la materia” ma che la principessa teneva costantemente nei rapporti con l’amico-poeta un tono solare, scherzoso e talora persino un po’ moqueur. È in questa struttura relazionale nobilmente asimmetrica, che Rilke trova la dimora” in cui sciogliere i nodi più intimi del suo stesso esistere
“Je ne suis pas un être aimant parce que je n’aime pas ma mere”- le scrive con una semplicità lapidaria che non fa parte delle sue abitudini letterarie. Significativamente la principessa è l’unica persona di lingua madre tedesca con cui Rilke corrisponde e comunica in francese, lingua amata (è noto che una parte consistente della poesia di Rilke è in francese) ma anche odiata perché impostagli dalla madr sin dall’infanzia come strumento e come simbolo di ascesa sociale. Qui la “nobiltà” della relazione tra il poeta e la principessa emerge n tutta la sua nobiltà che è insieme umana e culturale.
Il maternage di Maria non è rivolto solo a Rilke ma alla gestazione della sua opera, delle elegie che, proprio perché concepitein una dimensione separata dal possesso, le appartengono nella forma di una “proprietà” . “De la proprieté de…” le scrive Rilke, in francese, annunciando in modo trionfale il loro completamento e dedicandole la sua opera. “C’est pour cela seul que j’ai subsisté, envers et contre tout. Et c’était bien cela, qui fasait défaut. Rien que cela!” Tutto questo spiega non solo la nobiltà della loro relazione ma la ragione per cui le elegie sono dedicate alla Principessa. La lettera si chiude con un messaggio di grande profondità in cui la principessa, che mai un istante si atteggia a Musa ispiratrice, spinge il poeta a superare se stesso ad andare al di là delle ossessioni che avevano nutrito il dio del canto. La figura materna che lo ha accolto attraverso il distacco e l’accettazione di un’alterità irriducibile, gli chiede infatti di ricongiungersi con la madre che lo ha generato e che lo ha allontanato da sé con la sua incombente possessività. “Serafico – scrive la principessa facendo riferimento a un verso di Dante – malgré tant de sombres choses qui vous separent (*dalla madre) au cours de ce cheminement: ‘Benedetta colei che in te s’incise’. Je pense à vous avec un’ inexprimable reconnaissance”.
Non sappiamo fino a che punto Rilke abbia raccolto e fatto suo, in profondità, questo messaggio di salvazione, quale vero compimento dell’opera creatrice. Una frase della sua ultima lettera, a pochi mesi dalla morte, ce lo lascia sperare: “un sens mystérieux – scrive il poeta- donnera sa verité et sa justification à la dédicace qui figurera dans les Elegies : de la proprieté de…..”
L'articolo Nobiltà del mecenatismo al femminile: il poeta e la principessa proviene da Economy Magazine.