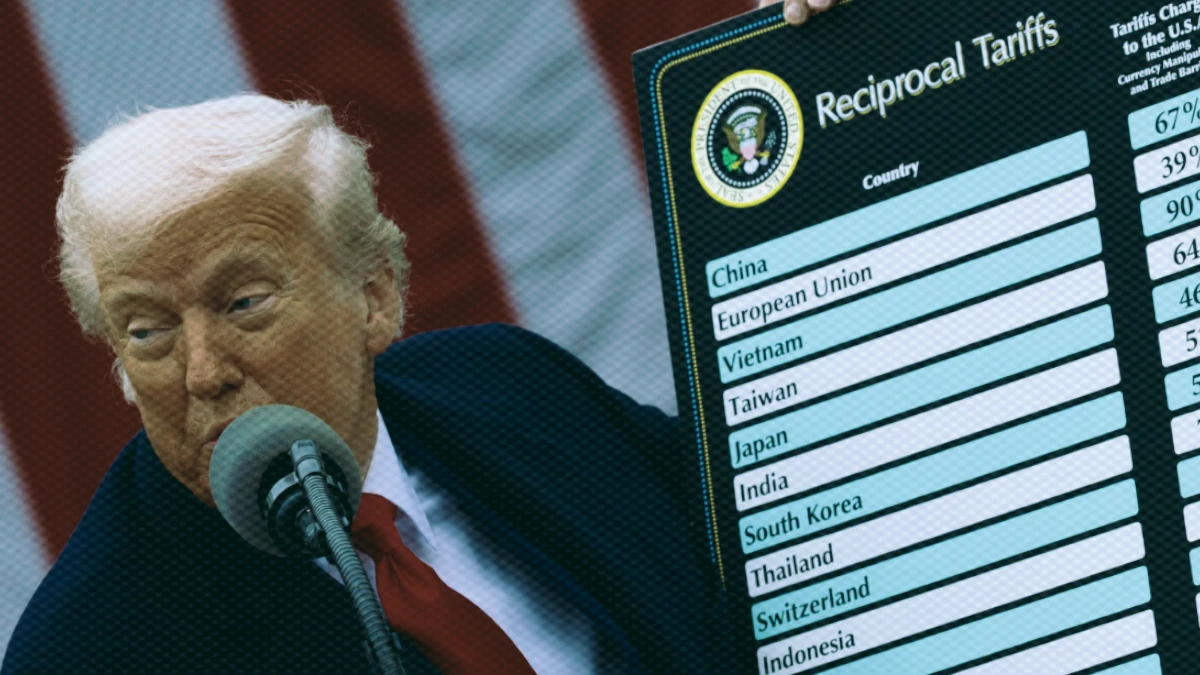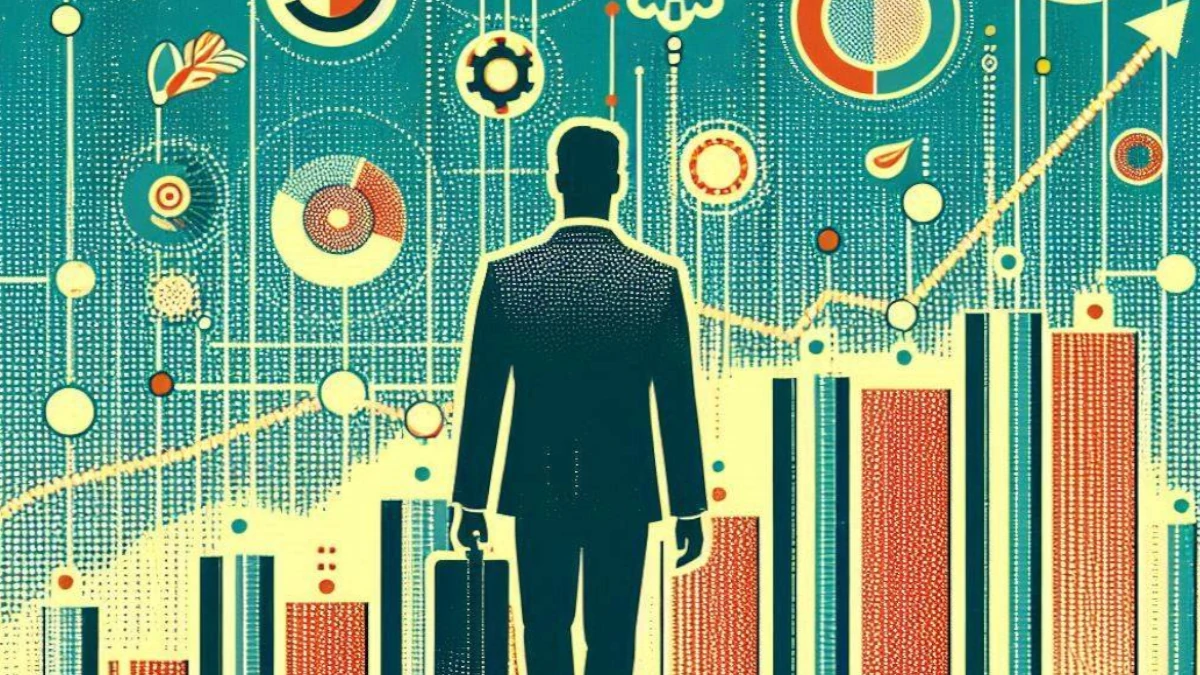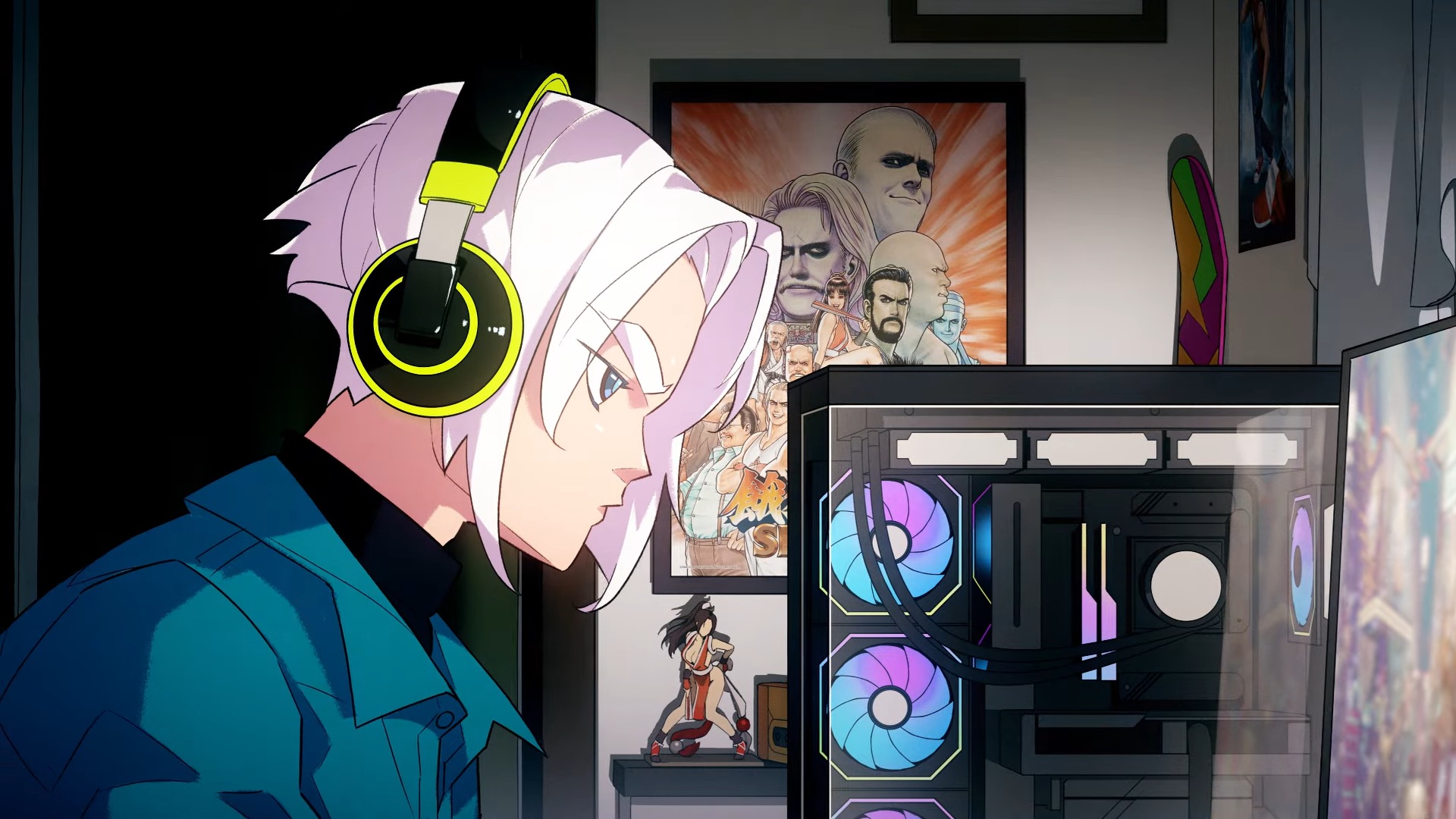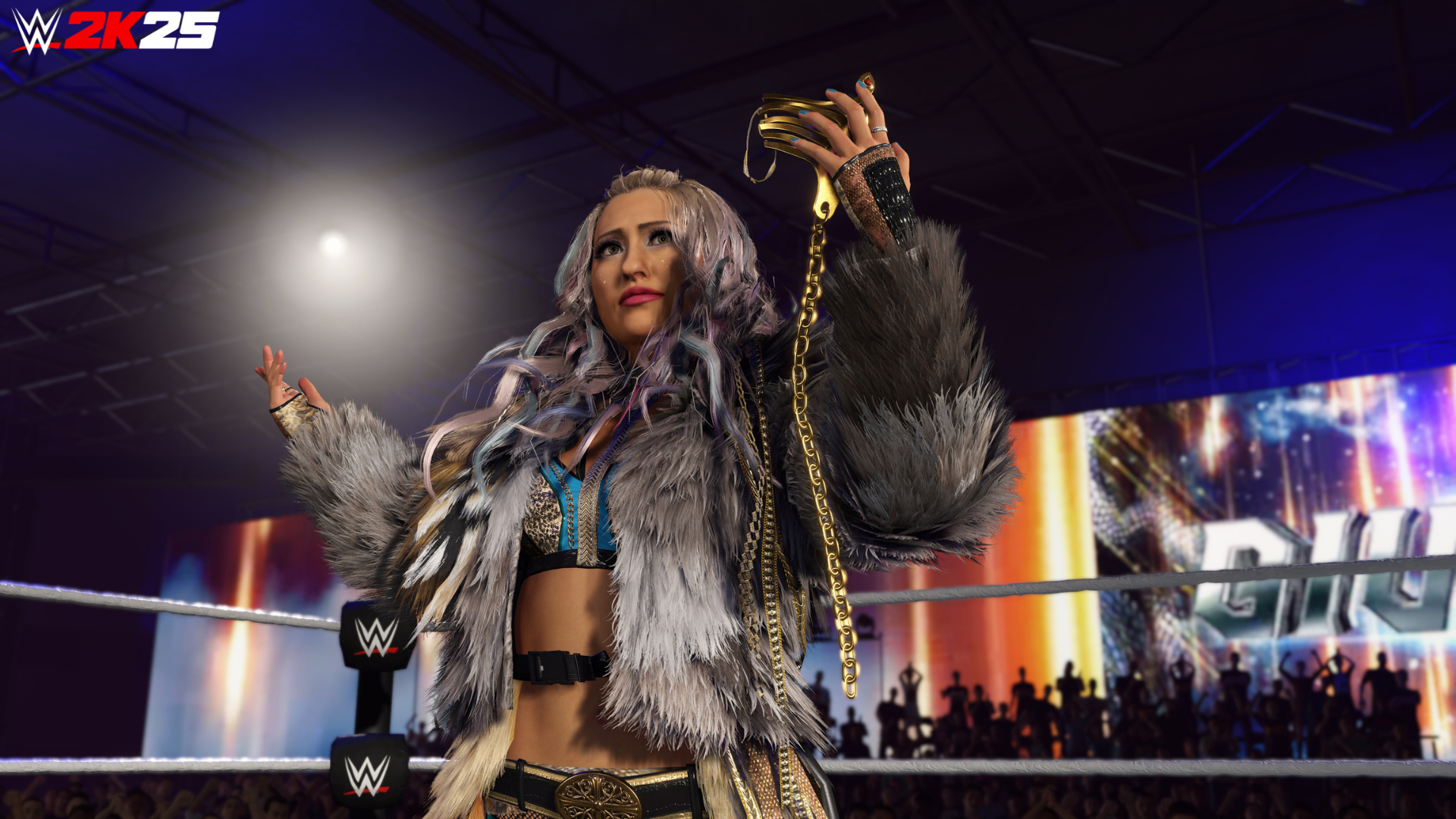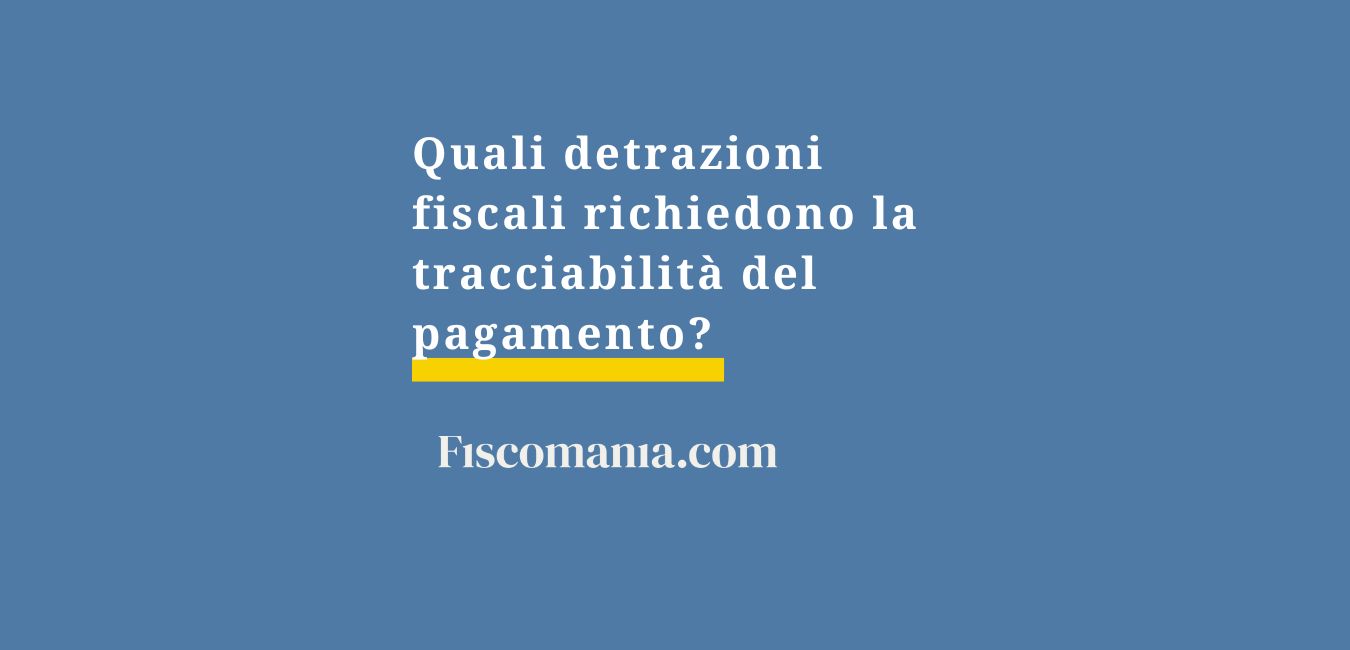The Shrouds – Segreti sepolti di David Cronenberg (2024) o sull’invisibile Niente
The Shrouds – Segreti sepolti (2024) di David Cronenberg si apre con il primo piano di un corpo morto. È il corpo di una donna, illuminata da una luce virtuale […]

The Shrouds – Segreti sepolti (2024) di David Cronenberg si apre con il primo piano di un corpo morto. È il corpo di una donna, illuminata da una luce virtuale (a forma di lucciola) che fluttua sopra di lei: nudo (e in digitale), il corpo di questa donna viene esposto al nostro sguardo; e il nostro sguardo si scopre, volente o meno, fin dalla prima inquadratura, a spiare qualcosa che non dovrebbe essere visto, e che probabilmente noi non avremmo mai voluto vedere. L’interno di una bara, con il suo contenuto putrescente, è infatti una frontiera oltre la quale ogni desiderio scopico difficilmente decide di addentrarsi.
Però siamo lì, in una sala buia, con gli occhi fissi su quel simulacro, mentre condividiamo inquieti (e lo stacco in controcampo ce lo conferma) la posizione osservatrice del protagonista. La cosa quindi, evidentemente, ci riguarda.
E Karsh, interpretato da un Vincent Cassel molto simile al Cronenberg “reale”, è lì con noi, la scruta in nostra vece. Diventato un personaggio noto per avere inventato il “cimitero del futuro”, Karsh possiede infatti un’azienda, la GraveTech, che propone ai suoi clienti Sudari in alta tecnologia, dotati di telecamera virtuale interna capace di spiare il corpo del defunto per renderlo osservabile ogni volta che lo si desideri. Figli, mariti, mogli, amanti…, su app e programmi computer, avrebbero potuto soddisfare il bisogno (Voyeristico, sì) di vedere imputridire i propri cari. Eccoci lì a guardare un cadavere in diretta, come loro.
Le ragioni di Karsh non erano affatto di mero profitto. La GraveTech, e l’ossessione che rappresenta, era nata dopo la morte della moglie Becca, da cui Karsh non si era mai ripreso. Vederla decomporsi, con muscoli e ossa in sfaldamento, giorno dopo giorno, e la carne che rinsecchisce, gliela faceva sentire un po’ più vicina, al drammatico Karsh. Non c’era nulla che lo appassionasse di più… mentre nei sogni l’immagine di lei (una bellissima Diane Kruger) ricompariva nella più erotica e nuda presenza; nuda e tagliata, nuda con le ossa che si frammentano al tatto, nuda e mutilata; perché la vita – questo è il sottinteso – è destinata alla consunzione (memento mori) e ogni bellezza venerea, come in un nuovo barocco della vanità, si sgretola e si deprime in una forma inquietante. Ecco il punto, morboso e toccabile con mano: la fragilità del corpo, l’umano che si degrada nel suo ineluttabile destino: essere-per-la-morte; e basta. Ecco l’ossessione di Karsh, l’ossessione di chi crede che l’invisibile sia semplicemente ciò a cui l’occhio fisico non riesce ad arrivare. Il non-visto materiale della realtà, l’interno oscuro della tomba: GraveTech.
Cronenberg la intravede, questa radice sotterranea, mentre spinge all’ultima frontiera il parossismo scopico cui ci ha abituati da mezzo secolo di critica cosciente alla società dei simulacri. Lo sa: non più solo la nuova carne che implode nell’elettronica (Videodrome 1983), non più solo l’identità che si duplica nel videogame (Existenz 1999); non più solo un’arte tecnologica che muta, bellissimo simbolo della contemporaneità, il corpo dall’interno (Crimes of future 2022). Il confine è l’ultimo, e il più inaccettabile: ora si guarda al cadavere. Sempre più in giù, nel tetro abisso dell’attaccamento folle, per dire il morbo di una cultura (la nostra, quasi sempre) che, ossessionata dalla morte e dalla consunzione della realtà, e incapace di pensare altrimenti la vita, si riduce a un desiderio di guardare che è più un esorcismo catartico che una soluzione possibile. È ancora un Cinema, quello di Cronenberg, assolutamente tragico, tanto impegnato a osservare (e mirabilmente) lo sfacelo morboso della realtà, quanto incapace di proporre, per l’umano che nasce dalle nostre profondità in ricerca, strade di bellezza, e di bene che ce ne possano salvare. Un Cinema che coglie, ancora una volta, e sempre più d’appresso, l’ambigua vicinanza che lega le immagini alla morte, non per sollevarle dalla loro possibile profanazione, ma per esporne nitidamente il delirio. Un cinema del tramonto, che non vuole sperare, come per esempio fa David Lynch, che al fondo dell’abisso, là dove un grido eterno di paura segna irrevocabilmente il mondo (la serie Twin Peaks : the Return, 2017, è emblematica…), il mondo stesso si allarga, si approfondisce, si infinita in chissà quali altre e inattese possibilità di ricerca, e (forse) emersione, o rinascita (magari fuori campo).
In Shrouds invece l’attaccamento alla morte è assoluto come il suo indomabile protagonismo concettuale: schiacciante, avvelenato, ambiguo, mostruoso. Perché non importa di che religione sei, dice Karsh. Ebreo, Musulmano, Buddhista, Cristiano: GraveTech può filmare la tua degradazione carnale. Non importa se c’è un’anima, perché a dominare, e lo dice subito, è una Religione della scienza, che ti promette la soddisfazione di ogni desiderio. E che rende possibile a ciascuno quel miracolo prima inattuabile, l’unico davvero indelebile e “ultimo”, che è vedere l’invisibile, o meglio quell’unico invisibile che si sa pensare nell’età del tardo-nichilismo: ripetiamolo, il Niente della tomba.
Per questo il discorso di Karsh (e Cronenberg, dichiaratamente ateo, è anche sceneggiatore), fin dalle prime battute del film, insiste sulle ragioni immancabilmente a-spirituali del suo intento. I suoi Sudari, dall’elegante estetica giapponese (la forma pura dello Zen, con la sua perfezione astratta e ricorrente, nel film, nasconde bene il tanfo della morte viscerale), non hanno niente a che vedere, dice lui, con il Sudario per eccellenza, la Sindone. Perché la Sindone di Cristo, per Karsh, oltre ad essere un falso, avrebbe pure tradito le sue attese. Pretendendo di mostrare l’invisibile, non aveva fatto che esserne una pallida copia (un po’ platonica); mentre invece i Sudari GraveTech, quelli sì!, dotati di un dispositivo grafico in super HD, con la loro iper-scopica qualità visuale, potevano precisare, modulare, raffinare lo sguardo dettagliato nella tenebra. E vedere la moglie che si dissolve in se stessa. La religione della scienza vince, suggerisce Karsh in controluce, dopo la caduta di un certo orizzonte di senso, che ci ha lasciato sotto un cielo cupo. La morte di Dio… il fallimento di Dio (Quinzio)… il suo apparente eclissarsi dal nostro cuore… in questa apocalisse di inizio terzo millennio. Che forse, il dubbio serpeggia spesso, non saranno solo immagini? Immagini che si consumano come corpi… Immagini della morte e sulla morte… La polvere dell’ambiguità risucchiata nel Niente della storia.
Karsh, in realtà, siamo noi, quando siamo a tal punto terrorizzati dalla vita da attaccarci ai fossili sfuggenti della realtà mummificando la nostra esistenza in un sudario virtuale. Karsh, forse, è anche il Cinema di Cronenberg. È il Cronenberg che ci ha portati molto spesso a vedere quanto è in gioco, della nostra carne, in questo passaggio antropologico epocale; che ci ha insegnato a diffidare delle Sirene del tempo, e a vedere le pieghe sottili della sua ambiguità. È il Cronenberg che ha disilluso i veli di un’immagine mortale. È il Cronenberg a cui siamo grati. Ma il cupo tramonto su cui si chiude The shrouds dice ben più di quanto non mostri. Mentre una nuova umanità albeggia nella notte del nostro tempo, nell’attesa di risplendere verso orizzonti inediti. Così accade che Cronenberg finisca per raccogliere, da mezzo secolo, soprattutto il lato cadente di un mondo che aspetta una nascita nuova. L’alba, che questo Cinema non vuole e non riesce a conoscere, si alza lontana e altrove. Quanto dista la vita dalla morte, la Sindone dai Sudari. Ma Karsh è troppo ossessionato da entrambe per poterla anche solo immaginare.