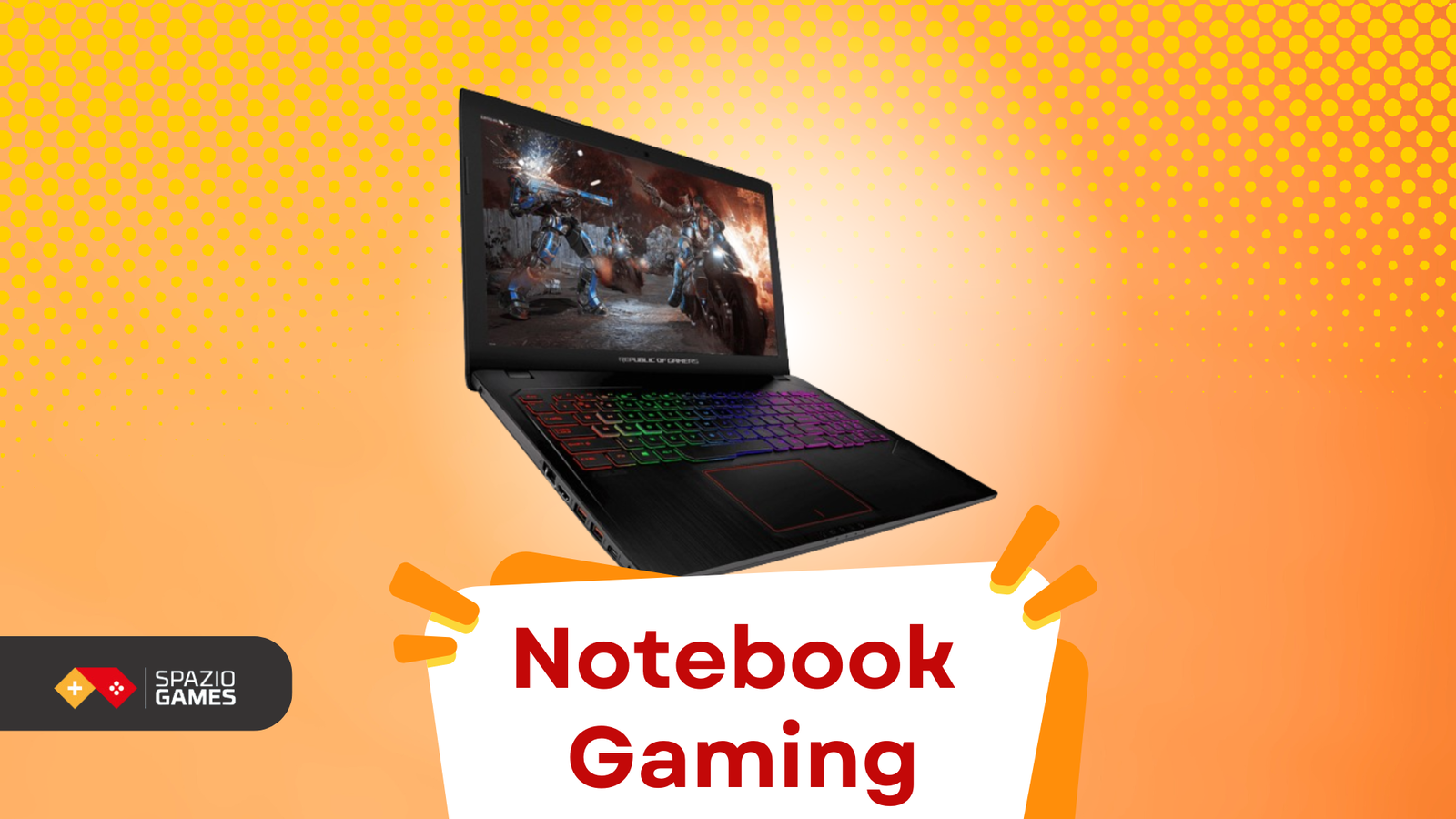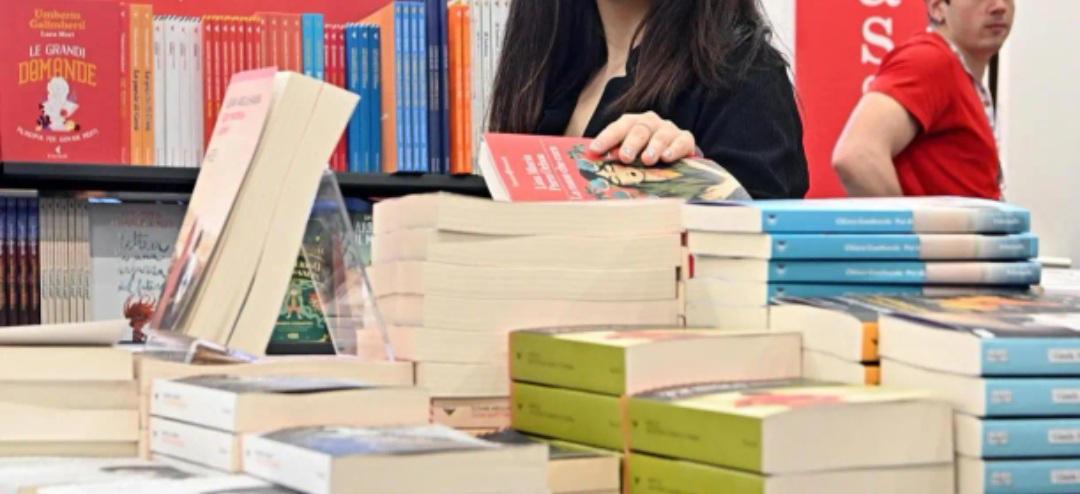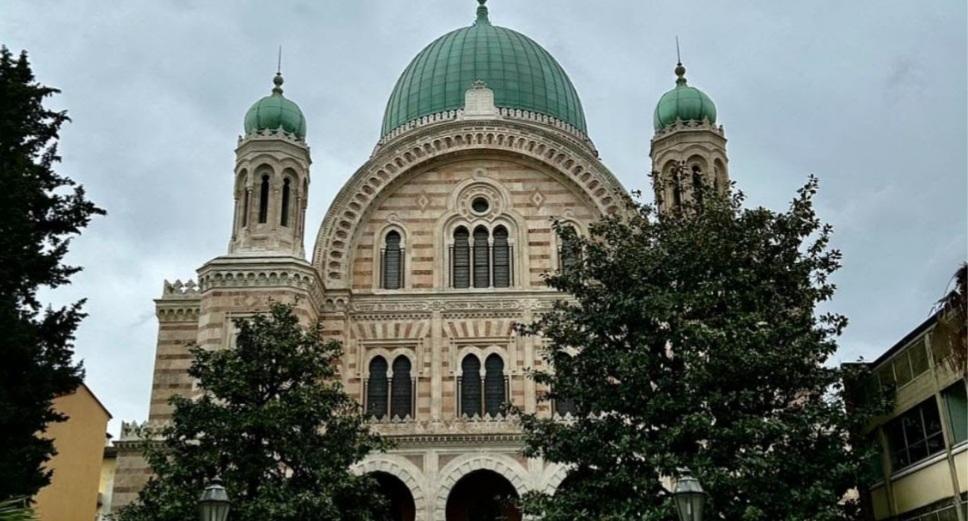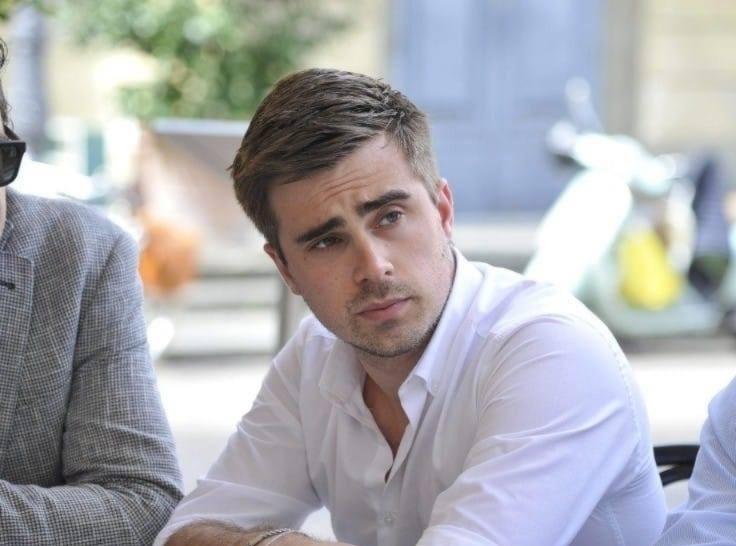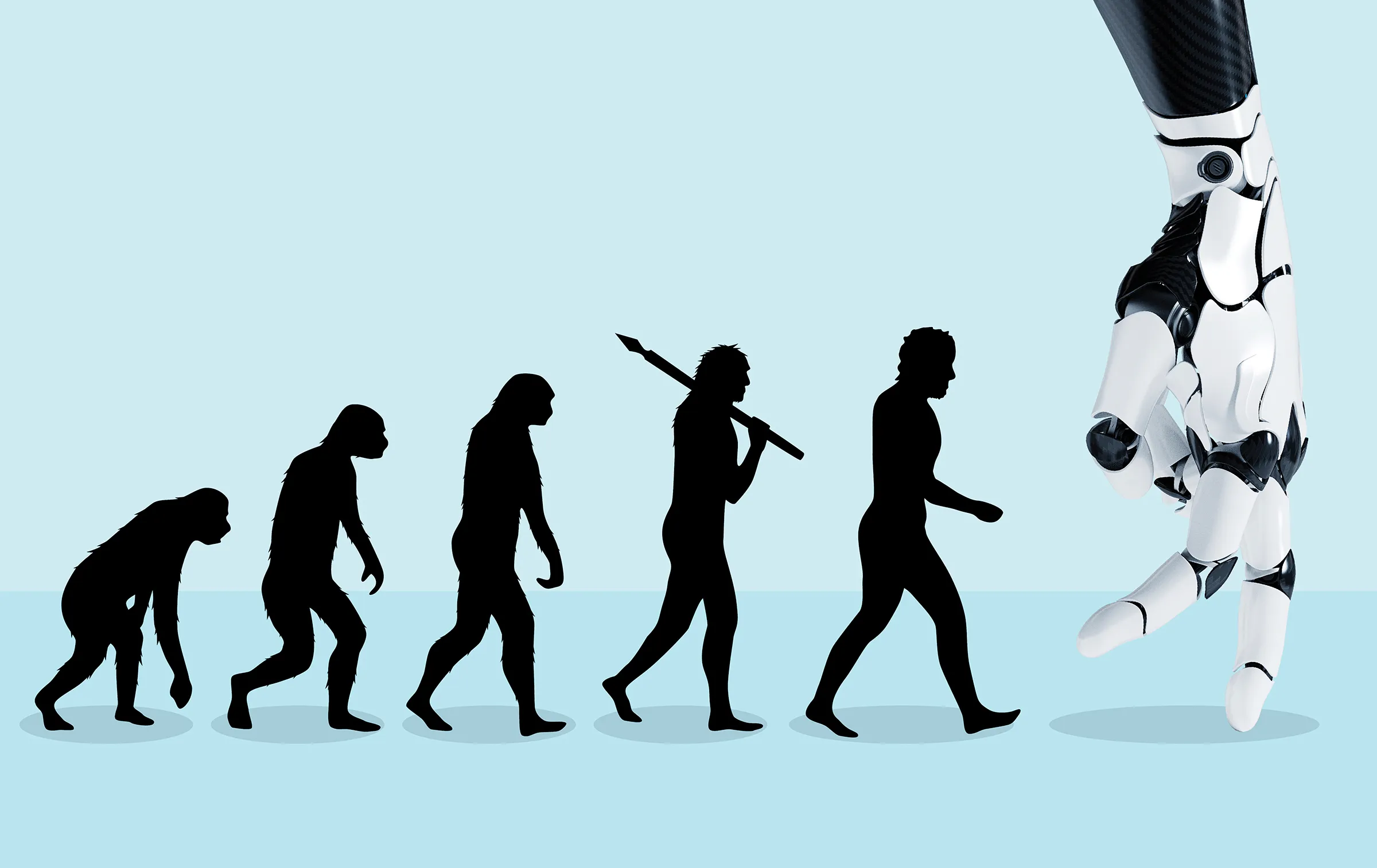Kashmir: la fredda cronaca
Il 22 aprile 2025, un gravissimo attentato – il più letale degli ultimi venticinque anni – ha riacceso la tensione tra India e Pakistan. L’attacco, inizialmente rivendicato e poi smentito […]

Il 22 aprile 2025, un gravissimo attentato – il più letale degli ultimi venticinque anni – ha riacceso la tensione tra India e Pakistan. L’attacco, inizialmente rivendicato e poi smentito da un gruppo armato denominato TRF, The Resistance Front, è stato attribuito dai servizi indiani a Lashkar-e-Taiba, una delle principali formazioni della resistenza kashmira. L’episodio ha innescato una spirale di eventi che ha portato i due storici rivali sull’orlo di un conflitto aperto.
Il giorno successivo all’attacco, l’India ha unilateralmente sospeso il Trattato delle Acque dell’Indo, siglato nel 1960: un accordo vitale per la già fragile economia pakistana, e finora utilizzato come canale di dialogo minimo tra due Stati nati in reciproca ostilità. Nei giorni seguenti, la mobilitazione di truppe lungo la Linea di Controllo (LoC), la chiusura dello spazio aereo ai voli pakistani e una serie di esercitazioni militari hanno lasciato presagire una rappresaglia indiana. Il 7 maggio, la previsione si è avverata: Nuova Delhi ha lanciato l’“Operazione Sindoor” – il sindoor è la polvere rossa che le donne hindu sposate applicano lungo la riga dei capelli, un simbolo religioso che, nella scelta del nome, è stato letto da molti come un segnale identitario.
L’offensiva ha colpito nove obiettivi: cinque nel Kashmir sotto controllo pakistano (Sawal Nala, Syedna Bilal, Gulpur, Barnala e Abbas) e quattro nel Punjab (Bhawalpur, Muridke, Sarjal e Mehmoona Joya). Secondo fonti governative indiane, si trattava di centri di addestramento per Lashkar-e-Taiba e Jaish-e-Mohammed. Nuova Delhi ha dichiarato che gli attacchi hanno colpito esclusivamente obiettivi militari. Islamabad, invece, denuncia la distruzione di edifici civili e una moschea gremita di fedeli. Il 9 maggio il Pakistan ha risposto lanciando sei missili balistici e sciami di droni contro l’India: tutti intercettati. L’India ha replicato bombardando tre basi aeree pakistane. Il 10 maggio è stato raggiunto un cessate il fuoco, che – nonostante accuse reciproche di violazioni – sembrerebbe reggere al momento della stesura di questo articolo (13 maggio).
Nel frattempo, la diplomazia internazionale ha cercato faticosamente di mobilitarsi. Se gli Stati Uniti si sono inizialmente defilati – con Vance che ha liquidato la questione come “not America’s business” – Turchia, Iran e Cina hanno espresso un forte interesse per la stabilità dell’area, ciascuno per ragioni differenti. Tuttavia, il nodo centrale resta irrisolto: l’India considera la questione del Kashmir un affare interno, mentre il Pakistan – consapevole della propria inferiorità militare e industriale – invoca da sempre l’internazionalizzazione del conflitto, facendo leva sulla Risoluzione ONU n. 47 del 1948, che prevedeva un referendum sull’autodeterminazione della regione, mai attuato da Nuova Delhi.
Considerazioni
Per affrontare in modo esaustivo la questione del Kashmir servirebbe una monografia di diverse centinaia di pagine. Anche su un piano puramente divulgativo, la complessità storica, politica e sociale del problema impone cautela. Non potendo offrire qui un’esplorazione approfondita, si propongono alcune coordinate essenziali per orientare la riflessione.
- Il Kashmir è l’unico Stato dell’Unione Indiana a maggioranza musulmana e confina direttamente con il Pakistan. Sin dalla spartizione del 1947, la regione è contesa: la maggioranza della popolazione auspica un’indipendenza che prescinda dall’annessione a uno dei due Paesi. Tuttavia, come i Melii della Grecia antica, i kashmiri non hanno mai potuto decidere del proprio destino, schiacciati dagli interessi strategici altrui.
- India e Pakistan hanno combattuto quattro guerre in 75 anni: tre scatenate da dispute sul Kashmir, la quarta conclusa con un trattato che ha stabilito l’attuale Linea di Controllo (LoC), la frontiera de facto che divide il territorio.
- Negli anni ’80, il Pakistan ha sostenuto militarmente l’indipendentismo kashmiro, contribuendo alla progressiva confessionnalizzazione del conflitto.
- In questo contesto, nel 1990, si è consumato l’Esodo dei Pandit: decine di migliaia di kashmiri di religione hindu, appartenenti in genere all’élite locale, sono stati costretti a fuggire a causa di un clima di odio intercomunitario. Si stima che tra 160.000 e 180.000 persone abbiano trovato rifugio in campi profughi. L’intervento dell’esercito, disposto da Nuova Delhi con la President’s Rule, giunse troppo tardi.
- Durante i governi del BJP, il Kashmir è stato oggetto di una strategia di “hinduizzazione” attraverso incentivi all’acquisto di terreni, investimenti infrastrutturali e turismo. Il culmine è arrivato nel 2019, con il “Lockdown”: il 5 agosto, l’articolo 370 della Costituzione – che garantiva lo statuto speciale alla regione – è stato revocato. Il Kashmir è stato isolato dal resto del mondo: coprifuoco militare, blocco delle comunicazioni, soppressione di internet, posta, trasporti. Lo Stato è stato diviso in due territori governati direttamente da Nuova Delhi. Solo dopo due anni è stata ripristinata una parvenza di normalità, fondata su investimenti statali, repressione del dissenso e un processo di “colonizzazione interna”.
La situazione è altamente fluida e densa di variabili: il contesto demografico rende ogni previsione azzardata. Ciò che colpisce è il livello di strumentalizzazione politica della crisi. Entrambi i Paesi sono governati da leadership che traggono forza da opinioni pubbliche polarizzate. In Pakistan, i militari cercano di compattare la nazione dopo l’arresto del popolare Imran Khan; in India, Modi continua a fondare il proprio consenso sulla retorica religiosa e sull’identificazione del “nemico interno” nella minoranza musulmana. Subito dopo l’attentato del 22 aprile, centinaia di migliaia di permessi di lavoro per cittadini pakistani sono stati revocati, alimentando l’equazione musulmano = pakistano = nemico.
La narrazione mediatica riflette (e rafforza) questa polarizzazione. Nei media indiani – che siano TV, testate digitali o canali YouTube – è quasi impossibile trovare toni non propagandistici. In Pakistan, la situazione è analoga. L’intossicazione del dibattito pubblico è tale che persino le voci critiche, per sopravvivere, devono premettere il proprio patriottismo o allinearsi a valori religiosi dominanti. Un aspetto rivelatore è quello linguistico: la comunicazione ufficiale indiana cambia tono a seconda della lingua. In genere, l’inglese – rivolto al pubblico internazionale – adotta toni più sfumati. In questo caso, invece, anche le dichiarazioni in inglese hanno assunto una coloritura bellicista, segnale preoccupante della radicalizzazione del discorso pubblico.
Prospettive internazionali
Dal punto di vista geopolitico, va considerato il ruolo della Cina, legata al Pakistan da interessi strategici. Il corridoio economico Cina–Pakistan (CPEC), parte della Belt and Road Initiative, attraversa l’Himalaya e raggiunge il porto di Gwadar: un nodo fondamentale per gli investimenti cinesi nell’area. Un Kashmir completamente sotto controllo indiano rappresenterebbe una minaccia diretta a questi interessi. Questa sola variabile rende improbabile un conflitto su larga scala: in passato, le guerre indo-pakistane hanno sempre avuto un’estensione limitata. Inoltre, Nuova Delhi non può permettersi di entrare in rotta di collisione con Pechino.
Più verosimilmente, l’India mira a utilizzare la crisi per stralciare definitivamente il trattato sulle acque dell’Indo e sbloccare progetti idrici finora impediti dal meccanismo di veto reciproco previsto dall’accordo. In questo modo, Nuova Delhi potrebbe accrescere la propria leva negoziale sul Pakistan attraverso il controllo delle risorse idriche, fondamentali per l’agricoltura e la sussistenza del Paese vicino.
Se allarghiamo ulteriormente la prospettiva – dalla politica internazionale alla geostrategia – diventa necessario inquadrare il conflitto nel più ampio processo di riposizionamento globale post-egemonia statunitense. Stabilire gli assetti futuri è complicato, ma un principio rimane valido: è la geografia a fare la storia, e non il contrario. L’Asia centro-meridionale è da secoli un crocevia strategico: ieri contesa tra britannici, russi e ottomani; poi campo di confronto tra americani e sovietici; oggi terreno di competizione tra potenze emergenti in un mondo multipolare ancora in fase di assestamento.
Il Pakistan, da sempre alleato degli Stati Uniti, è diventato una pedina essenziale per la Cina, che lo considera un partner chiave per la sicurezza e la logistica dei suoi corridoi commerciali. Allo stesso tempo, Washington ha progressivamente spostato il proprio interesse verso l’India, vista come baluardo potenziale contro l’espansionismo cinese nell’Indo-Pacifico. Questo doppio allineamento crea un equilibrio instabile, ma per ora funzionale a evitare l’escalation.
Singolare – ma geopoliticamente rilevante – è anche l’asse informale tra India e Israele. La stampa indiana ha coniato per essa il termine bromance, fusione tra brotherhood e romance, per descrivere il rapporto tra Modi e Netanyahu. L’India guarda con attenzione alla gestione israeliana della questione palestinese, pur sapendo che – data l’enorme popolazione musulmana presente sul proprio territorio – l’applicazione di modelli simili sarebbe, se non impossibile, certamente destabilizzante.
Infine, attori regionali come Turchia e Iran osservano con crescente preoccupazione l’instabilità kashmira. Dopo il collasso siriano, un ulteriore punto di rottura in Asia meridionale costituirebbe un grave colpo agli equilibri regionali. Non a caso, Teheran – pur alle prese con forti pressioni internazionali, la successione di Khamenei e i negoziati sul nucleare – ha intrapreso fin dall’inizio della crisi uno sforzo diplomatico non indifferente.
Conclusione
In un quadro globale già segnato da molteplici focolai di tensione – da Gaza a Kiev, dallo Yemen al Mar Cinese – l’apertura di un nuovo fronte potenzialmente esplosivo come quello kashmiro è quanto di meno auspicabile. Eppure, nella logica di un ordine internazionale in profonda trasformazione, ogni crisi locale rischia di diventare un tassello di una più ampia redistribuzione dei poteri. E in questo risiko mondiale, il Kashmir torna a essere, come sempre, più campo che giocatore.
Non ci facciamo mancare nulla.