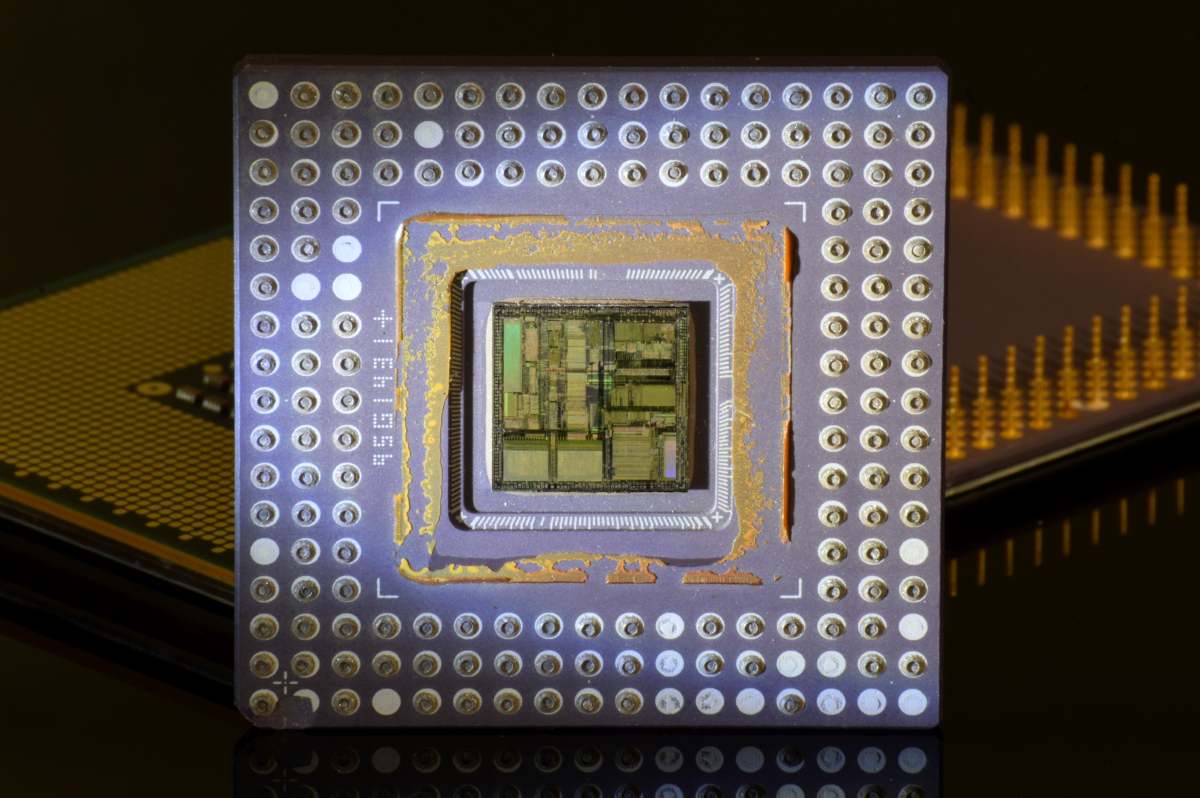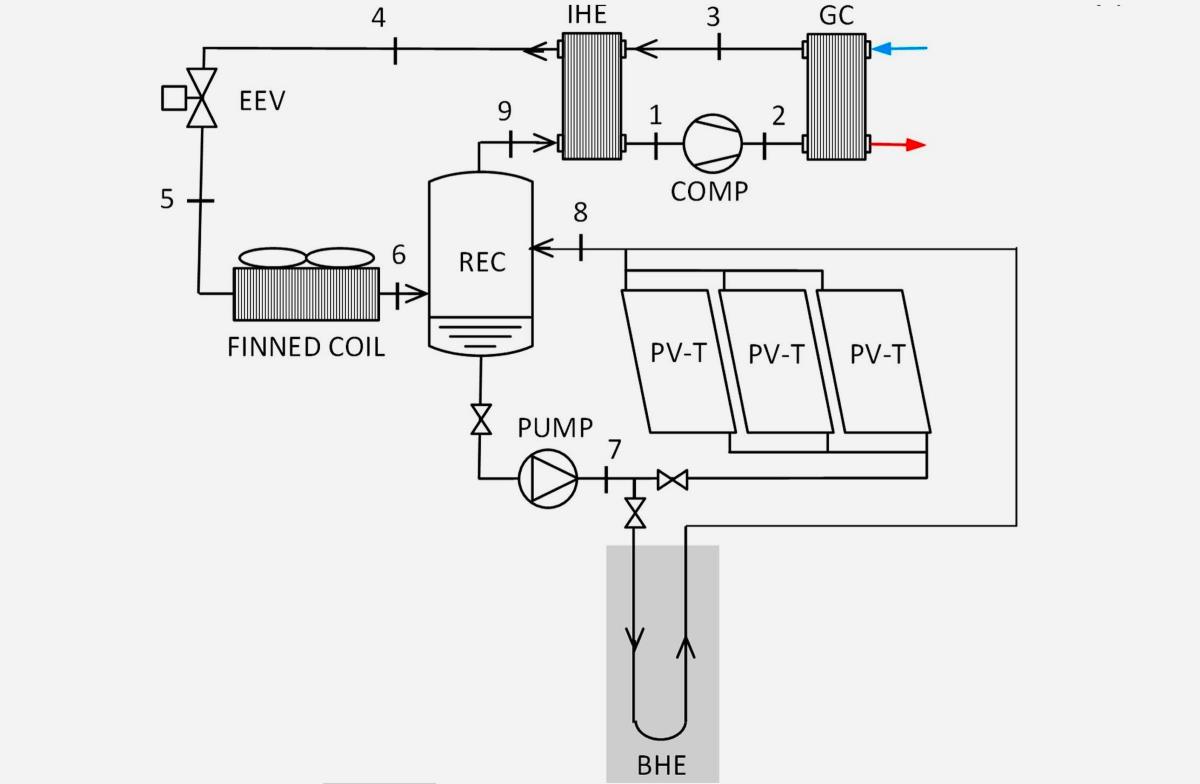Siamo soli e senza soldi. Abbiamo bisogno di più spazi sociali ma ce li tolgono.
In città come Bologna, Milano, Roma o Firenze, i cosiddetti “terzi luoghi”, cioè posti dove poter stare insieme senza essere costretti a consumare, stanno scomparendo sotto il peso della gentrificazione e di città modellate sempre più sulle esigenze di turisti ricchi. Eppure, in un periodo in cui siamo sempre più soli e senza soldi, sono fondamentali per la nostra vita. L'articolo Siamo soli e senza soldi. Abbiamo bisogno di più spazi sociali ma ce li tolgono. proviene da THE VISION.

Studiare a Bologna durante gli anni Zero è stato un grande privilegio, ma anche un motivo di confronto amaro con tutto ciò che è venuto dopo. Per quanto la Rossa non fosse più la patria indiscussa della controcultura che era stata nei decenni precedenti – e chi li aveva vissuti non mancava mai di fartelo notare, snocciolando gli aneddoti più incredibili –, la sua dimensione di paesone di sinistra pieno di fermento culturale ha reso la mia esperienza universitaria un periodo di arricchimento assoluto. Ricordo con nostalgia soprattutto l’uso libero che noi studenti potevamo fare degli spazi cittadini per conoscerci e confrontarci – principalmente piazze, centri sociali e parchi, ma anche enormi e moderne biblioteche pubbliche, come la Sala Borsa.

Le cose, poi, sono cambiate. Alcuni anni dopo la mia laurea, dall’ufficio milanese della multinazionale americana per cui lavoravo, ho praticamente pianto alla notizia che il writer BLU aveva cancellato tutte le sue opere blognesi per protesta contro la gentrificazione, e ho assistito con tristezza alla diretta Facebook dello sgombero dell’XM24, uno dei centri sociali più simbolici e vissuti della città. Un paio di segnali che, per quanto avesse ancora un certo respiro progressista, Bologna stava cambiando insieme all’Italia tutta, diventando sempre più simile a città escludenti come Milano, dove lo spazio vissuto collettivamente è ridotto all’osso.
Con il passare del tempo, poi, anche le poche isole felici che ho trovato a Milano stanno venendo pian piano a mancare, lasciando il posto a una feroce e rapida gentrificazione. Nelle prossime settimane, anche il centro sociale Leoncavallo SPA, punto di riferimento dell’underground italiano da 50 anni, potrebbe essere sgomberato dalla sua sede di via Watteau. E se le minacce di sfratto, negli anni, sono state più di 130, questa volta la questione sembra più seria del solito. La sentenza, dopo la denuncia da parte di proprietari dello stabile, che condanna il ministero dell’Interno per 3 milioni di euro per un mancato sgombero, suggerisce che stavolta il Leo sia destinato a spostarsi in una zona più defilata o a finire. E con la caduta di uno degli ultimi baluardi della socialità militante, il dominio delle vinerie-con-cucina, a Milano, è destinato a diventare una dittatura.

Il Leoncavallo è forse il centro sociale più famoso d’Italia – secondo la leggenda frequentato, in gioventù, persino da Matteo Salvini – ed è un punto di riferimento per migliaia di milanesi (e non solo), di tutte le età ed estrazioni sociali. Dopo le ultime minacce di sgombero, quindi, i presidi sono stati numerosi e partecipati, e personalità famose della cultura italiana – da Neffa a Samuel dei Subsonica – si sono espresse sui social in solidarietà con lo spazio autogestito. Tutto questo, tuttavia, difficilmente basterà per salvare l’occupazione del bellissimo e decadente edificio di via Watteau.
Del resto, negli ultimi anni, gli appassionati di spazi militanti hanno assistito alla triste decadenza di numerosi altri luoghi leggendari, con una serie di sgomberi che hanno colpito città sempre più inaccessibili e instagrammabili. Tra gli altri, sono venuti a mancare punti di riferimento importanti come l’Ex Asilo di Torino, l’XM24, Labas e l’Atlantide di Bologna, Macao e Casaloca a Milano. Luoghi che per anni hanno plasmato e conferito valore culturale alle città in cui si trovavano anche a livello internazionale, organizzando eventi e manifestazioni, continuando a perpetrare una certa cultura anti-sistema su più livelli. Inspiegabilmente visti – da chi non li frequenta – come dei posti di degrado ed evitati come se trasmettessero virus pericolosi, gli spazi occupati tengono vive scene musicali, culturali e persino sportive, ospitando gli eventi più disparati a prezzi popolari, dai festival di gaming ai corsi di italiano per stranieri – colmando, in questo, diverse lacune dello Stato.

Nelle ultime settimane, complice un caso legato alla turistificazione delle sale cinematografiche dismesse della città di Roma, si sta parlando molto dei cosiddetti “terzi luoghi”, ovvero spazi urbani di socialità, diversi dalla casa e dal lavoro, dove le persone possono interagire, socializzare e costruire comunità. Il dibattito a riguardo è molto vivo – ma, per quanto mi riguarda, non abbastanza – anche perché questo genere di luoghi, un tempo vissuti e condivisi, sta scomparendo sotto il peso della gentrificazione e dell’esigenza di sfruttare ogni metro quadro di suolo cittadino per aumentare il profitto di pochi ed escludere i più. Eppure, frequentare uno spazio di libertà e socializzazione è fondamentale per la nostra vita quotidiana.
L’idea del terzi luoghi è stata teorizzata per la prima volta nel 1982 dai sociologi statunitensi Ramon Oldenburg e Dennis Brissett, e da allora è diventata una lente utile per capire cosa ci manca in questo preciso momento storico. Questi luoghi infatti possono essere bar, ristoranti o librerie, ma anche biblioteche, centri culturali o spazi occupati, insomma posti dove non sei costretto a consumare qualcosa per sentirti parte di un contesto. L’importante è che siano poco costosi, informali, comodi e vicini – tanto da poterci andare spesso, anche solo per passare del tempo in compagnia. Oldenburg e Brissett sostenevano che frequentare questi spazi contribuisse in modo decisivo al nostro benessere, dandoci un senso di completezza, di identità, di libertà espressiva. Sono ambienti dove si incontrano persone diverse, dove succedono cose nuove, dove si può essere sé stessi senza dover recitare una parte.

Se penso a Milano, oggi, direi che questi terzi luoghi sono sempre più rari. Forse li ritroviamo in qualche bar di quartiere che resiste al tempo o in qualche vecchia parrocchia – per gli appassionati del genere – che ha mantenuto un’anima sociale. Nella maggior parte dei casi, purtroppo sono spazi che vengono trasformati in università private, bistrot e coworking. E con loro rischia di sparire anche un pezzo importante della nostra possibilità di vivere davvero la città senza sentirci poveri e smarriti. Tenere vivi degli spazi che non portano denaro, nell’urbanistica contemporanea, è sempre più impensabile. E la tolleranza nei confronti di ciò che è fuori dalle regole del sistema capitalista è prossima allo zero. Anche tra le persone stesse l’abitudine di manifestare, seguire le controculture, ritagliarsi degli spazi di libertà senza doversi necessariamente svenare in un cocktail bar sembra stia cedendo il passo a una rassegnazione che le lascia con pochi spiccioli in tasca e poco divertimento sulle spalle. E il paradosso è che chi spende 70 euro per un concerto o per una cena tutto sommato mediocre molto spesso vive al di sopra delle sue possibilità. Molti ormai si sono rassegnati all’idea che passare del tempo di qualità con amici e conoscenti – o con persone con cui si hanno delle passioni in comune – voglia spesso dire consumare degli aperitivi veloci in posti in cui alle 20:45 ti chiedono di liberare il tavolo per la cena.

La mancanza di spazi di socialità tout court, in cui il punto non è degustare un piattino di asparagi selvatici con un bicchiere di orange, sta lentamente erodendo la socialità cittadina aumentando la solitudine percepita. Per coltivare delle amicizie che si possano definire tali, per esempio, non basta un aperitivo al mese in un posto alla moda a 30 minuti da casa. Eppure il sistema ci sta portando in questa direzione. Per quanto ogni legame abbia un suo equilibrio, il fatto di non avere dei punti d’incontro definiti e a basso costo è un tema, soprattutto in periodi di recessione come questo. Senza scomodare l’agorà dell’antica Grecia, è evidente che città modellate su turisti spendenti come quelle italiane abbiano perso del tutto la loro anima sociale. E la chiusura di spazi storici come il Leoncavallo è parte integrante di questo cambiamento, ma sarebbe più giusto parlare di declino.
Oggi i social media e le app di incontri – non per forza romantici, ormai ce n’è di tutti i tipi –, offrono una parvenza di connessione con gli altri, ma la presenza fisica, la possibilità di costruire relazioni randomiche e di vicinanza è un fattore che manca fortemente. Non a caso, stando ai dati più recenti, il 95% dei giovani in Italia è convinto che l’utilizzo di device tecnologici vada limitato per preservare la propria salute mentale. E molti nativi digitali occidentali, dalla Gen Z in poi, stanno iniziando a rimpiangere i rapporti non mediati virtualmente, ormai rarissimi, in favore del caro vecchio contatto umano.

Per stare fisicamente insieme, però, c’è bisogno di uno spazio condiviso, e non è mai stato tanto chiaro quanto in questo periodo di frammentazione e solitudine strutturale. Di per sé, l’idea di occupare un edificio inutilizzato nasce appunto dalla volontà di riappropriarsi dei luoghi dal basso per poterli utilizzare in modi non previsti dal sistema capitalista. Con questa motivazione, il 18 ottobre 1975, dopo un corteo, un gruppo di giovani occupò illegalmente un’ex fabbrica abbandonata da dieci anni nel quartiere Casoretto, in via Leoncavallo. Da quel momento, il centro sociale Leoncavallo è stato protagonista di momenti cruciali per la sua storia e per i Movimenti in Italia: dai festival di parco Lambro all’impegno delle Mamme Antifasciste contro la tossicodipendenza. Nel periodo storico che stiamo vivendo, invece, la percezione è che la storia si sia spostata altrove. Oppressi anche da leggi liberticide, come il decreto rave e il DL sicurezza, che di fatto inasprisce le pene per qualsiasi attività che non rientri nelle grazie della destra, sembra che ci siamo rassegnati alla completa passività. Eppure, passiamo le nostre serate libere a degustare vino in posti chic per poi nutrirci di prodotti da discount nella tranquillità delle nostre cucine perché è l’unico modo per evitare di avere il conto in rosso. E nonostante questa situazione insostenibile e a tratti degradante, ora come ora, la spinta verso la reclamazione degli spazi è ancora da venire. La speranza che prima o poi accada, tuttavia, è sempre accesa.
L'articolo Siamo soli e senza soldi. Abbiamo bisogno di più spazi sociali ma ce li tolgono. proviene da THE VISION.