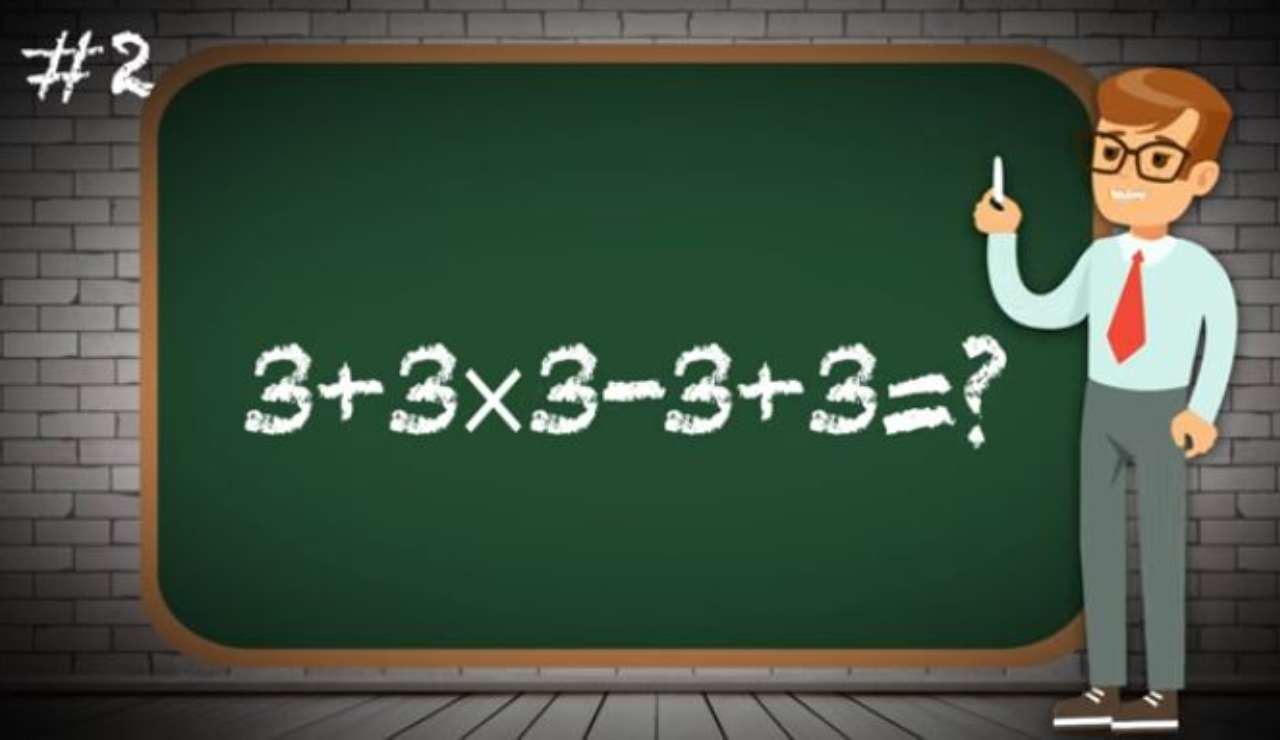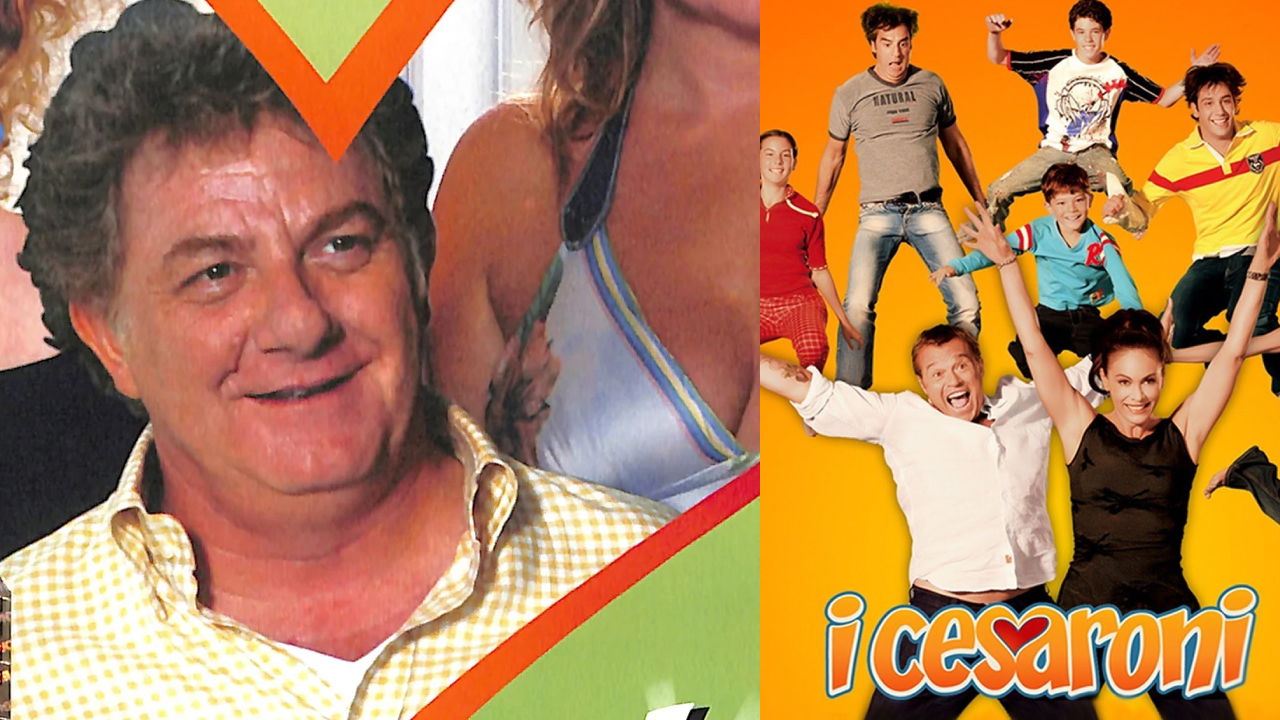Sgorbissa, UniGe: «Ecco le potenzialità dei robot nella sanità»
L’impiego dei robot umanoidi nell’assistenza sanitaria è una prospettiva che solleva interrogativi tecnici, etici e sociali. Non si tratta solo di sviluppare macchine capaci di interagire con le persone, ma di garantire affidabilità e sicurezza in contesti delicati come ospedali e strutture per anziani. Dalla capacità di comprendere e rispondere ai bisogni dei pazienti alla […] L'articolo Sgorbissa, UniGe: «Ecco le potenzialità dei robot nella sanità» proviene da ilBollettino.

L’impiego dei robot umanoidi nell’assistenza sanitaria è una prospettiva che solleva interrogativi tecnici, etici e sociali. Non si tratta solo di sviluppare macchine capaci di interagire con le persone, ma di garantire affidabilità e sicurezza in contesti delicati come ospedali e strutture per anziani.
Dalla capacità di comprendere e rispondere ai bisogni dei pazienti alla necessità di dimostrare un impatto clinico misurabile, la strada per l’integrazione degli automi nella sanità è ancora lunga. Se da un lato queste tecnologie promettono di supportare il personale medico e migliorare la qualità della vita dei pazienti, dall’altro emergono resistenze culturali e dubbi sull’effettiva utilità di questi sistemi.
«La principale obiezione di chi guarda con scetticismo a queste tecnologie è la riluttanza ad affidare ai robot mansioni sensibili, tradizionalmente basate su relazioni umane» dice Antonio Sgorbissa, Professore Ordinario presso l’Università degli Studi di Genova, fondatore e direttore del RICE lab (Robots and Intelligent systems for Citizens and the Environment).

Quali sono le caratteristiche principali di un robot umanoide pensato per l’assistenza sanitaria?
«Come per qualunque robot destinato a contesti reali, è l’affidabilità, cioè la capacità di comportarsi in maniera ripetibile. Nessuno acquisterebbe un frigorifero che funziona un giorno su sette o un’auto che frena occasionalmente. Nonostante la ricerca robotica abbia prodotto sistemi interessanti per interagire con le persone in ambito sanitario, raramente questi sono del tutto prevedibili e affidabili. Ad esempio, un robot umanoide per l’assistenza agli anziani non deve per forza svolgere lavori domestici, un’immagine spesso stimolata dal cinema e dalla letteratura.
Un automa capace di conversare, anche se non pulisce i pavimenti, può comunque aiutare a stimolare le capacità cognitive e ridurre l’isolamento. Ma anche un robot che “fa solo conversazione” deve essere affidabile: funzionare in ambienti rumorosi, comprendere anziani con difficoltà nel parlare chiaramente, essere comprensibile e rispondere in modo appropriato. Nella ricerca robotica sappiamo che il vero problema non è tanto cosa la macchina sa fare, quanto con quale affidabilità lo faccia, soprattutto in ambito sanitario, dove la responsabilità verso persone fragili e società è cruciale».
In che modo si differenzia da altri sistemi di automazione già in uso?
«I robot sociali sono progettati per interagire con le persone tramite parole, gesti, postura ed espressioni facciali. Si differenziano così da altri tipi, come quelli industriali, quelli usati per trasportare materiali in ospedale, gli esoscheletri o i dispositivi chirurgici, molto diffusi oggi in ambito sanitario (come il sistema da Vinci).
Non tutti i robot sociali hanno la capacità di riprodurre espressioni facciali: alcuni, come il popolare Furhat, proiettano un volto animato su uno schermo. Tuttavia, più dell’hardware, è la capacità di agire autonomamente e di mostrare un’apparente “intelligenza” a fare la differenza. Pensati per assistere anziani e bambini o per accogliere visitatori in musei e negozi, i robot sociali interagiscono spontaneamente, stimolando le persone a conversare e creando un legame più profondo rispetto ad altri sistemi automatizzati. Per questo risultano affascinanti e talvolta controversi».

In quali ambiti dell’assistenza sanitaria si potrebbe avere un impatto più significativo?
«Sicuramente nella cura delle persone anziane, di quelle affette da alcune forme di demenza, dalle persone che hanno lesioni al midollo spinale o hanno mobilità ridotta per altre cause. Attualmente, per esempio, siamo sul punto di cominciare un nuovo studio in collaborazione con l’Ospedale San Martino di Genova, finalizzato alla prevenzione del delirium nelle persone anziane ricoverate in ospedale. Si manifesta come uno stato di confusione, con perdita di connessione con la realtà. Chi ha un genitore sopra una certa età che è stato ricoverato in ospedale, ha purtroppo una buona probabilità di fronteggiare la situazione.
L’idea è quella di utilizzare robot sociali per la conversazione, in modo che possano tenere compagnia alle persone ospedalizzate per lunghi periodi, stimolandole periodicamente tramite protocolli orientativi finalizzati a ripristinare il legame con il “qui e ora” che può venire a mancare. Il robot chiacchiera con la persona degli argomenti più disparati, privilegiando gli argomenti di discussione che sa essere di particolare interesse per la persona: un appassionato di letteratura russa, ad esempio, si troverà un automa in grado di parlare di Dostoevskij, un appassionato di sport potrà passare il tempo scambiando opinioni sulle discipline e gli atleti più popolari».

Quali sono le principali difficoltà tecniche ancora da superare prima che i robot umanoidi possano essere utilizzati su larga scala negli ospedali?
«Innanzitutto, è necessario dimostrarne concretamente l’utilità. Nonostante numerosi studi, mancano ancora prove definitive e misurabili dell’impatto sulla salute, ottenibili solo tramite trial clinici con più partecipanti e protocolli rigorosi, simili a quelli usati per approvare nuovi farmaci. Tuttavia, la sperimentazione è complicata da limiti tecnici: i robot sociali, per quanto avanzati, spesso presentano malfunzionamenti che, sebbene non pericolosi, compromettono l’efficacia terapeutica. Molti problemi potrebbero essere risolti con investimenti significativi, necessari per industrializzare tecnologie ancora in fase prototipale. Tuttavia, l’interesse degli investitori dipende proprio dalla disponibilità di dati solidi sull’efficacia, ottenibili solo con sperimentazioni ampie e rigorose. È un circolo vizioso che potrà spezzarsi solo quando un investitore deciderà di correre il rischio».
Quali sono le principali resistenze etiche e culturali all’uso in ospedale?
«Le resistenze esistono, ma sono meno frequenti del previsto. Noi stessi abbiamo collaborato con geriatri, psichiatri, infermieri ed esperti di scienze dell’educazione, scoprendo spesso che avevano idee persino più avanzate delle nostre sui possibili benefici dell’uso. Chi è diffidente sostiene che affidare a macchine compiti delicati, specialmente nella cura di persone fragili, comprometta il necessario rapporto umano.
Nei nostri esperimenti, però, abbiamo visto anziani protestare quando dovevamo portare via il robot dalla loro stanza, o raccontare a queste macchine episodi personali con evidente entusiasmo. Quando si sostiene che un robot per la conversazione migliori l’umore degli anziani, spesso ci si sente rispondere che si tratta di un “inganno”. Tuttavia, anche un videogioco, un film, un libro o una canzone che suscitano emozioni sono inganni simili. Scegliere consapevolmente di ingannare le emozioni, o semplicemente di passare piacevolmente il tempo, è del resto una prerogativa profondamente umana».

Come si sta preparando il personale medico a lavorare a fianco di questi dispositivi?
«Al momento non esiste una casistica sufficiente per conclusioni generali sulle reazioni all’uso. Contrariamente allo stereotipo dei lavoratori spaventati dal rischio di essere sostituiti, le reazioni sono molto diverse: alcuni manifestano simpatia per i robot, altri sono meno entusiasti, come avviene con ogni tecnologia.
Tuttavia, nessuno percepisce attualmente queste macchine come una minaccia reale, data la loro diffusione ancora limitata. Quando il personale sanitario incontra robot meno efficienti del previsto, spesso ne è sollevato, comprendendo che i timori diffusi dai media tendono a essere esagerati. Di fronte all’esperienza diretta, infatti, le paure si ridimensionano. Alcuni, invece, si oppongono alle macchine per ragioni etiche, sostenendo che non sia accettabile sostituire persone con macchine incapaci di una reale cura, anche se questo argomento resta poco chiaro».
Crede che in futuro la presenza di robot nell’assistenza sanitaria sarà percepita come una risorsa o esiste il rischio che venga vista come una sostituzione del personale umano?
«Come succede per ogni nuova tecnologia, nel breve termine sarà necessario porre molta cura al fine di evitare distorsioni, difendendo i diritti dei lavoratori e dei pazienti. Non sarà facile, ovviamente, perché gli interessi in gioco sono molti e differenti. Ma è sbagliato pensare che questo problema riguardi solo la robotica: è quello che succede ogni qual volta una nuova tecnologia diventa accessibile e in grado di replicare quello che fa il personale umano con un costo ridotto – e magari in maniera più affidabile e sicura.
Di conseguenza, io credo che sarà necessario essere cauti e dominare il processo, allo stesso modo in cui si agisce – o si dovrebbe agire – ogni qual volta lo sviluppo scientifico e tecnologico fa un passo in avanti. Sono questioni che devono essere affrontate soprattutto a livello politico: stiamo all’erta per controllare i controllori, perché facciano ciò che è giusto affinché la tecnologia diventi una risorsa e non un problema».

Quali scenari possiamo aspettarci nei prossimi 10-20 anni?
«Fare previsioni sul futuro è difficile: spesso ci fanno sognare o spaventare, ma raramente si avverano. Pensiamo ai modelli generativi come ChatGPT, capaci oggi di scrivere codice, storie e poesie. Lo fanno peggio degli esseri umani? Qualcuno sottolinea errori banali del software di OpenAI, ma io credo che già ora un modello generativo scriva meglio del 99% delle persone comuni. Pochi anni fa questo scenario era impensabile.
Per quanto riguarda i robot sociali, oggi esistono già macchine capaci di interagire con naturalezza, seppur con limiti. Che nei prossimi 10-20 anni diventino popolari dipenderà non tanto dalla tecnologia, quanto dalla loro reale utilità percepita dal Mercato. Sarà davvero così, o questa strada si rivelerà un vicolo cieco, lasciando spazio a sviluppi completamente diversi e inattesi?».

Infine, se dovesse sfatare un mito, quale sarebbe?
«In seguito ad alcuni insuccessi degli anni passati, normali nel processo di sviluppo tecnologico, si è diffusa l’idea che i robot di assistenza non funzionino. Qualcuno, parlandone con le persone anziane, ci racconta di aver sentito gli utenti finali osservare ridacchiando: “Siamo noi a fare i badanti ai robot, e non il contrario”. La situazione non è più questa: la tecnologia c’è, per quanto non sia ancora in grado di fare tutto quello che vorremmo.
È ora necessario identificare l’utilizzo più appropriato perché abbiano un vero e proprio valore commerciale, necessario per il salto di qualità finale. Da lì partirà una fase per trasformarli da prototipi in oggetti pronti per il Mercato. Sia che abbiate grandi aspettative sia che abbiate paura, suggerisco a tutti di restare con gli occhi bene aperti»
©