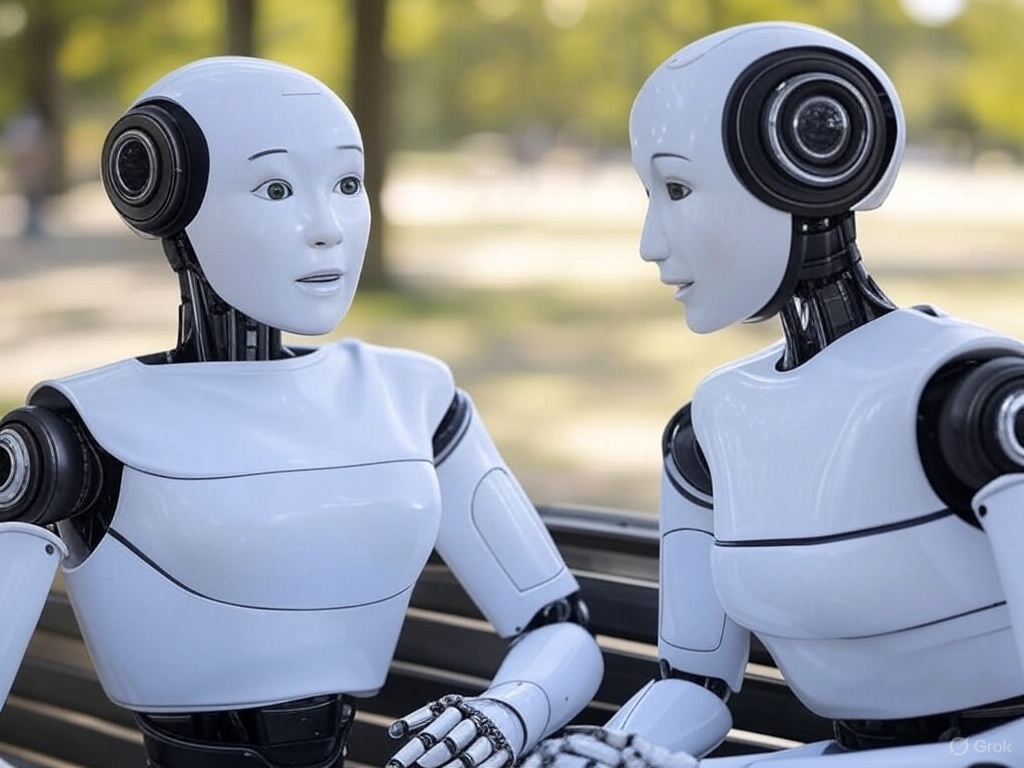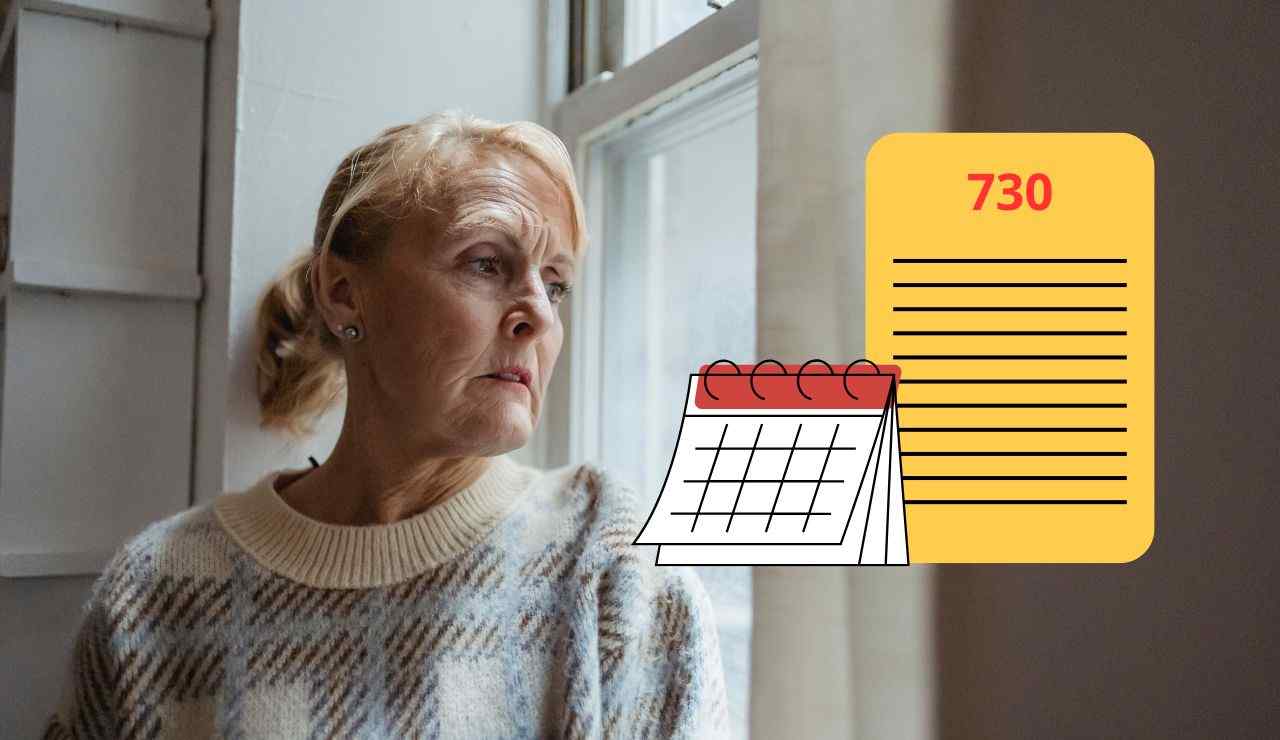“No other land”, il documentario che tutti dovrebbero vedere
È simile a un pendolo che continuamente oscilla tra le violente demolizioni e le pazienti ricostruzioni la vita nel villaggio di Masafer Yatta. Siamo nel sud della Cisgiordania, tra le […]

È simile a un pendolo che continuamente oscilla tra le violente demolizioni e le pazienti ricostruzioni la vita nel villaggio di Masafer Yatta. Siamo nel sud della Cisgiordania, tra le colline di Hebron: qui sono ambientate le riprese del documentario No other land, girato tra il 2019 e il 2023 e firmato dal collettivo israelo-palestinese costituito da Basel Adra, Yuval Abraham, Rachel Szor e Hamdan Ballal.
Un’ora e mezza di immagini nude e crude riprendono le fatiche dei civili di rimanere attaccati alle loro case, nonostante gli sfratti e le occupazioni coatte delle forze di difesa israeliane (IDF), per adibire la zona a un campo di addestramento militare. Lo sforzo maggiore è non abbandonare la propria terra, che diventa anche la loro ragione di vita, per dimostrare al mondo intero, con sacrificio, resistenza e ostinazione, che no, non c’è un’altra alternativa.
Basel Adra ha ereditato da suo papà l’attivismo per la difesa della resistenza palestinese da quando sono iniziate le occupazioni israeliane nel lontano 1967 e consegna questo impegno allo spettatore tramite le riprese della sua telecamera, a titolo di telecronaca del presente e memoria per il futuro. “Ho iniziato a filmare quando è iniziata la nostra fine” afferma. Le ruspe, i bulldozer e i carrarmati non possono fermare la forza delle loro ragioni. Così come non può fermarle il rischio di essere feriti o incarcerati, come molte volte accaduto allo stesso papà di Basel. Di fronte alle macerie, alla visione delle loro case fatte a pezzi, di scuole e pozzi distrutti, non rimane che la protesta pacifica per urlare il diritto a restare. La vita ricomincia sempre, come si può e si riesce, adoperandosi magari in modo fugace di notte, ripristinando gli impianti elettrici, adibendo le grotte ad abitazioni e con artifici rudimentali. L’obiettivo è sempre lo stesso: ritornare a un sentore di normalità o di fiducia in una qualche giustizia che venga, prima o poi, a riportare lo stato di diritto.
Colpisce la confidenza di questo popolo con l’incarcerazione, che si percepisce sempre prossima e vicina, o peggio ancora con il dolore e la morte che si percepisce come parte di un orizzonte comune. È il caso di Farisa Abu Aram, che ha visto il figlio rimanere paralizzato per mesi dopo i colpi d’arma da fuoco dell’esercito israeliano, e poi lentamente morire per le ferite riportate. Ed è anche il caso del padre di Basel, più volte arrestato, come avviene anche nel documentario, obbligando il protagonista a occuparsi dei suoi cari e della gestione della pompa di benzina a conduzione famigliare. Eppure, mai trapela il sentimento di rassegnazione, di sfiducia e arrendevolezza. Il pubblico si confronta con una realtà di resistenza e tenacia che ha ben poco ha che fare con le nostre placide, leggere e spensierate quotidianità. Anzi: il problema è proprio dover accettare che nel nostro pianeta siano parimenti presenti entrambi questi mondi. E magari a poca distanza tra loro. Uno fatto di continui soprusi; l’altro di floridità e benessere. Lo si nota ancora meglio nel legame d’amicizia tra il palestinese Basel Adra e il giornalista israeliano Yuval Abraham, che decide di supportare la lotta dell’amico. Sono entrambi giovani ragazzi che abitano a pochi km uno dall’altro, ma mentre Yuval vive libero e senza restrizioni, Basel vive, privato di tanti diritti, sotto un’occupazione militare: l’area in cui sono state girate le riprese è infatti totalmente controllata dall’esercito israeliano che limita gli spostamenti e i diritti dei residenti. Un carcere a cielo aperto.
Arrivato agli onori della cronaca, il film ha già ricevuto diversi premi: alla Berlinale 2024, dove è stato mostrato in anteprima al 74° Festival, agli EFA (European Film Awards) 2024 ed è risultato vincitore come Miglior documentario agli Oscar 2025. È stato distribuito nelle sale cinematografiche da Wanted Cinema con il patrocinio di Amnesty International Italia e il sostegno di Medici Senza Frontiere. Eppure, paradossalmente, proprio il tema delle premiazioni innesca la domanda sull’utilità concreta della pellicola. Che ne sarà di questi premi se una volta tornato in Cisgiordania per Basel, la sua famiglia e tutti gli altri civili non cambierà nulla? I protagonisti vivono il dubbio che, una volta spentesi le luci in sala, e una volta tornati alle loro vite, per gli spettatori non cambi sostanzialmente nulla. Temono che lo shock e lo sgomento rimangano insomma limitati ai 96 minuti di proiezione cinematografica. “Penso che le persone debbano capire come fare la differenza”, afferma a un certo punto Yuval. Un appello alle coscienze di tutti, nessuno escluso. Un urlo di speranza, un’urgente richiesta d’aiuto. No other land non è certo un documentario da guardare seduti comodi, o a cui ripensare in scioltezza. È al contrario una scossa per i sensi e gli animi.
Il film si conclude con una didascalia per informare lo spettatore che le riprese sono terminate prima degli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023: come si sa, da lì in poi si è scatenato l’inferno e si sono decuplicate le violenze, le distruzioni, le macerie, la carestia, l’indigenza, la fame, la sete, la malattia e la morte. Il tutto non sempre rendicontato dai nostri media e giornali. Anzi, nella maggior parte dei casi, sminuito e ridimensionato. L’ufficio per il Coordinamento degli affari umanitari delle Nazioni Unite (Ocha) informa, sulla base dei dati comunicati dal Ministero della Salute palestinese che fino al 19 gennaio 2025 a Gaza sono morte con certezza 46.913 persone e 110.750 sono state ferite: il 59% delle persone uccise erano donne, bambini ed anziani, mentre il 41% erano uomini. E da gennaio a oggi i numeri non fanno che crescere ulteriormente di giorno in giorno, con stime che attestano la morte di un bambino ogni 10 minuti, secondo i dati UNRWA.
Lo scorso 5 maggio, infine, per arrivare a oggi, il governo israeliano ha diffuso la notizia, approvata all’unanimità dal Gabinetto di Sicurezza, che sarà intrapresa una nuova massiccia invasione a Gaza con un annesso sfollamento della popolazione civile da spostare e concentrare in un lembo strettissimo di territorio, con le tragiche conseguenze umanitarie che possiamo facilmente immaginare, tanto più dopo aver visto l’anzidetto documentario. Il capo dell’esercito israeliano, il tenente generale Eyal Zamir, ha quindi previsto – secondo quanto riportato dal The Guardian – che l’esercito è pronto a chiamare decine di migliaia di riservisti per consentire il dispiegamento della nuova intensa offensiva a Gaza. A nulla sono valsi gli appelli di allarme dei numerosi funzionari umanitari, secondo i quali i circa restanti 2,3 milioni di abitanti di quei territori non riuscirebbero più ad avere sufficiente cibo e cure. Lo stesso Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA) ha accusato Israele di voler chiudere l’attuale sistema di distribuzione degli aiuti gestito dalle Nazioni Unite per imporre un suo sistema di approvvigionamento.
Di cosa accadrà domani di quelle terre e di quelle persone non abbiamo certezza. Lo possiamo però, nostro malgrado, facilmente immaginare. E proprio per questo, è il caso di ridirlo citando nuovamente le parole di Yuval: ognuno di noi, con sua la consapevolezza, può davvero fare la differenza.
Se devo morire
che porti speranza
che sia una storia.
(poeta e attivista palestinese)