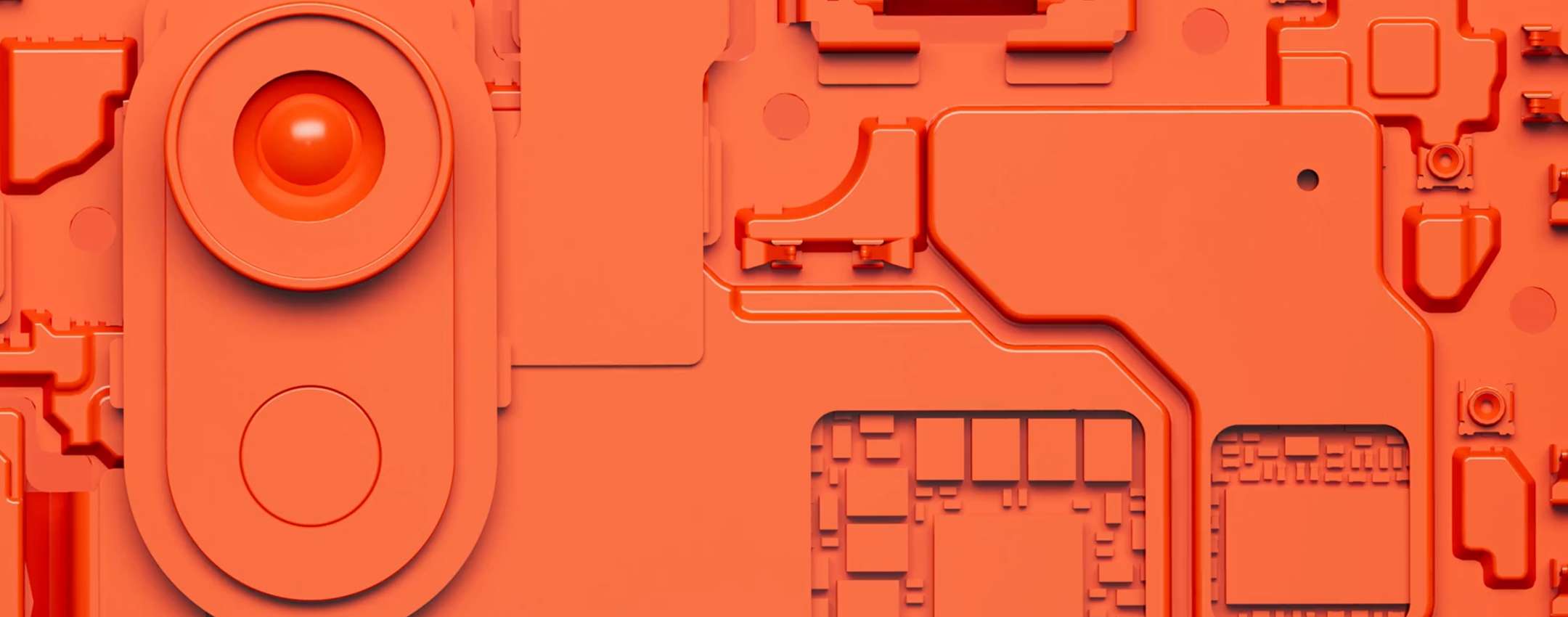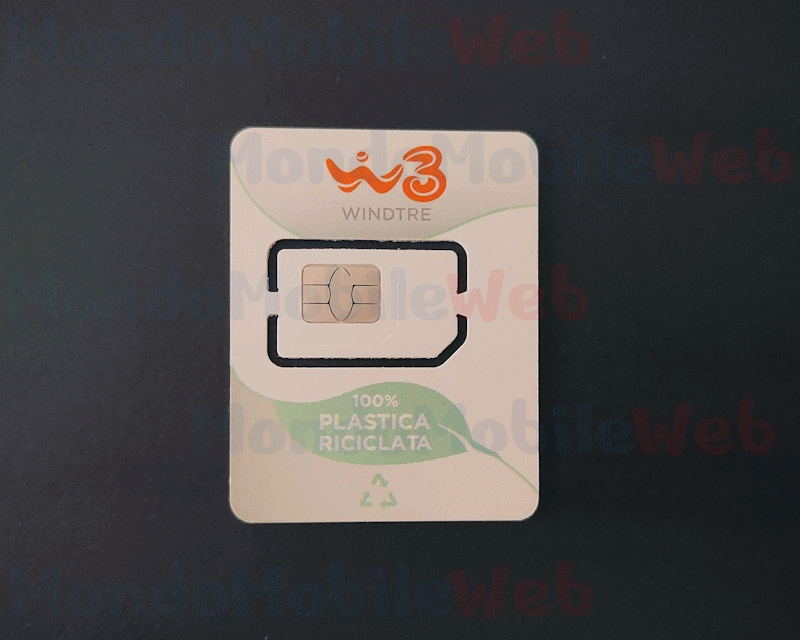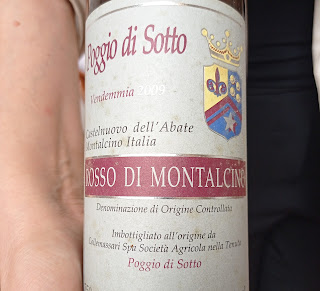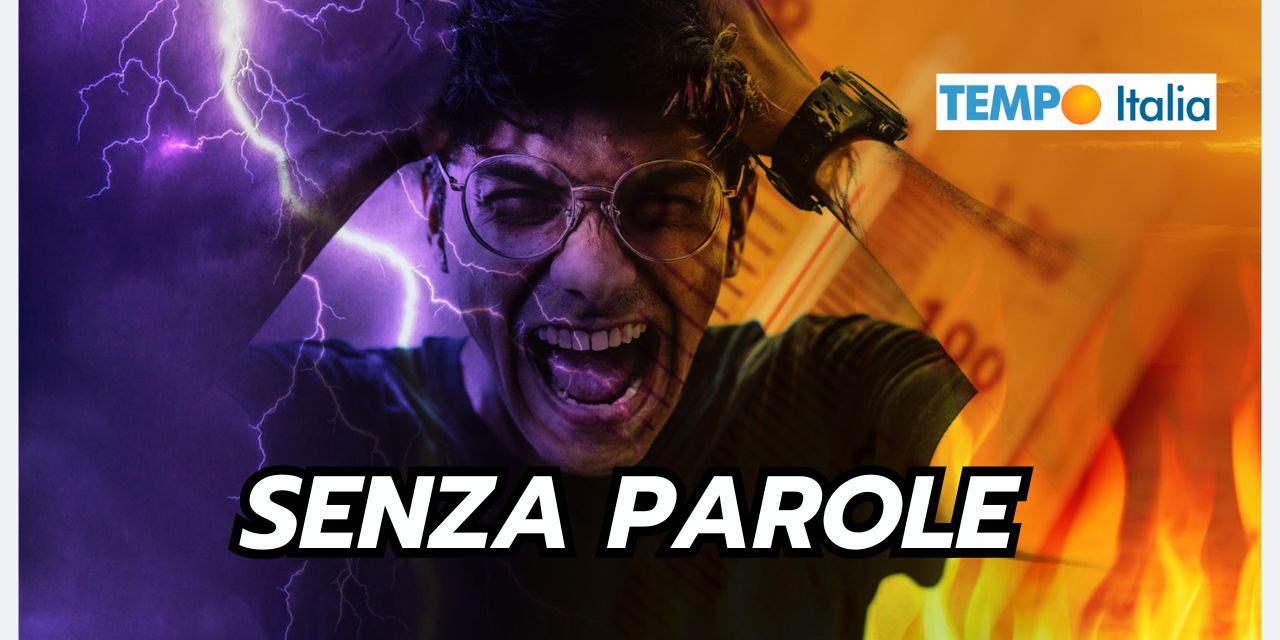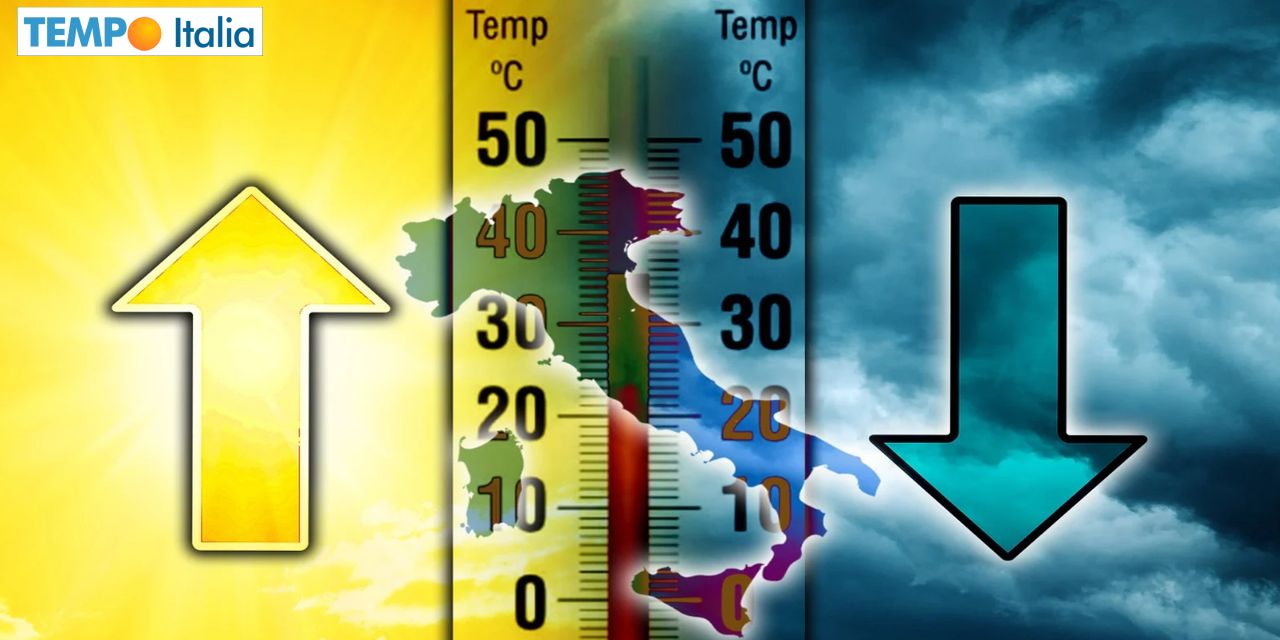MICKEY 17 di Bong Joon-ho (2025) o dell’uomo-spazzatura
Mickey 17 (2025) di Bong Joon-ho si apre con un primissimo piano: lento e affaticato, con il volto coperto di ghiaccio, il protagonista Michael Barnes (Robert Pattinson) sta per riprendere […]

Mickey 17 (2025) di Bong Joon-ho si apre con un primissimo piano: lento e affaticato, con il volto coperto di ghiaccio, il protagonista Michael Barnes (Robert Pattinson) sta per riprendere i sensi dopo essere precipitato in una rupe. Quando sente che qualcuno è venuto a cercarlo, a malapena muove lo sguardo verso l’alto. Il nostro, di sguardo, invece gli è vicino, ammette un empatico rispecchiamento nei suoi confronti. “C’è speranza per lui?”, ci chiediamo. Joon-Ho, con la consueta ironia, lascia che le immagini ci rispondano subito, e riprende la scena con un gioco ripetuto di controcampi a piombo. Mickey, che sta sotto, inquadrato dall’alto, e la voragine che si staglia sul cielo, che sta sopra, inquadrata dal basso. Piuttosto eloquente, Joon-Ho, con questa dialettica di abisso e di cielo, di nero e di bianco, di morte e di vita, drasticamente opposti. C’è speranza che l’umano si salvi? Forse no: c’è un salto impossibile tra i due piani, un’incomunicabilità assordante tra lui che sta di sotto e la salvezza luminosa che sta di sopra. Appunto, controcampo a piombo. È troppo evidente, anche prima che la scena ci mostri i suoi esiti nefasti. Sicuramente Mickey non si salverà, perché, ed è quasi ovvio, sarà abbandonato dal suo inaffidabile amico sorridente (Steven Yeung) e, dulcis in fundo, appariranno inaspettati alieni simili a miriapodi, un po’ memori della grassezza di Okja (Okja, 2017) ma apparentemente molto più cattivi … e affamati. Povero Mickey.
Il suo segreto, che si situa proprio in quel baratro concettuale (morte e vita, senso e non-senso, alto e basso), ce lo rivela la sua stessa voce fuori campo, praticamente subito. C’è una ragione per cui essa ci suona così ironica e beffarda, nonostante quello che vediamo non possa che apparire cupissimo, inquietante, ripugnante; abbastanza sopra le righe, quella “voce fuori”, da ammiccare alla nostra meta-filmica incredulità, a non farci aderire davvero alla posta in gioco imposta dalle immagini. A lasciarci, come Mickey, sospesi tra la certezza dell’annientamento e la possibilità di uscire fuori dalla tenebra della nostra condizione. Imprigionati nel mezzo, tra il baratro e il cielo, più nel baratro che nel cielo.
Ecco il punto: Mickey, di fatto, è già morto molte volte. Precisamente è morto sedici volte. Non ama morire, come ci dice con espressione disgustata quando il “miriapode” spalanca la bocca davanti a lui per inghiottirlo; eppure si è abbastanza abituato alla cosa da permettersi di non essere struggente quando ci annuncia la sua diciassettesima volta: divorato vivo. Punto e a capo. Come in un videogioco Mickey rinasce, perché a differenza nostra è letteralmente riproducibile, alla maniera di un clone confezionato ex novo, o di un avatar, o di un replicante. Prendiamo i rifiuti della nave spaziale su cui si è imbarcata una parte di esseri umani reietti che si allontana dalla terra (sovrappopolata, climaticamente instabile, ovviamente etc.), impastiamoli nella avveniristica stampante 3D e avremo comodamente, più che Michael Barnes (solo e unico), un numero potenzialmente infinito di Mickey [Mickey 2, Mickey 3, Mickey 4, Mickey 5, Mickey 6 …Mickey 17, quello nella caverna, (poi 18, poi 19,…)]. Ne facciamo quello che vogliamo: serve aggiustare l’astronave? Mandiamo Mickey, che può inzupparsi di veleno cosmico, e magari esplodere. Serve un vaccino? Testiamolo su Mickey, che se si squaglia è “ristampabile”. Serve esplorare il pianeta? Mandiamo Mickey, al massimo viene mangiato, e noi lo “rifacciamo”, da zero. La sua memoria, comunque, resta (età post-Musk); e niente di lui va perso. Se non la “carne”, che comunque è fatta di trash, letteralmente. Che valore ha la sua vita, se è sostituibile? Mickey, e lui solo, è IL SACRIFICABILE. Diciamolo meglio: Mickey è, con Agamben, la “nuda vita”. Diciamo che è la “nuda vita” che una società capitalista sfrutta a proprio piacere, e a proprio vantaggio, per campare, vaccinare, esplorare, testare, avvelenare …. Mickey è il riciclabile di una società corrotta, guidata da folli egomaniaci post-fascisti (il capo della spedizione Marshall, Mark Ruffalo), da ipocrite voglie classiste (sua moglie Ylfa, Toni Collette) da arrivisti ruffiani (l’amico Timo, Yeung), da mafiosi implacabili, da scienziati grotteschi e imbarazzati. Mickey siamo un po’ noi, gli uomini “senza qualità”, rimpiazzabili a piacimento nel tritacarne della nostra oscura realtà (l’astronave è buia come l’ultimo vagone di Snowpiercer, spoglia come i cunicoli di Alien… poca speranza di uscirne!). Mickey, come del resto tutti i passeggeri che supinamente mangiano gelatina fatta di rifiuti, è plastificato nella carne, è organicamente fatto di spazzatura. È un uomo-spazzatura perennemente redivivo.
Eccoci allora, nel baratro della prima scena, inficcati in una rupe, a rischio di diventare cibo per mostri. Poveri riciclati, che guardiamo in alto e sappiamo benissimo che non ci arriveremo, a quel cielo. Eccoci pronti ad essere, ancora, un bel niente. Mickey, come noi, sta proprio al centro di una dialettica impossibile tra la vita e la morte, tra l’alto e il basso, tra la sconfitta annichilente e l’uscita dalla gabbia mostruosa del nostro mondo, che però sembra inattingibile. Non è così anche questo nostro mondo affaticato? Non siamo proprio come questa astronave di persone disperse nel vuoto universale, in un’insignificanza che stentiamo a comprendere, per ricercare un “nuovo mondo” da cui ricominciare la nostra storia? Non sono, questi, i temi che ognuno di noi sente impellenti nel suo cuore? Ri-nascere, ri-fondarsi, ri-vivere? Mickey, che può rinascere, rifondarsi e rivivere ci rappresenta molto più di quanto non potremmo volere ammettere. Quanto siamo sacrificabili, noi? Quanto si vale?
Eppure Mickey 17 non sa, e non vuole, scommettere sulla possibilità che un altrove sia possibile. I toni auto-ironici sono troppo espliciti, le esagerazioni grottesche troppo ricorrenti, le situazioni troppo esasperate, perché lo spettatore creda davvero a quella vaga speranza che Joon-Ho, comunque, mette in campo nel corso degli eventi (senza Spolier!). A che vale cercare un “nuovo mondo” da ricostruire, una “nuova casa” da abitare, secondo i più utopistici sogni trans-umani, se l’uomo è pensato, fatto, nutrito, ingozzato, di spazzatura? Che poi, e la cosa è significativa, questa “nuova terra promessa” è, nel film, ben poco attraente, fredda, ghiacciata, brutta, visibilmente inabitabile. Più che la tabula rasa di un inizio sembra l’ostinazione stupida di un impossibile. Non è certo, Niflheim, un pianeta florido, simile al tropicale Pandora immaginato da James Cameron in Avatar, ma nemmeno prossimo al selvatico e tribale pianeta “prodotto” da Ridley Scott in Prometheus. Non ci sono i Na’vi, nuovi indigeni panteisti che ci chiamano ad una nuova spiritualità new age, ma vendicativi vermoni pelosi, gli Striscianti. Difficile rispecchiarsi in un sogno che sembra un artropode. Difficile credere a una salvezza che non voglia superare il proprio “vuoto”. Difficile credere a quel poco di “bene” che, in salsa un po’ woke, Joon-Ho dissemina di qui e di lì, più a disilluderci (anche) di ogni eventuale progressismo di moda che a indicarci una strada diversa da ogni post-reazione fuori tempo massimo.
Il fatto è che il film di Joon-Ho, preso dal romanzo di Edward Ashton (Mickey 7, 2022), sembra pericolosamente troppo simile al suo protagonista. Esibendosi come una ricca e costosissima (118 miliardi) metafora del mondo, riciclando volutamente situazioni, luoghi comuni, pretesti, topoi del genere, Mickey 17 finisce per essere fatto – e lo sa benissimo – della stessa materia riciclata di cui parla; prende il residuo di un certo cinema commerciale post-moderno, lo impasta, e lo “ristampa” per noi, spettatori ipersensibili, per surrogare (ancora! Ma questa volta consapevolmente) ogni aspirazione al “nuovo”. Per parlarci di una eterna rinascita alla morte, piuttosto che di una possibile rinascita alla vita.
Forse una “nuova fondazione” dovrebbe invece partire dall’unica cosa che il film di Joon-Ho trascura, perché non sa, né vuole, pensarla. Che la voragine, quella iniziale, quella della vita e della morte, NON è solo un impossibile che, “umani” in carne e ossa o creature riciclabili a piacimento, siamo vocati a subire nell’insensatezza del tutto. Che l’unico “pianeta” che può e dovrebbe essere cercato, per evitare di essere solo un uomo-trash che vaga nell’universo senza posa, con tutti i suoi diritti più o meno moderni, sta nel riconoscimento (eminentemente sapienziale) che noi NON siamo questo. MA invece, con i Veda, “Siamo Quello”. E che Quello non è di Questo mondo. Non basta più ironizzare con comoda cialtroneria sulle contraddizioni di un “mondo della fine”. Ogni critica al nostro tramonto d’Occidente che non muova da questa intuizione iniziatica non solo sarà (come Mickey 17) solidale con le forze che ci astringono nel burrone della morte certa; ma anche, (forse) inconsapevolmente, al loro servizio finale.