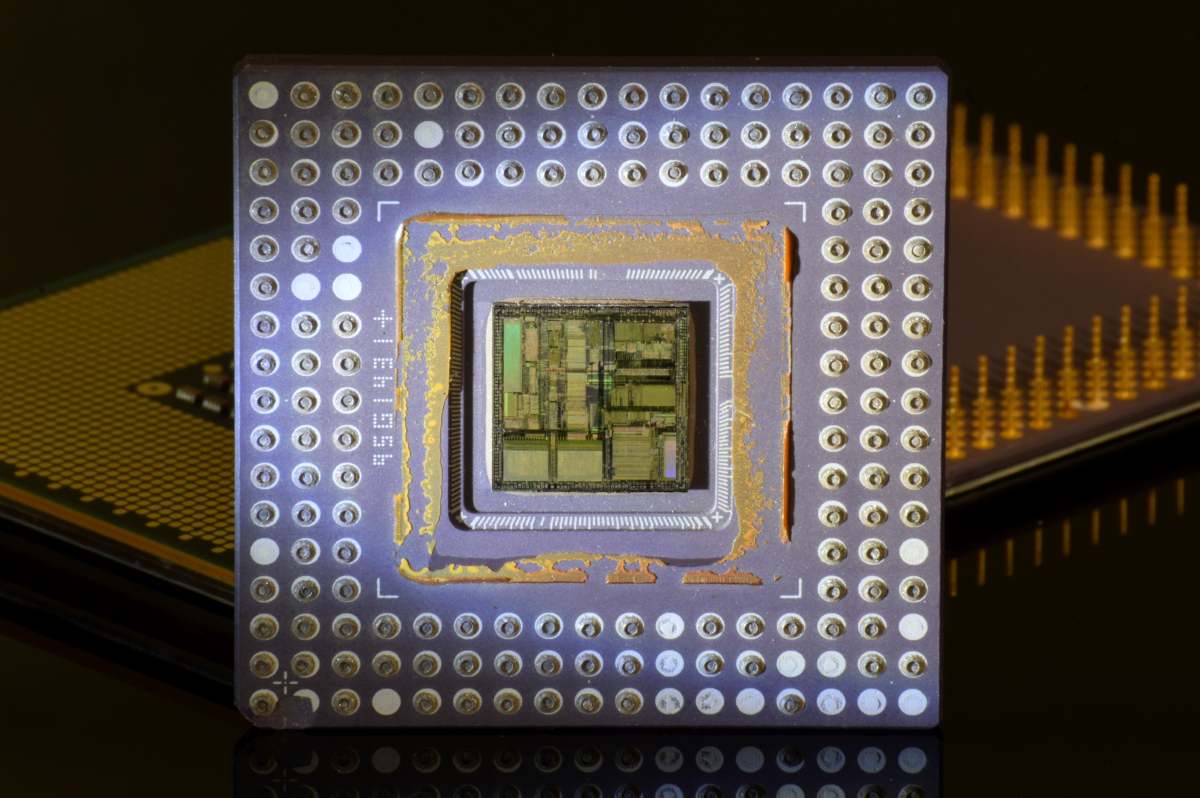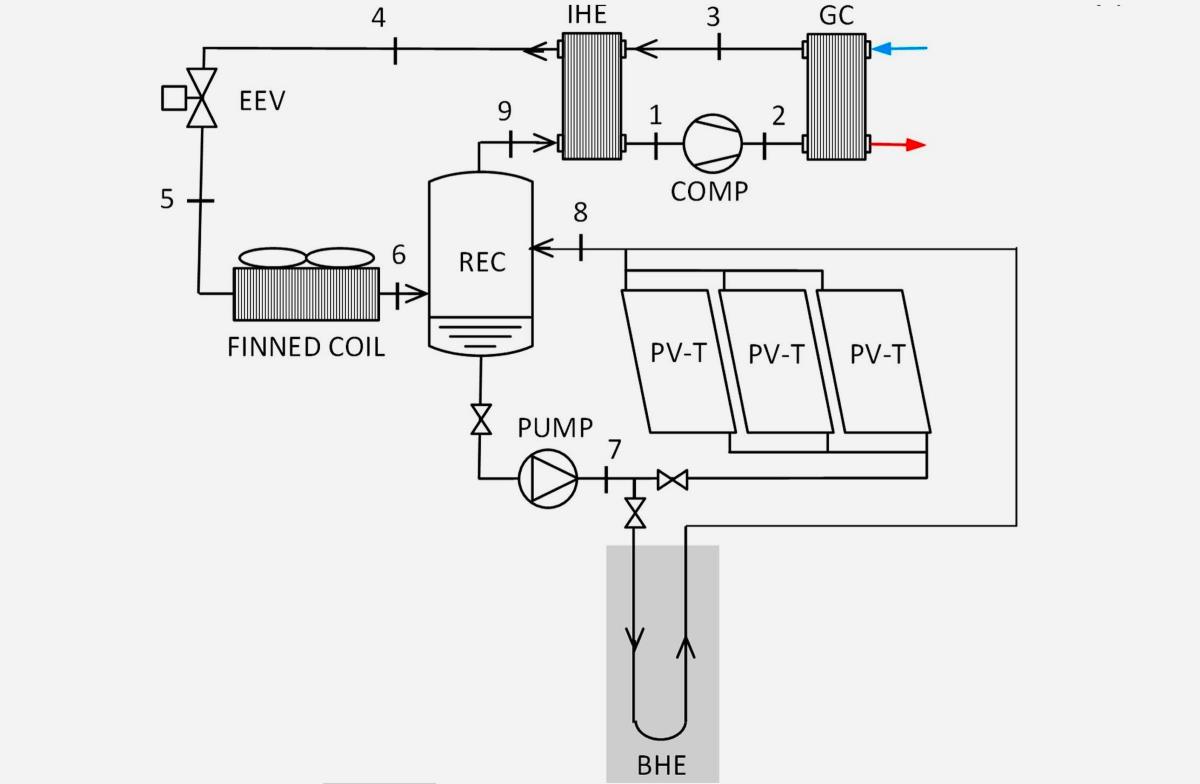La promessa incompiuta: Vera democrazia da una prospettiva marxiana
In un’epoca in cui la parola “democrazia” rischia di essere consumata dal logorio delle retoriche ufficiali, piegata a una funzione di legittimazione dell’esistente più che di apertura a una possibile […]

In un’epoca in cui la parola “democrazia” rischia di essere consumata dal logorio delle retoriche ufficiali, piegata a una funzione di legittimazione dell’esistente più che di apertura a una possibile alterità, il volume Vera democrazia. Politica e diritto nella prospettiva marxiana di Giulio Di Donato si impone come un gesto intellettuale raro: un ritorno al pensiero originario di Karl Marx, depurato tanto dalle semplificazioni ideologiche quanto dalle consuete caricature manualistiche.
Di Donato si confronta con il cuore incandescente della questione democratica: non la democrazia come mera forma procedurale, né come sistema rappresentativo finalizzato alla gestione dell’ordine sociale, ma la democrazia come progetto di emancipazione sostanziale, come promessa di una società finalmente riconciliata con sé stessa, in cui l’autogoverno non sia solo proclamato, ma effettivamente vissuto. Fin dalle prime pagine, emerge la volontà di sfidare l’eredità più insidiosa del pensiero politico moderno: quella scissione tra sfera politica e sfera sociale, tra uomo concreto e cittadino astratto, che Marx aveva diagnosticato con acutissima lucidità nei suoi scritti giovanili, in particolare nella Critica della filosofia hegeliana del diritto pubblico. La democrazia borghese, ricorda Di Donato seguendo fedelmente l’analisi marxiana, emancipa l’individuo solo come soggetto di diritto privato, come possessore atomizzato, non come essere umano sociale; essa produce, per riprendere le parole di Marx, “l’uomo fantastico, l’uomo astratto, l’individuo egoista”. Ne consegue che la “vera democrazia” non può limitarsi alla concessione di diritti formali, ma deve configurarsi come un rovesciamento radicale delle condizioni sociali che rendono tali diritti, nella pratica, lettera morta.
La democrazia autentica è, in questa prospettiva, non la maschera che vela la divisione sociale, bensì l’evento attraverso il quale l’umanità si riappropria delle proprie potenzialità negate. Di Donato insiste sul fatto che Marx, lungi dal proporre una negazione totale della politica, ne auspica una metamorfosi: la politica, nella società comunista, non scompare, ma muta natura; da strumento di dominio si fa esercizio collettivo di autogoverno. In tale ottica, la Comune di Parigi assurge a modello anticipatorio: non un governo delegato, ma un potere immediato dei produttori associati, che si amministrano senza mediazioni separate. In questa lettura, la democrazia vera si avvicina a una concezione della libertà che recupera, in forme nuove, l’ideale della partecipazione politica degli antichi, contaminandolo con l’esigenza moderna di una piena emancipazione materiale.
L’analisi di Di Donato sul rapporto tra diritto ed economia è particolarmente penetrante. Il diritto borghese è, per Marx, una forma necessaria ma storicamente determinata: è necessario in quanto offre un terreno su cui si combattono battaglie cruciali per l’emancipazione; ma è al contempo intrinsecamente segnato dalla logica della proprietà privata e dell’ineguaglianza. Il diritto, in una società alienata, è costretto a riconoscere formalmente ciò che la realtà sostanzialmente nega. La vera democrazia comporta dunque una dialettica in cui il diritto borghese viene superato non mediante un atto di volontà, ma attraverso la trasformazione progressiva dei rapporti sociali, fino a rendere superfluo il ricorso alla coazione esterna. Non l’abolizione arbitraria della norma, ma l’instaurarsi di una vita associata così intrinsecamente razionale e cooperativa da non richiedere più il supporto della forza giuridica.
La democrazia, nella sua autenticità, è per Marx un compito storico mai definitivamente compiuto. Non è un assetto dato, ma un processo aperto, una tensione ininterrotta verso una forma di vita nella quale l’uomo non sia più estraneo a sé stesso, né nelle relazioni economiche né in quelle politiche. È, per usare la terminologia di Ernst Bloch, una utopia concreta: la visione di una comunità riconciliata che, lungi dal congelarsi in un modello fisso, si offre come orizzonte critico, come incessante autocritica della realtà esistente. In questo senso, il pensiero di Marx si fa prossimità a quella idea di democrazia come “infinita apertura del possibile” teorizzata, su altri versanti, da Miguel Abensour.
Lo stile di Di Donato si segnala per una chiarezza nobile, immune tanto dagli accademismi più sterili quanto dalle seduzioni dell’eccessiva semplificazione. La sua scrittura nasce da una lunga consuetudine con il pensiero che interroga: ogni frase è il precipitato di una meditazione seria, ogni argomento è presentato con una misura che rivela la profondità della riflessione più che l’urgenza della tesi. In ciò, Vera democrazia si pone come esempio raro di saggistica filosofica capace di coniugare rigore filologico e tensione politica.
In ultima analisi, il libro di Giulio Di Donato è molto più che una rilettura di Marx: è un invito a pensare la democrazia al di là della feticizzazione procedurale, a riaprire la domanda sull’essenza stessa della comunità politica, a riconoscere che senza una trasformazione radicale delle condizioni materiali di esistenza, senza l’estinzione dell’alienazione nelle sue molteplici forme, la democrazia resta parola vuota, “bandiera sollevata sopra una società divisa”, come avrebbe potuto dire lo stesso Marx. In tempi segnati dall’apatia politica, Vera democrazia suona come un monito e una promessa: la democrazia vera è ancora tutta da costruire, e il cammino verso di essa, lungi dall’essere lineare, richiede coraggio teorico, pazienza storica, e una fede incrollabile nella capacità umana di superare le proprie alienazioni.