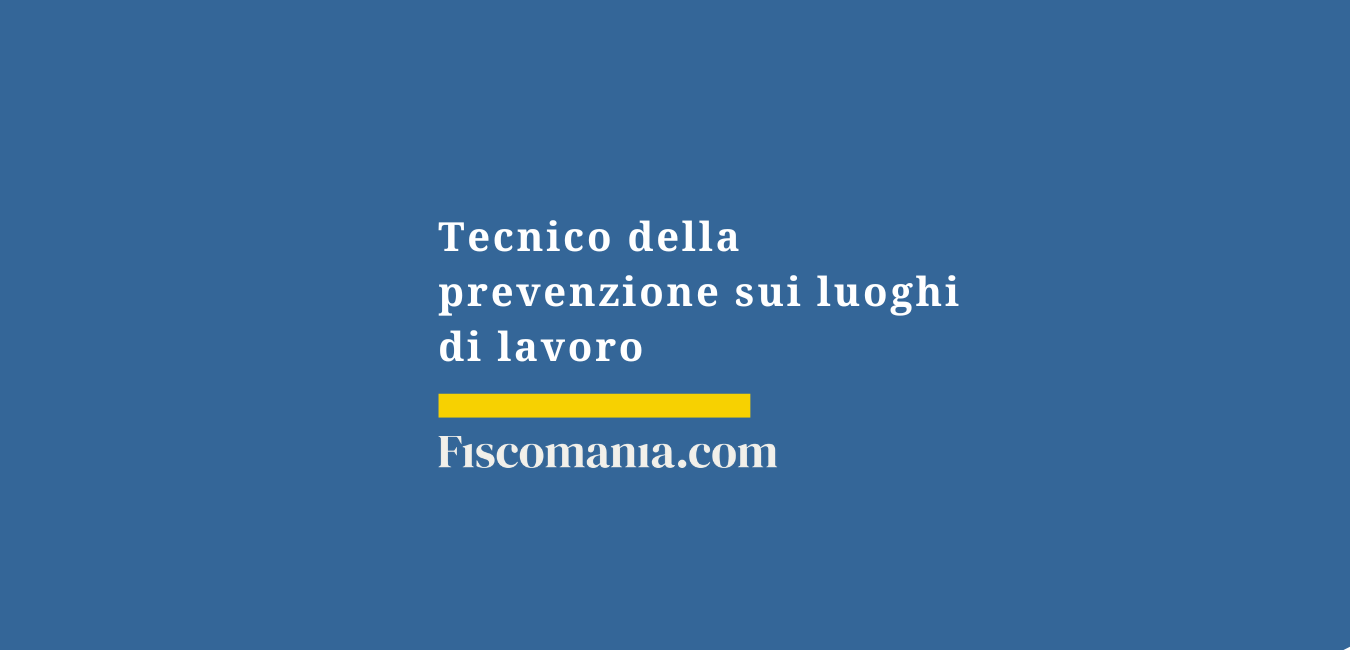In genere
Perché le cosiddette “questioni di genere” infiammano il dibattito contemporaneo? Filosoficamente esse pongono, in maniera chiara e ambivalente insieme, il tema complesso del rapporto tra identità e differenza. Un’identità chiusa […]

Perché le cosiddette “questioni di genere” infiammano il dibattito contemporaneo?
Filosoficamente esse pongono, in maniera chiara e ambivalente insieme, il tema complesso del rapporto tra identità e differenza.
Un’identità chiusa si differenzia per esclusione dalle altre. Una aperta si riconosce come profondamente relazionale, dunque co-isituita nel rapporto con altre identità aperte. A questo aggiunge la sensazione di essere attraversata internamente dalla differenza, in una impossibile coincidenza finale con sé.
Ce ne accorgiamo in modo eclatante con il fenomeno della disforia di genere, una possibilità dell’umano non strettamente patologica (per quanto comporti spesso sofferenza psichica), anzi “strutturale”, poiché genere e sesso non si corrispondono automaticamente.
Possiamo sentirci appartenenti a un genere diverso da quello che la nascita ci ha assegnato sul piano sessuale-biologico-anatomico (che tuttavia esiste, e nessuno può scegliere volontariamente: è dunque ricevuto e irrevocabile, anche laddove fosse modificato tramite assunzione di ormoni o riassegnazione chirurgica del sesso), senza che questo debba farci sentire anormali.
Del resto – ferma restando la riproduzione della specie tramite unione maschio/femmina o, meglio ancora, elementi maschili ed elementi femminili – è limpido a chiunque conosca un po’ l’antropologia, la psicologia e le scienze in genere, che la sessualità per gli umani è immediatamente filtrata e stravolta dalla dimensione pulsionale e linguistica della cultura. Non si fa sesso solo (o principalmente) per procreare, per quanto la sua generatività rimanga un dato fondamentale e non trascurabile.
Siamo creature sessuate perché poste originariamente in una tensione relazionale: maschi per femmine, femmine per maschi, omosessuali per omosessuali (maschi per maschi, femmine per femmine), eterosessuali per eterosessuali, non-binari per non-binari (e non solo) ecc. Il brutto vizio della maggioranza statistica eterosessuale è stato, per millenni (con qualche eccezione passeggera), quello di elevarsi a norma per l’intero genere umano. Così le altre soggettività non conformi – che, si badi bene!, come tutte sperimentano la loro identità sessuale solo in esercizio, cioè amando un Altro essere umano – sono state considerate errori di natura o pericolosi devianti da ricondurre all’Ordine (questo è uno dei punti fissi dei fascismi vecchi e nuovi).
La reazione di rivolta a questa discriminazione ha portato a grandi prese di consapevolezza, ma talora a degli estremismi. Un libro misurato e molto accurato su tali argomenti è quello di Adriana Cavarero e Olivia Guaraldo, intitolato “Donna si nasce” (Mondadori, 2024). Capita allora che l’articolato mondo LGBTQIA+, all’interno del quale, fatta esclusione per la maternità surrogata, troviamo diverse rivendicazioni sensate e condivisibili, non possa che rispettare la legge della relazionalità radicale, in quanto il suo orgoglio identitario centrato soprattutto sulla “fluidità” (paradosso mirabile: un identitarismo fluido che piace all’ideologia neoliberale e al suo individualismo spinto) si dà in opposizione all’eterosessualità normativa. Non a caso quel + al termine dell’acronimo LGBTQIA rimanda a future, nuove identità sovversive da aggiungere alle precedenti, ad esclusione di quella eterosessuale che, per definizione, non potrà mai trovare posto accanto alle altre.
Del resto, visto che la sessualità è solo secondariamente auto-erotismo, ed è originariamente richiamo/desiderio di incontro con l’Altro (qualunque sia la sua identità di genere), dobbiamo accettare che il sé e l’autodeterminazione hanno una loro importanza, ma non possono esaurire la vicenda in esame. Noi siamo, strutturalmente, sé-con-l’Altro, non se ne esce. E lo testimoniano i conflitti, le intolleranze, i varchi di respiro, le alleanze, le dicotomie distruttive. Nessuna identità vale “in isolamento”. Anche la A delle minoranze sessuali (gli A-sessuali) non può che definirsi rispetto ai più diffusi “sessuali”. Non avvertire attrazione per alcun genere, e non avere interesse per la sessualità, è nei fatti una possibilità del vivente, tuttavia la sua definizione identitaria risente dell’alfa privativa rispetto al desiderio e all’attrazione sessuale. Brutti scherzi gioca questo sesso!
Ritengo che, a fronte di queste provvisorie considerazioni, sia possibile indicare tre cautele da assumere responsabilmente se vogliamo che l’argomento sprigioni la sua forza politica senza cadere nella rete dei vari manipolatori di turno. Le cautele si riassumono in tre posizioni che esprimo senza tanti giri di parole: 1) non possiamo comprendere la sfida posta dalle questioni di genere se la guardiamo dall’angolazione ristretta e tradizionalista di chi si abbarbica a essenze metafisiche (l’Uomo, la Donna) e di chi vive nel terrore di una “ideologia gender” nemica della famiglia e dell’amore tra sessi opposti e complementari; 2) non possiamo valorizzare le istanze trans-femministe se aderiscono inconsapevolmente alla retorica del “tutto è possibile” negando la rilevanza generale delle differenze sessuali incarnate nei corpi, dunque anatomia e biologia, in nome di un paradossale invito a “scegliere chi essere” senza limiti e vincoli ecoculturali, sovrastimando la sfera della volontà e della decisione cosciente; 3) va evitata con cura la competizione tossica tra particolarismi e va rilanciato l’impegno – come suggerisce ottimamente Mimmo Cangiano nel suo “Guerre culturali e neoliberismo”, nottetempo edizioni – per lotte coordinate di solidarietà e liberazione dall’oppressione e dallo sfruttamento capitalistico. Il punto è che, se non cadiamo nel particolarismo sterile delle lotte (e nel vittimismo che lo contraddistingue), possiamo finalmente farci carico di una coscienza ampliata: indipendentemente dalle nostre identità di genere e sessuali, siamo tutte/i immersi nella società del profitto e nel corrispettivo mercato del lavoro. Quindi le discriminazioni verso le minoranze e quelle più vaste e trasversali, si riflettono l’una nell’altra. Per questo motivo la sfida è quella di tenere insieme, in un’unica prospettiva, diritti di libertà, giustizia sociale, battaglie per l’ambiente e lotta per la pace e la cooperazione internazionale.