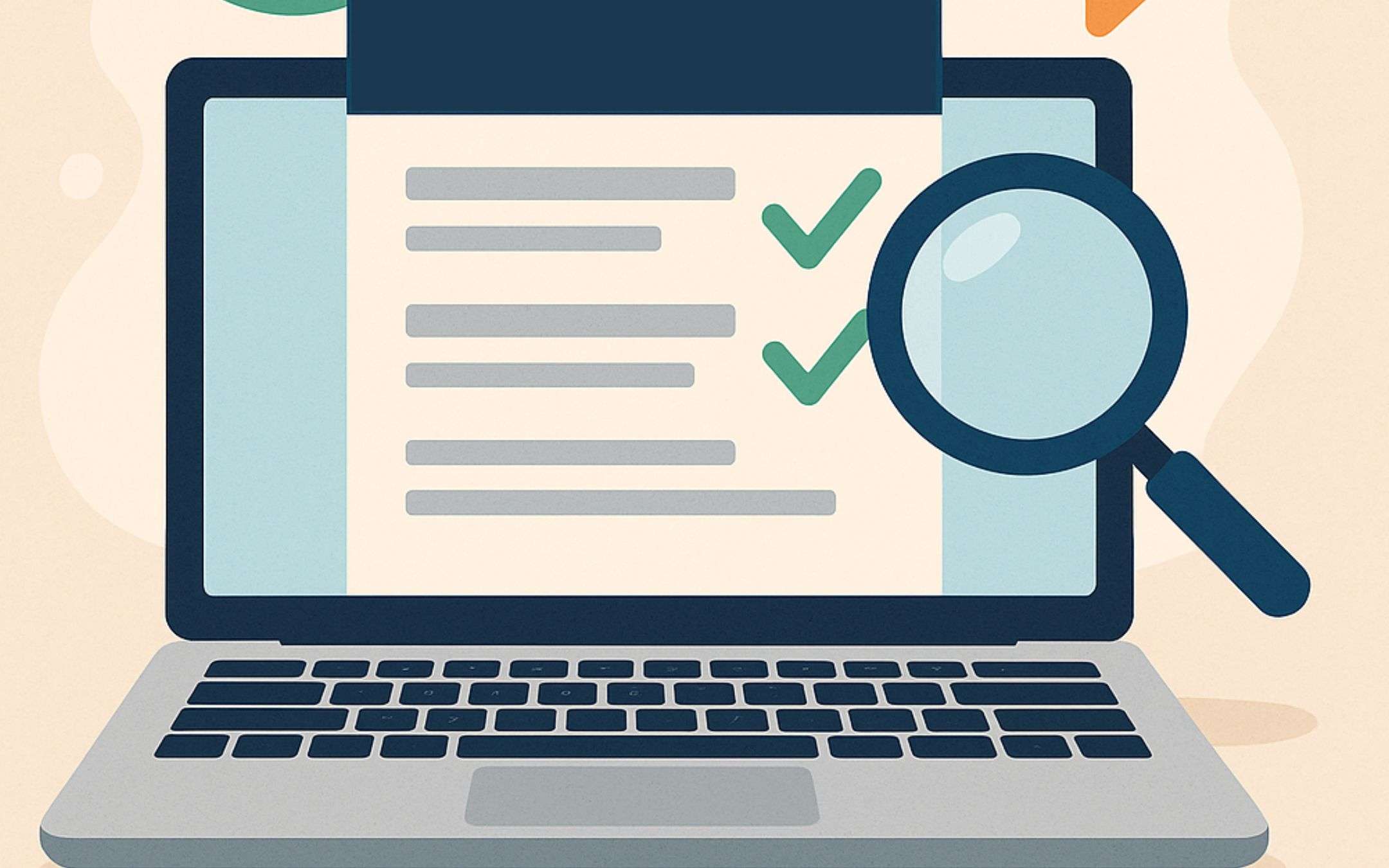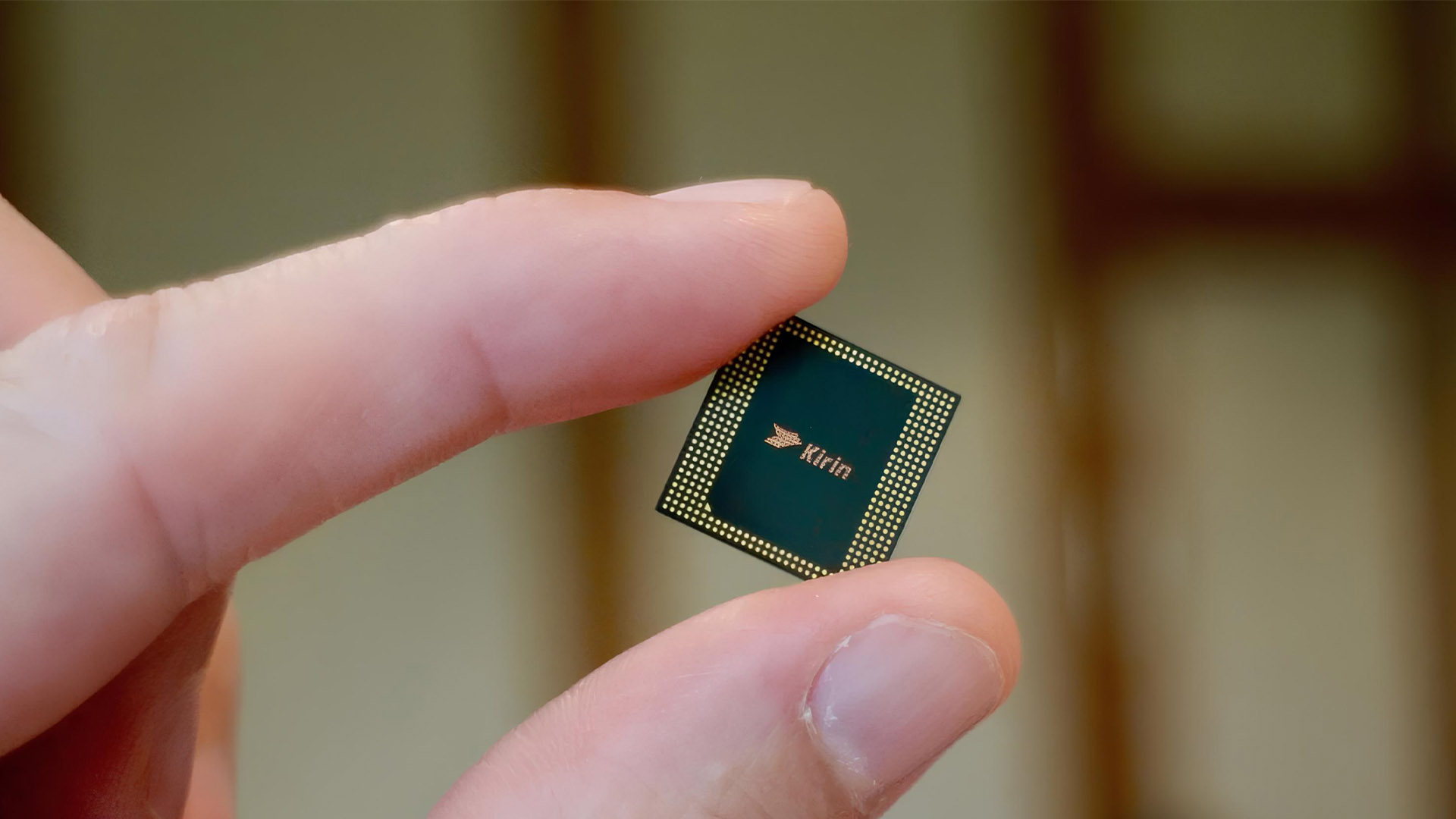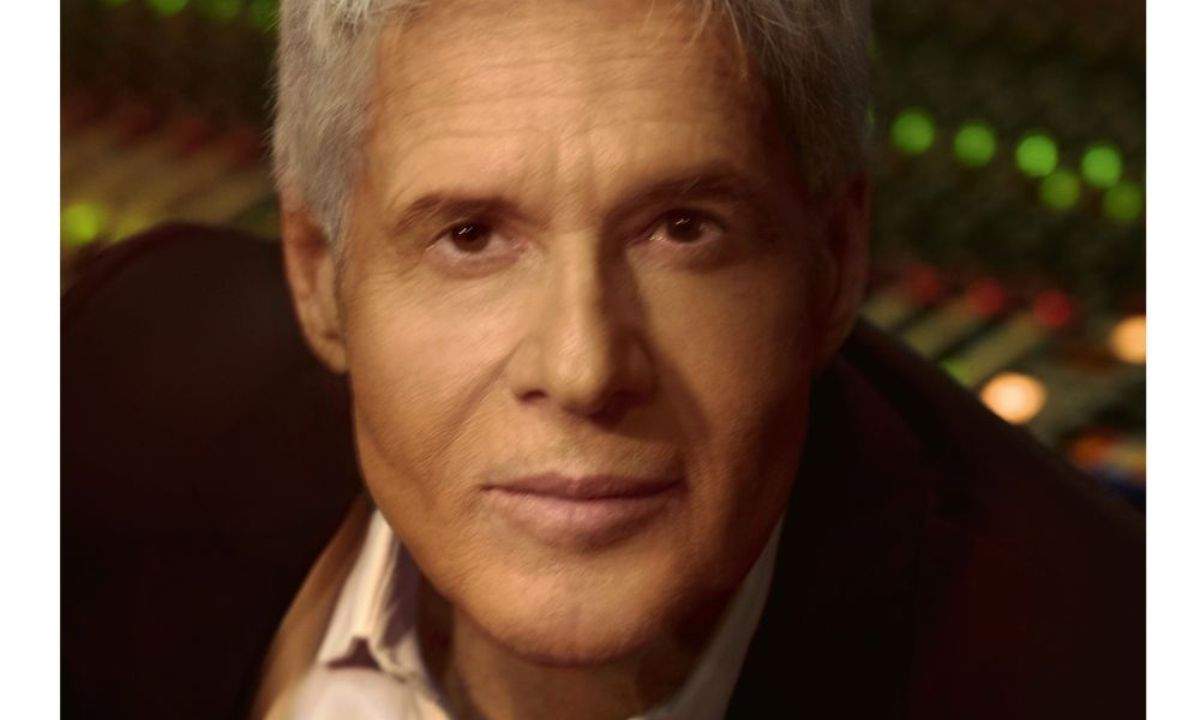Il TAR sul conflitto di interessi del consigliere comunale in sede di votazione
lentepubblica.it Una recente sentenza del TAR Sicilia, analizzata dall’Avvocato Maurizio Lucca, fornisce alcune indicazioni importanti sul sul conflitto di interessi del consigliere comunale in sede di votazione. La sez. V Palermo del TAR Sicilia, con la sentenza 13 maggio 2025 n. 1042 (Estensore Illuminati), si sofferma sui confini del conflitto di interessi del consigliere comunale in […] The post Il TAR sul conflitto di interessi del consigliere comunale in sede di votazione appeared first on lentepubblica.it.

lentepubblica.it
Una recente sentenza del TAR Sicilia, analizzata dall’Avvocato Maurizio Lucca, fornisce alcune indicazioni importanti sul sul conflitto di interessi del consigliere comunale in sede di votazione.
La sez. V Palermo del TAR Sicilia, con la sentenza 13 maggio 2025 n. 1042 (Estensore Illuminati), si sofferma sui confini del conflitto di interessi del consigliere comunale in sede di votazione, affermando che la situazione che impone l’astensione (alias allontanamento dall’aula) [1] non può essere predicata in astratto ma dimostrata nel concreto (ovvero, dando conto degli elementi capaci di condizionale l’esito del voto) [2], donde la piena legittimità della deliberazione adottata.
Il pronunciamento consente di andare oltre al caso.
Conflitto di interessi del consigliere comunale in sede di votazione
Nel decidere il consigliere comunale deve necessariamente astenersi in presenza di un interesse personale e dei propri congiunti dovendo garantire, nell’esercizio delle proprie funzioni, l’imparzialità e il principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni: la c.d. riserva di amministrazione che nel principio di separazione distingue i ruoli di indirizzo e controllo da quelli gestionali, affidati all’apparato tecnico.
In termini giuridici, il comma 2, dell’art. 78 del d.lgs. n. 267/2000, prevede che gli amministratori «devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado».
Si tratta di un interesse al medesimo tempo sostanziale e immateriale:
- sostanziale, dal lato dei consociati, perché garantisce la giustizia attraverso la uguaglianza delle posizioni, la parità di trattamento, e la conseguente tutela della concorrenza;
- immateriale, dal lato della PA, perché tutela anche l’immagine imparziale del potere pubblico, anche la situazione di pericolo, che definiamo “agire in conflitto di interessi”, danneggia ex se l’interesse pubblico immateriale suddetto.
Il ricavato formale porta in rilievo non solo casi in cui viene minata la regolarità dell’azione amministrativa, ma anche ipotesi in cui ad essere pregiudicata è “l’immagine imparziale” dell’Amministrazione: devono, così, essere evitate e prevenute tutte le possibili situazioni di natura oggettiva che possano anche solo far dubitare che il componente dell’organo amministrativo non abbia una posizione di imparzialità rispetto all’attività che è chiamato a svolgere [3].
Il conflitto di interessi nel Codice dei contratti pubblici
In effetti, anche il comma secondo dell’art. 16, Conflitto di interessi, del d.lgs. n. 36/2023, «in coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell’azione amministrativa, la percepita minaccia all’imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto»:
- una prima condizione deve risultare «sulla base di presupposti specifici e documentati»;
- una seconda condizione (aggiunta alla prima) «deve riferirsi a interessi effettivi», i quali devono alimentarsi in un contesto di reciprocità «la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all’altro», con l’inevitabile conseguenza di un dovere di allegazione puntuale e documentale delle circostanze addebitabili a quel determinato interesse coinvolto, senza il quale non può ritenersi (ex lege) sussistere un’alterazione dell’imparzialità (il presidio della norma, ex 97 Cost.) [4].
Viene definita una speciale regola relativa all’onere della prova, con valenza sia sostanziale che processuale, non un semplice sospetto o la potenzialità (astratta) [5], recependo la nozione eurounitaria di conflitto di interessi che viene, tuttavia, riformulata e semplificata, anche al fine di evitare inutili ridondanze: non consiste quindi in comportamenti dannosi per l’interesse funzionalizzato, ma in una condizione giuridica o di fatto dalla quale scaturisce un rischio di siffatti comportamenti, un rischio di danno: l’essere in conflitto e abusare effettivamente della propria posizione sono due aspetti distinti (Relazione illustrativa del Codice).
Il conflitto di interessi potenziale
L’art. 6 bis, Conflitto di interessi, della legge n. 241/1990, inserito dall’art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, ha stabilito che «il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale», dove l’astensione è doverosa anche in presenza di un conflitto di interessi non attuale ma astrattamente, possibile la cui violazione (della comunicazione) può costituire una violazione grave che può portare alla sanzione espulsiva.
Non è necessario, quindi, che il conflitto di interessi causi effettivamente un illecito penalmente rilevante, l’importanza risiede nella potenzialità del conflitto stesso di ledere la fiducia posta alla base del rapporto di lavoro: la violazione del vincolo riveste indubbia gravità [6].
In questo caso, l’espressione “conflitto di interessi”, compendiata dal cit. art. 6 bis, evoca tutte le situazioni in grado di compromettere, anche solo potenzialmente, l’imparzialità richiesta nell’esercizio del potere decisionale, ipotesi che si verificano quando il soggetto chiamato a svolgere una funzione strumentale alla conduzione di una procedura selettiva è portatore di interessi della propria o dell’altrui sfera privata (c.d. interessi secondari), che potrebbero influenzare negativamente l’esercizio imparziale ed obiettivo delle sue funzioni: l’interesse primario al buon andamento dell’azione amministrativa (l’imparzialità) [7].
Agire in conflitto di interessi comporta l’immediata (condotta doverosa):
- segnalazione del conflitto, anche solo se potenziale al proprio superiore;
- l’astensione, con il conseguente divieto di adottare l’atto, versando in situazione di incompatibilità.
Fatti
Nella sua essenzialità (per ciò che interessa al tema), il ricorso viene promosso avverso una deliberazione di Consiglio comunale riferita alla presa d’atto dell’efficacia ed esecutività del Piano Regolatore Generale (PRG), rilevando una serie di violazione alle norme sull’incompatibilità e sull’imparzialità amministrativa: la deliberazione veniva approvata dal voto favorevole dei consiglieri già dichiaratisi incompatibili al momento dell’approvazione.
Infatti, (a suo tempo) il provvedimento urbanistico di adozione dello strumento urbanistico generale veniva approvato da un Commissario ad acta stante una situazione generale di incompatibilità dei membri del Consiglio comunale.
Il Comune resistente evidenziava che la deliberazione consiliare impugnata non avrebbe natura provvedimentale, ma rappresenterebbe un atto meramente ricognitivo: una costatazione dell’esistenza dell’efficacia sopravvenuta del Piano Regolatore Generale.
Lesività dell’atto e non mera ricognizione
In via preliminare viene respinta l’eccezione di inammissibilità, atteso che l’atto risulta in grado di incidere le posizioni soggettive del ricorrente, e dunque non avrebbe natura meramente ricognitiva e, in quanto privo di autonoma efficacia lesiva, non suscettibile di autonoma impugnazione per carenza di interesse al ricorso.
In effetti, se in linea generale un atto ricognitivo si limita a prendere atto dell’efficacia di provvedimenti preesistenti o di effetti giuridici prodotti direttamente dalla legge, senza incidere in modo diretto e innovativo sulla sfera giuridica dei destinatari rispetto ad un atto provvedimentale che implica l’esercizio di potere amministrativo e produce effetti modificativi, costitutivi o estintivi di situazioni giuridiche soggettive.
Nel caso di specie, al di là del titolo di “presa d’atto” dell’efficacia del PRG, il provvedimento non si limitata a una mera attestazione dell’efficacia giuridica di atti preesistenti, al contrario, l’atto impugnato, incide in modo sostanziale sul contenuto del piano urbanistico già adottato, adeguandolo alle prescrizioni contenute in un parere motivato VAS, modificando le aree di proprietà della parte ricorrente che originariamente avevano una diversa destinazione (da edificabili e zona agricola), determinando un’immediata e concreta incidenza negativa sulla potenzialità edificatoria dei fondi, con evidente pregiudizio (motivi di accoglimento del ricorso per la violazione della procedura di adozione in variante (di esteso contenuto rispetto al provvedimento iniziale): è mancata tout court la procedura di partecipazione essendo, appunto, una variante al PRG già adottato).
Merito
Nel merito il ricorso viene accolto per altri motivi (non trattati nel presente commento), con condanna alle spese, mentre per la presenza del conflitto di interessi dei consiglieri votanti la questione risulta infondata sulla base delle seguenti argomentazioni:
- l’invalidità dell’atto adottato da un organo collegiale può derivare da tali vizi solo in presenza di una comprovata incidenza concreta sull’imparzialità e sul corretto svolgimento del procedimento;
- ne deriva che non è sufficiente la mera allegazione di un interesse personale o familiare in astratto, ma occorre dimostrare, con elementi puntuali e specifici, che la partecipazione dei consiglieri abbia condizionato in modo determinante l’esito della deliberazione;
- invero, l’ipotesi del conflitto di interessi non può essere predicata in astratto, ma deve essere accertata in concreto sulla base di prove specifiche: la minaccia all’imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura deve essere dimostrata sulla base di presupposti specifici e concreti, tali da far ritenere che la decisione sia stata assunta in una situazione di compromissione oggettiva o soggettiva della funzione pubblica esercitata [8].
Il Tribunale aderisce all’interpretazione formulata espressamente dalla disciplina del codice dei contratti pubblici, dove viene espresso un principio che ha portata generale e si applica, mutatis mutandis, «a tutti i procedimenti amministrativi, compresi quelli di formazione e approvazione degli strumenti urbanistici».
In simbiosi con la nuova formulazione del conflitto di interessi presente nel d.lgs. n. 36/2023, la parte ricorrente non è stata in grado di dimostrare le presunte incompatibilità ma si è limitata a rinviare ad un precedente (le dichiarazioni di incompatibilità riferite al momento di adozione del PRG), senza aggiungere una dimostrazione attuale sulla presenza (permanenza) delle condizioni ostative al voto, rectius il conflitto di interessi attuale (presente al momento del voto).
La prova
A ben vedere, al di là della norma sopraggiunta, l’assenza – nel testo deliberativo – di una espressa dichiarazione dell’assenza di un conflitto di interessi da parte dei consiglieri comunali, porta a ritenere l’assenza del cit. conflitto, ben potendo medio tempore aver alienato i beni, facendo venir meno la condizione iniziale di impedimento: nella sostanza non viene fornita prova che i medesimi consiglieri avessero mantenuto interessi attuali, diretti e specifici sull’oggetto della deliberazione.
La mancata dimostrazione della violazione dell’obbligo di astensione è equivalente al caso della presenza – nelle commissioni di concorso – di legami “intensi” tra commissari e candidati, dovendo dimostrare la rilevanza dell’intensità e non la semplice frequentazione (mera occasionalità): non costituisce ragione di incompatibilità la sussistenza sia di rapporti di mera collaborazione scientifica, sia di pubblicazioni comuni, essendo ravvisabile l’obbligo di astensione del componente della commissione solo in presenza di una comunanza di interessi anche economici, di intensità tale da porre in dubbio l’imparzialità del giudizio [9].
In termini diversi, le deduzioni da invocare sulla presenza dell’intensità non si devono limitare solo a insinuare meri sospetti o ad elencare dei contatti ma devono assurgere a prove inconfutabili che i rapporti tra allievo e maestro sono solidificati da “relazioni” costanti tali da assimilare una condivisione che va ben al di là del naturale rapporto di frequentazione sempre possibile in ambienti accademici: va provato questo travalicamento in una comunione di vita che non consente di slegare le identità di azione (aspetto fattuale non semplice da fornire) [10].
Conclude la sentenza con questa evidenza dei fatti: «Né risulta provato che i voti da essi espressi abbiano avuto carattere determinante o che l’organo consiliare fosse altrimenti impedito a deliberare. In mancanza di un concreto riscontro dell’incidenza del supposto conflitto sull’imparzialità del procedimento, la doglianza non può essere accolta e va respinta».
Superamento del conflitto di interessi potenziale
La sentenza nella sua linearità espositiva affronta un tema sempre vivo, se la nuova formulazione del conflitto di interessi operata dal Codice dei contratti, e dei relativi principi presenti nei primi articoli del cit. Codice, innova l’esegesi, con una proiezione a tutti i procedimenti amministrativi, non può che significare l’abbandono del sospetto, delle mere illazioni, dell’esigenza pratica di contestare la condotta solo quando vi è la certezza (da dimostrare caso per caso) della presenza attuale del conflitto di interessi, non potendo operare a livello di “potenzialità”, o “idoneità possibile” (richiamandosi alla formulazione dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990).
Si va oltre – con il d.lgs. n. 36/2023 – alla situazione di incompatibilità che porta alla valutazione del conflitto in astratto non potendo più essere predicata la presenza su vincoli presuntivi ma solo in termini di effettività provata (reale): una lettura più che sostanziale della norma, dovendo – il conflitto di interessi – essere accertato in concreto (nel suo modo visivo di presentarsi) sulla base di prove specifiche e puntuali (le interessenze), con ciò sposando una valutazione tangibile (oggettiva/palpabile), abbandonando – superando – la via della rilevanza del conflitto in astratto [11].
Non sarà possibile invocare la presenza di un conflitto di interesse se non si riesce superare l’onere della prova, rendendo del tutto possibile la prova di resistenza: la parte che ritiene la presenza del conflitto di interessi non potrà limitarsi ad enucleare le condizioni, dovendo presentare al giudice sia i fatti che l’interesse personale del soggetto agente nella sua effettività del vantaggio conseguito: un binomio tra condotta e interesse personale che deve rispondere ad un’utilità conseguibile (misurabile).
Contesto di riforme
Assistiamo ad un momento particolare, da alcuni definito “suggestivo”, della storia del diritto dove si declama la cura della salute “liberalizzando” il fine vita, la pace armandosi (sforando ogni limite di bilancio), la trasparenza e la legalità scardinando le regole: nell’indifferenza (fermiamoci).
Con il “delirio” della “regolamentazione” del distanziamento Covid – 19, abbiamo conosciuto la funzione legislativa del Governo (esautorando il Parlamento), anzi delle ordinanze, anzi dei dpcm [12], anzi delle dirette Facebook, dei colori a fasce per limitare le libertà di movimento, segregando le persone, in una lettura alquanto discutibile (censurabile) della Costituzione ma pienamente operante [13].
In questo contesto di emergenza sanitaria prima, energetica dopo, abbiamo assistito:
- alla creazione dello “scudo penale” per i vaccinatori (ex 3, Responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, del DL 44/2021);
- all’avvento dello “scudo erariale” per risolvere la c.d. paura della firma, più volte prorogato (vedi, l’art. 1, Differimento del termine in materia di responsabilità erariale, del DL 12 maggio 2025, n. 68, «Il termine di cui all’articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, relativo alla responsabilità erariale è differito al 31 dicembre 2025. La disciplina ivi prevista trova applicazione anche per i fatti commessi tra il 30 aprile 2025 e la data di entrata in vigore del presente decreto»);
- ed anche il Codice dei contratti pubblici, tra i principi fondamentali intende rispondere al timore della firma per assicurare “fiducia”, “risultato” e “autoresponsabilità”.
In questi giorni (da qualche giorno) percepiamo la piena legittimità costituzionale dell’abrogazione dell’abuso d’ufficio [14], ed invero anche la precedente revisione rispondeva sempre alla “fuga” della firma (c.d. burocrazia difensiva), senza dimenticare l’abrogazione del comma 2, dell’art. 7, Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale, del d.lgs. n. 39/2013, inserito in sede di conversione del DL n. 202/2024 (c.d. mille proroghe) [15], e la precedente incostituzionalità di parte della norma [16], senza tralasciare (fuori contesto) la riforma sull’uso delle intercettazioni.
In tutto questo rifluire di tutele e protezioni evocative (dei tanti scudi mitici dell’epica classica), non può mancare la riforma della Corte dei conti, sempre per rispondere alla cosiddetta «paura della firma» che «affligge il funzionamento della pubblica amministrazione italiana. Si tratta di un problema complesso, che è stato affrontato sotto il profilo penale e che, con effetti che potranno rivelarsi ancor più positivamente dirompenti, necessita di trovare una soluzione anche sul piano della gestione delle risorse pubbliche» [17]; quella dell’accesso al pubblico impiego è sempre un evergreen (DL n. 25/2025).
Perle
Che dire… il “conflitto di interessi”, in questa scia devozionale, viene ridimensionato in una lettura restrittiva, perdendo il proprio impianto per dare ingresso all’onere della prova, per ridurre la “paura” dell’agire amministrativo nel raggiungimento dello scopo, dimenticando (improbabile negligenza) la costante (continua) mole di norme/format che quotidianamente le diverse Autorità sfornano, pretendendo di semplificare il lavoro.
Questi protagonisti del diritto, questi esperti senza titoli, insegnano il lavoro non avendo mai lavorato.
Non è simpatico (!).
Note
[1] Nel caso in cui abbia partecipato alla delibera un soggetto che avrebbe dovuto astenersi perché in conflitto di interessi, non è necessario operare la c.d. “prova di resistenza”: ove ricorra una simile evenienza, la delibera del collegio deve ritenersi sempre illegittima, in quanto i soggetti interessati alle deliberazioni assunte dagli organi collegiali di cui fanno parte devono evitare di partecipare finanche alla discussione, potendo condizionare nel complesso la formazione della volontà assembleare, Cons. Stato, sez. V, 13 giugno 2008, n. 2970.
[2] Le situazioni di conflitto d’interesse, nell’ambito dell’ordinamento pubblicistico, non sono tassative, ma possono essere rinvenute volta per volta, in relazione alla violazione dei principi di imparzialità e buon andamento sanciti dall’art. 97 Cost., Cons. Stato, sez. V, 19 settembre 2006, n. 5444. Per quanto non esista, all’interno del quadro normativo, una definizione univoca e generale che preveda analiticamente tutte le ipotesi di tale fattispecie, il conflitto di interessi viene definito dalla giurisprudenza come quella condizione giuridica che si verifica quando, all’interno di una pubblica amministrazione, lo svolgimento di una determinata attività sia affidato ad un funzionario che è contestualmente titolare di interessi personali o di terzi, la cui eventuale soddisfazione implichi necessariamente una riduzione del soddisfacimento dell’interesse dell’Amministrazione, Cons. Stato, sez. VI, 22 marzo 2022, n. 2069.
[3] TAR Lazio, Roma. sez. I, 23 febbraio 2024, n. 3669.
[4] La disciplina in materia tende ad anticipare la frontiera del contrasto a fenomeni corruttivi e comunque del rischio possibili vizi e condizionamenti, dovendo osservare che la disciplina va interpretata nel considerare rilevanti quelle situazioni che possano suscitare il dubbio che la sequenza decisionale o selettiva possa essere stata influenzata da comportamenti inappropriati, tenuto conto di tutti gli interessi coinvolti, dove (nelle gara d’appalto) il vantaggio competitivo dell’aggiudicatario, potrebbe essere determinata anche solo dalla anticipata conoscenza degli atti di gara o di possibile acquisizione di informazioni qualificate (afferenti al progetto e al capitolato), riservate e di specifico orientamento sulle aspettative e sui gradimenti della stazione appaltante, Cons. Stato, sez. III, 20 agosto 2020, n. 5151.
[5] TAR Lazio, Roma, sez. II, 31 luglio 2023, n. 12917, nella vigenza dell’art. 42 del d.lgs. n. 50/2026, al fine di delimitare l’ampio raggio di operatività della nozione di conflitto di interesse, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che l’ipotesi di conflitto d’interessi deve essere supportata da elementi concreti, specifici ed attuali, Cons. Stato, sez. III, 26 marzo 2021, n. 2581: l’ipotesi del conflitto di interessi non può essere, infatti, predicata in via astratta, ma deve essere accertata in concreto sulla base di prove specifiche, Cons. Stato, sez. V, 6 maggio 2020, n. 2863.
[6] Cass. civ., sez. lav., 17 febbraio 2025, n. 4075, ove si osserva che la presenza astratta porta delle conseguenze concrete, essendo di contro ininfluente che esso si sia nel concreto realizzato, ove si consideri che gli obblighi imposti al pubblico dipendente mirano a garantire la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa e, ad un tempo, a prevenire fenomeni di corruzione.
[7] TAR Campania, Napoli, sez. III, 13 marzo 2024, n. 1696.
[8] Cons. Stato, sez. III, 11 luglio 2024, n. 6211.
[9] Cfr., Cons. Stato, sez. VI, 3 luglio 2014, n. 3366; sez. III, 20 settembre 2012 n. 5023; sez. VI, 31 maggio 2012, n. 3276.
[10] Cfr. Cons. Stato, sez. VII, 3 maggio 2024, n. 4028.
[11] TAR Lazio, Latina, sez. II, 14 febbraio 2024, n. 125.
[12] Cfr. Cons. Stato, sez. III, 9 aprile 2025, n. 3038, sulla legittimità formale del ricorso da parte del legislatore ordinario, alla previsione dell’adozione di decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri per le misure di prevenzione del contagio. Si annota che «la Corte costituzionale, nella sentenza n. 14 del 2023 relativa alla somministrazione vaccinale anti Covid-19, ha chiarito che anche dall’art. 32 della Costituzione si evince una dimensione di tutela solidaristica della salute collettiva tale da prevalere perfino (non già sulla libertà di iniziativa economica, ma) sulla salute come fondamentale diritto dell’individuo».
[13] Si rinvia, LUCCA, Dalle Idi di marzo (fase zero punto zero) al contagio dei DPCM (fase quattro punto zero), comedonchisciotte.org, 14 novembre 2020.
[14] Corte cost., Comunicato ad oggetto, Non è incostituzionale l’abrogazione del reato di abuso d’uffici, 8 maggio 2025, dove si legge «Nel merito, la Corte ha dichiarato infondate tali questioni, ritenendo che dalla Convenzione non sia ricavabile né l’obbligo di prevedere il reato di abuso d’ufficio, né il divieto di abrogarlo ove già presente nell’ordinamento nazionale».
[15] Vedi Atto di segnalazione ANAC n. 2 del 26 marzo 2025, per chiedere la tempestiva modifica della legge 21 febbraio 2025, n.15, per quanto riguarda le disposizioni in materia di inconferibilità.
[16] Corte Cost., sentenza n. 98 del 4 giugno 2024, ove sembrerebbe di comprendere che la separazione di ruoli costituisce un imperativo categorico (una forma eticamente sensibile del dover essere), assegnando alla provenienza politica una capacità “certificata” ex lege di condizionare gli eventi: l’assegnazione di un incarico, mentre l’aver ricoperto un incarico tecnico costituirebbe un esimente al raffreddamento, come se il raffreddamento (una fictio iuris) escludesse la permanenza del conflitto di interessi (e viceversa).
[17] Relazione presentata il 19 dicembre 2023 alla Camera dei Deputati, alla Proposta di Legge d’iniziativa del deputato FOTI N. 1621 — Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale.
Vedi, TENORE, La “paura della firma” e “la fatica dell’amministrare” tra mito e realtà: categorie reali o mera giustificazione per l’impunità normativa degli amministratori pubblici? dalla “corte dei conti” alla “corte degli sconti”, Rivista della Corte dei conti, 2025, 1, dove si conclude con il «sentore che i fluidi ed umorali concetti di “paura della firma”, “burocrazia difensiva” e “fatica dell’amministrare”, sovrastimati dal solo legislatore ed ascritti solo e soltanto a giudici persecutori, siano stati mera giustificazione per un intervento normativo protettivo, purtroppo avallato dalla Corte costituzionale, teso a fornire una “corazza erariale” (ovvero una “immunità giuscontabile”) agli amministratori locali (più che ai dipendenti), a danno dei bilanci pubblici e dunque della collettività, che paga le tasse e pretende corretta spesa dei soldi pubblici e servizi gestiti da soggetti competenti ed onesti che, ove sbaglino, dovrebbero pagare integralmente e non simbolicamente, accollando i costi del “non recuperato” sulla collettività. Si è raggiunto il mal celato obiettivo della trasformazione della Corte dei conti nella Corte degli sconti, giudice della “(ir)responsabilità amministrativa”».
The post Il TAR sul conflitto di interessi del consigliere comunale in sede di votazione appeared first on lentepubblica.it.