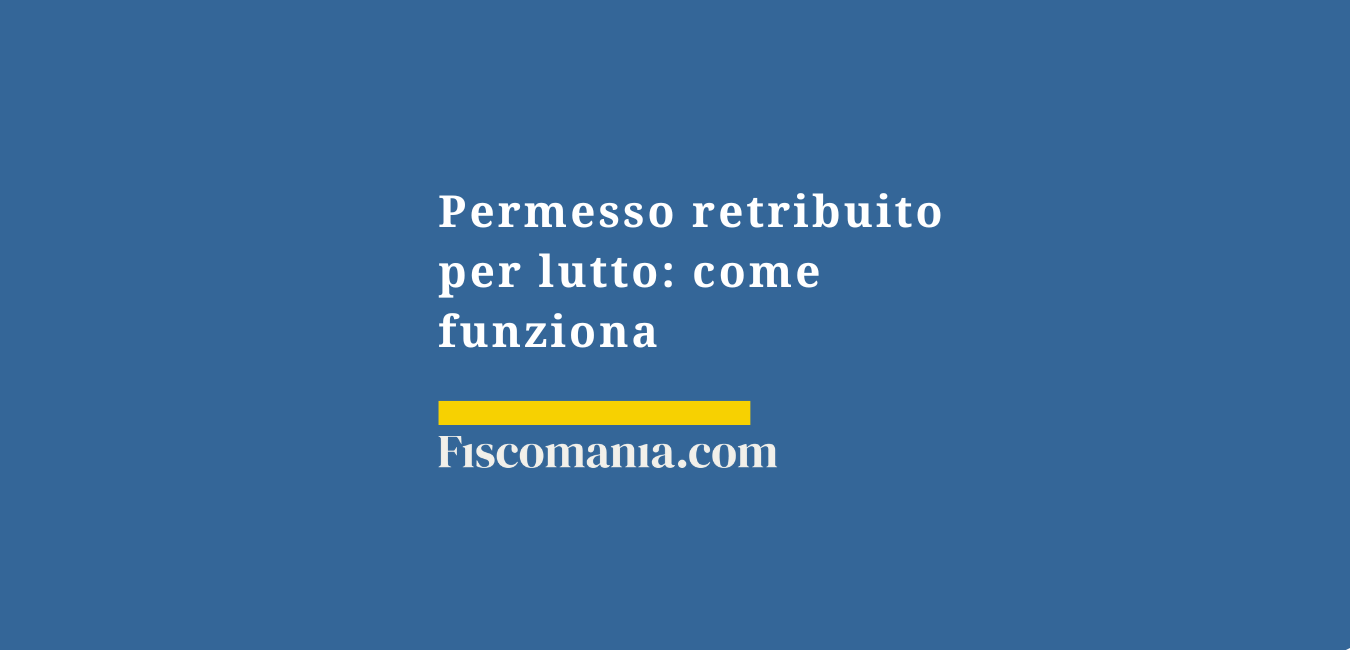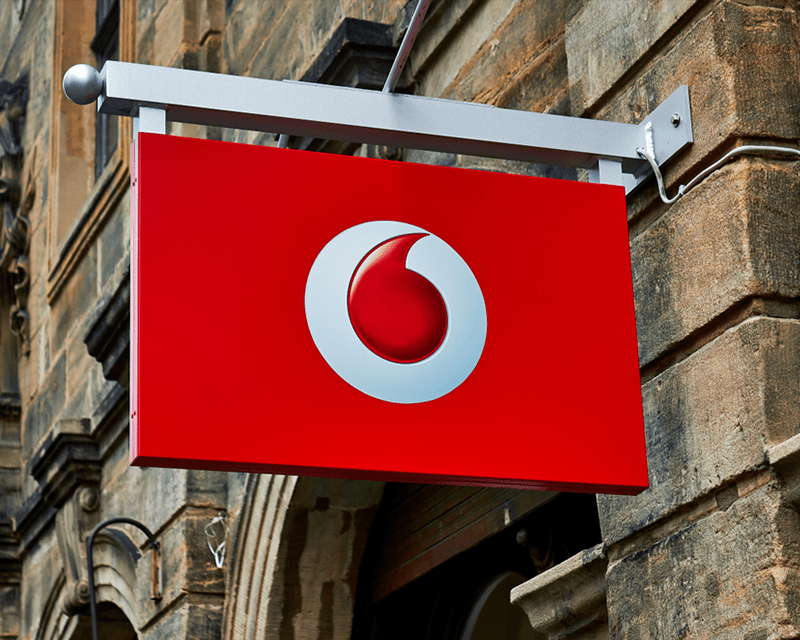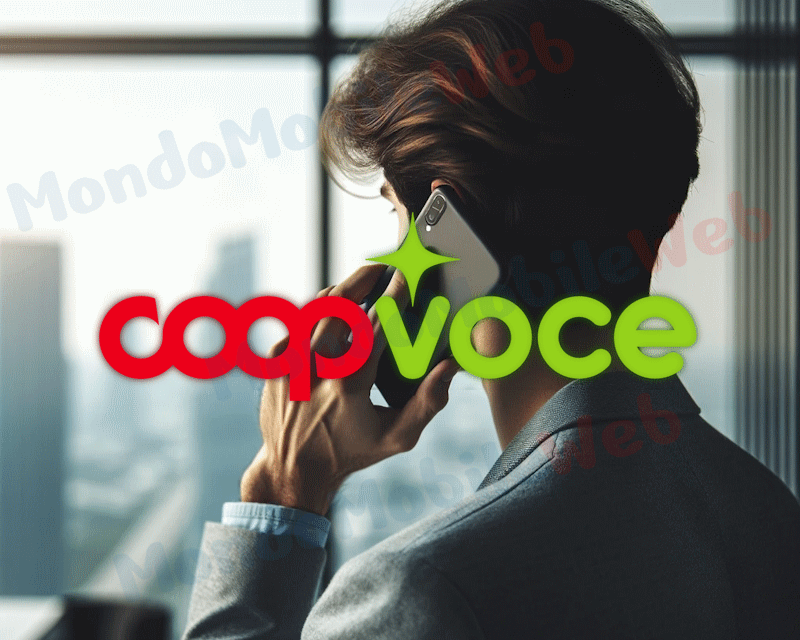Il DL Sicurezza è l’ennesimo passo verso l’autoritarismo. Dobbiamo smetterla di stare in silenzio.
Se i diversi report e denunce di enti internazionali potevano non allarmarci a sufficienza denunciando il deterioramento dello stato di diritto in Italia, l’esecutivo Meloni ha pensato bene di renderne chiaro il senso pratico. Con il “decreto Sicurezza”, il governo italiano ha compiuto un passo che non solo ridefinisce il perimetro del controllo statale sul dissenso e sulla gestione dell’ordine pubblico, ma che solleva interrogativi profondi sulla tenuta dello stato di diritto e sulle garanzie costituzionali, rafforzando in maniera inedita i poteri repressivi dello Stato. L'articolo Il DL Sicurezza è l’ennesimo passo verso l’autoritarismo. Dobbiamo smetterla di stare in silenzio. proviene da THE VISION.

Se il report di Civil Liberties Union for Europe, pubblicato lo scorso mese, poteva non allarmarci a sufficienza denunciando il deterioramento dello stato di diritto in Italia, l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni ha pensato bene di renderne chiaro il senso pratico. Con l’approvazione e l’entrata in vigore del “decreto Sicurezza”, il governo italiano ha compiuto un passo che non solo ridefinisce il perimetro del controllo statale sul dissenso e sulla gestione dell’ordine pubblico, ma che solleva interrogativi profondi sulla tenuta dello stato di diritto e sulle garanzie costituzionali. Dietro la retorica della fermezza e della tutela dei cittadini si cela un impianto normativo che, nei fatti, rafforza in maniera inedita i poteri repressivi dello Stato, con un’attenzione particolare al sistema penitenziario e ai servizi segreti, rendendo ancora più marginali e conflittuali le sezioni della nostra società ritenute più fragili.
Il testo del decreto, inizialmente presentato come disegno di legge, ha incontrato fin da subito forti resistenze sia da parte dell’opposizione sia, più sottilmente, da ambienti istituzionali legati alla presidenza della Repubblica. Le obiezioni sollevate dal Quirinale riguardavano in particolare la vaghezza di alcune formulazioni, la sproporzione delle pene previste e la possibilità di violazioni dei principi costituzionali, in primis quelli di uguaglianza, proporzionalità e offensività. Nonostante queste riserve, e le pressioni per modificare almeno gli articoli più critici, il governo ha scelto una strada diversa. Con una decisione definita da molti osservatori “irrituale”, il disegno di legge è stato trasformato in decreto-legge, uno strumento per sua natura riservato a situazioni di urgenza e necessità. Questa scelta ha permesso all’esecutivo di eludere il dibattito parlamentare più approfondito, riducendo il margine di intervento delle Camere, stralciando gli emendamenti delle opposizioni e rafforzando l’impianto originario, in nome della rapidità.

Dietro questa accelerazione legislativa si è consumata una tensione evidente all’interno della stessa maggioranza. La Lega di Matteo Salvini ha spinto per approvare il testo nella sua versione più dura, ritenendolo uno strumento simbolico per riaffermare il proprio ruolo identitario all’interno della coalizione. Fratelli d’Italia, pur condividendo l’impostazione securitaria, ha tentato una mediazione più istituzionale, per evitare rotture con il Quirinale. Ma ha prevalso la linea muscolare: blindare il testo, tagliare le fasi intermedie e presentare la sicurezza come un feticcio politico non negoziabile. Il risultato è stato un decreto che, nella sua forma definitiva, mantiene quasi intatto l’impianto originario, compresi i passaggi più controversi.
Tra le novità più discusse, l’introduzione del reato di “rivolta in carcere” ha attirato da subito l’attenzione della stampa e degli osservatori internazionali. Il nuovo articolo 415-bis del codice penale punisce qualunque atto di violenza, minaccia o resistenza, anche passiva, commesso da tre o più persone all’interno di un istituto penitenziario. La norma è stata criticata per la sua voluta ambiguità, con l’unico effetto di inasprire le sanzioni e restringere ulteriormente gli spazi di dissenso. Secondo l’associazione Antigone, il rischio è che si finisca per punire proteste non-violente, come scioperi della fame, rifiuti simbolici o anche la battitura delle sbarre. Tutti gesti che, nel contesto carcerario, rappresentano spesso l’unica forma possibile di espressione politica e di denuncia. Patrizio Gonnella e Susanna Marietti, dell’associazione Antigone, hanno più volte sottolineato in questi mesi l’inadeguatezza di una norma che criminalizza il dissenso laddove mancano strumenti reali di partecipazione o difesa dei diritti. In un sistema penitenziario già segnato da sovraffollamento, carenze strutturali e disuguaglianze sociali, l’introduzione di un reato come quello di rivolta appare come un tentativo di reprimere il sintomo senza curare la malattia.

Le critiche non si fermano alle associazioni italiane. Il Consiglio d’Europa, attraverso il commissario per i diritti umani Michael O’Flaherty, aveva espresso a dicembre una “profonda preoccupazione” per le norme contenute in quello che allora era un disegno di legge, in particolare per il rischio che le nuove pene fossero trasformate in uno strumento di repressione arbitraria. Nella lettera si chiedeva al presidente del Senato Ignazio La Russa e ai senatori di non procedere con la promulgazione. Per rispondere al commissario, il governo ha accelerato. Ora l’ONU, attraverso i suoi relatori speciali che sorvegliano il diritto interno dei Paesi, ha chiesto formalmente al governo italiano di ritirare le norme più problematiche, definendole una minaccia alla libertà di espressione e al diritto di protesta pacifica. Segnalazioni che, finora, non hanno trovato alcuna risposta istituzionale.
Il decreto estende inoltre la logica delle carceri anche ai Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR), contesti già segnati da documentate condizioni di detenzione degradanti. E anche qui, la protesta rischia di diventare un reato, mentre il contesto di degrado strutturale e mancanza di trasparenza resta inalterato. Criminalizzare le proteste in questi luoghi significa, di fatto, togliere anche l’ultima possibilità di parola, e spesso di visibilità mediatica, a chi già non ha voce. Il quadro che emerge è quello di una repressione che si fa norma, con strumenti giuridici concepiti per scoraggiare la mobilitazione sociale e rendere sempre più difficile ogni forma di resistenza. A confermarlo è quanto accaduto a Milano, durante la manifestazione in solidarietà con la Palestina: le immagini degli scontri e dell’uso sproporzionato della forza raccontano di un equilibrio ormai compromesso tra il diritto a manifestare e il mantenimento dell’ordine pubblico.

Su questa linea, il decreto Sicurezza rafforza in modo sistematico le tutele per gli agenti: prevede rimborsi legali fino a 10.000 euro per ogni fase processuale e inasprisce le pene per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Nessun obbligo di codici identificativi, bodycam facoltative, e porto d’armi private consentito anche fuori servizio, senza licenza. A ciò si aggiungono norme che colpiscono direttamente la protesta organizzata: una nuova aggravante, definita “norma anti-TAV”, introduce pene più severe per chi si oppone alla realizzazione di infrastrutture strategiche. Vengono colpiti con sanzioni anche i manifestanti per il clima e le loro proteste non violente di blocco stradale. In altre parole, maggiore protezione per chi esercita il potere, meno trasparenza per chi ne subisce gli effetti.
Nel decreto è poi contenuta un’altra battaglia donchisciottesca della Lega: verrà vietata la cannabis light, colpendo un settore che impiega migliaia di persone e favorendo il mercato illegale controllato dalle mafie. Il governo sembra aver ceduto invece sulla norma contenuta nell’articolo 31, tra le più controverse del provvedimento, che nella sua formulazione originaria prevedeva per i servizi segreti un accesso esteso – e in deroga alla normativa sulla privacy – ai dati sensibili detenuti da enti pubblici. Università, ospedali e società partecipate avrebbero dovuto fornire informazioni riservate, comprese cartelle cliniche o orientamenti politici, senza possibilità di opporsi e senza che fosse previsto un rafforzamento del controllo da parte del COPASIR, la commissione parlamentare preposta alla vigilanza. Inquietante, soprattutto alla luce della storia repubblicana dei nostri apparati di intelligence, di cui però la destra non sembrava affatto preoccuparsi.

Nel decreto è stata rivista anche la norma che ha suscitato un acceso dibattito per il suo carattere discriminatorio: quella che inizialmente prevedeva l’obbligo per le persone extracomunitarie di esibire un permesso di soggiorno per acquistare una scheda telefonica. Una misura che, nella sua formulazione originaria, avrebbe escluso migliaia di persone dalla possibilità di accedere a uno strumento oggi indispensabile per comunicare, lavorare e completare le procedure burocratiche che servono all’ottenimento del permesso di soggiorno stesso. Dopo le critiche sollevate anche da alcune forze della maggioranza, il testo definitivo ha attenuato il requisito, prevedendo che sia sufficiente un documento di identità valido. Resta tuttavia il segnale politico: la sicurezza viene ancora una volta declinata come controllo preventivo delle minoranze, nel solco di una cultura dell’esclusione. Particolarmente allarmante è anche il cambio di passo nella gestione delle detenute madri. Finora, la legge prevedeva il rinvio obbligatorio della pena per le donne incinte o con figli di età inferiore a un anno. Il decreto Sicurezza introduce invece l’obbligo di detenzione in istituti a custodia attenuata (ICAM). Una modifica apparentemente neutra che però, nella sua applicazione concreta, colpisce soprattutto le donne straniere o rom, spesso arrestate per reati minori. Non è difficile cogliere in questa scelta una chiara impronta discriminatoria, che nulla ha a che vedere con il principio rieducativo della pena.

L’intero impianto del decreto, insomma, appare costruito non per risolvere problemi concreti di sicurezza, ma per dare forma normativa a una visione del mondo. Una visione che punta a ridefinire i confini della cittadinanza e a tracciare nuove linee di inclusione ed esclusione. Il dissenso, la marginalità, la povertà, la fragilità sociale non sono più considerate condizioni da affrontare politicamente, ma da contenere giuridicamente. Il decreto Sicurezza non rappresenta un argine al caos, anche perché i reati in Italia diminuiscono di anno in anno, ma un sintomo del disagio di una democrazia che fatica a riconoscere se stessa. Nel silenzio generale, tra la stanchezza mediatica e la normalizzazione dell’emergenza, la compressione degli spazi democratici avanza, un decreto alla volta. Ma la storia recente insegna che la repressione non è mai neutra: ha sempre un bersaglio, e troppo spesso quel bersaglio non è chi minaccia la convivenza civile, ma chi la difende con mezzi fragili: la parola, il corpo, la presenza pubblica. In una democrazia, il vero punto di rottura non arriva con la prima manganellata impunita, ma con l’ultimo silenzio. E oggi, quel silenzio, è già più vicino di quanto sembri.
L'articolo Il DL Sicurezza è l’ennesimo passo verso l’autoritarismo. Dobbiamo smetterla di stare in silenzio. proviene da THE VISION.