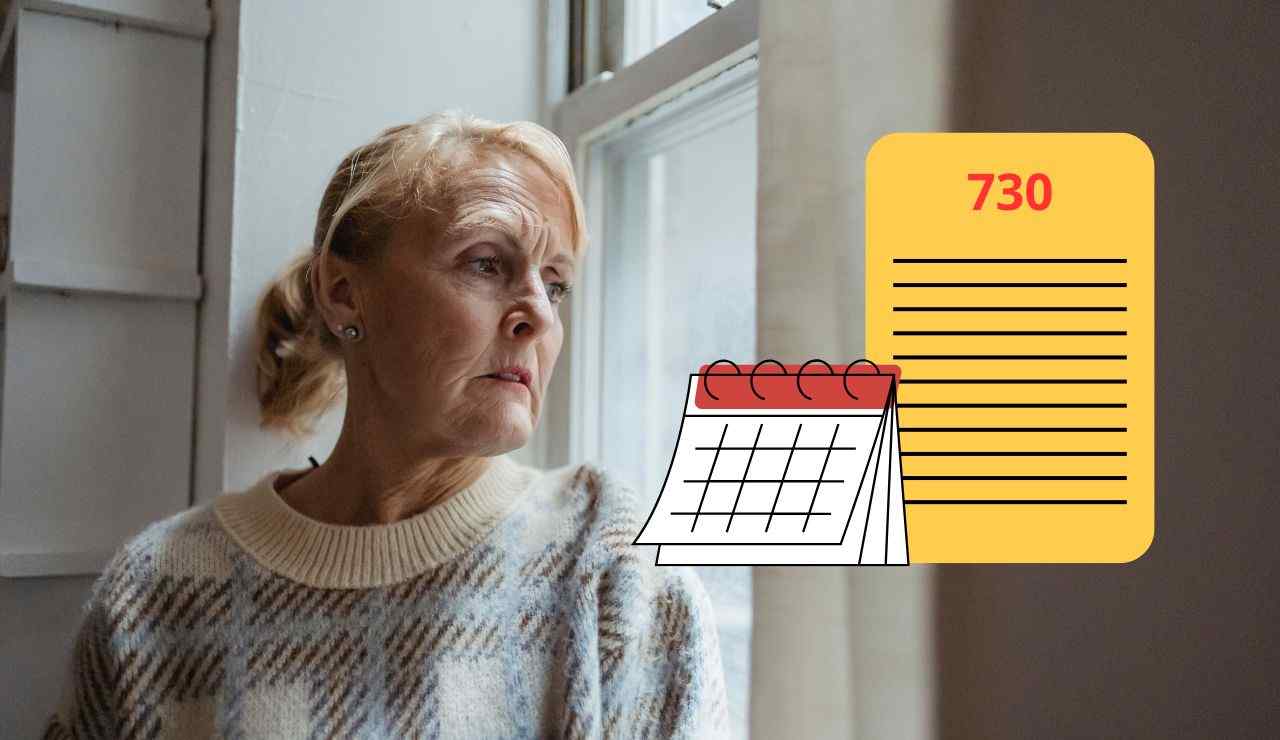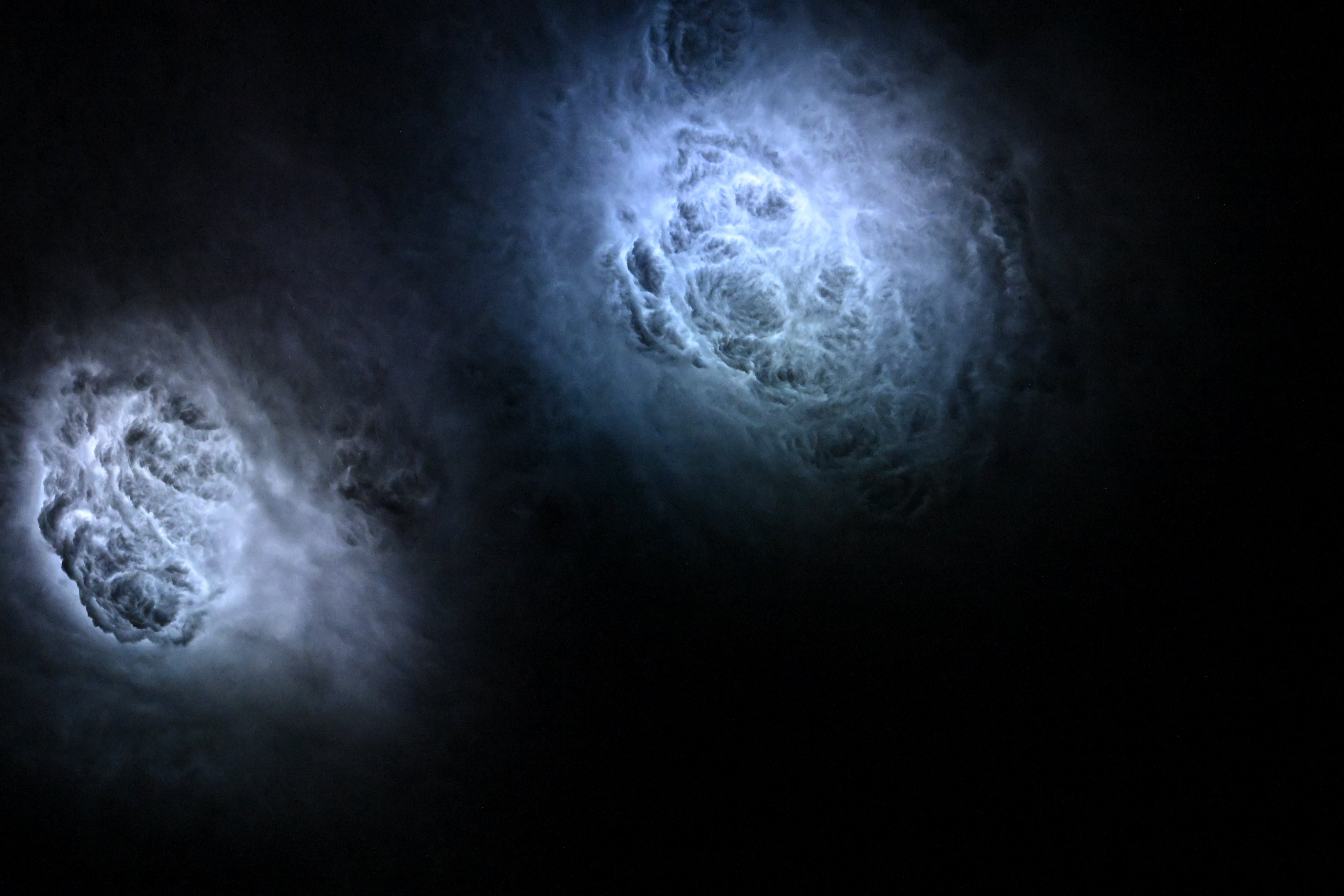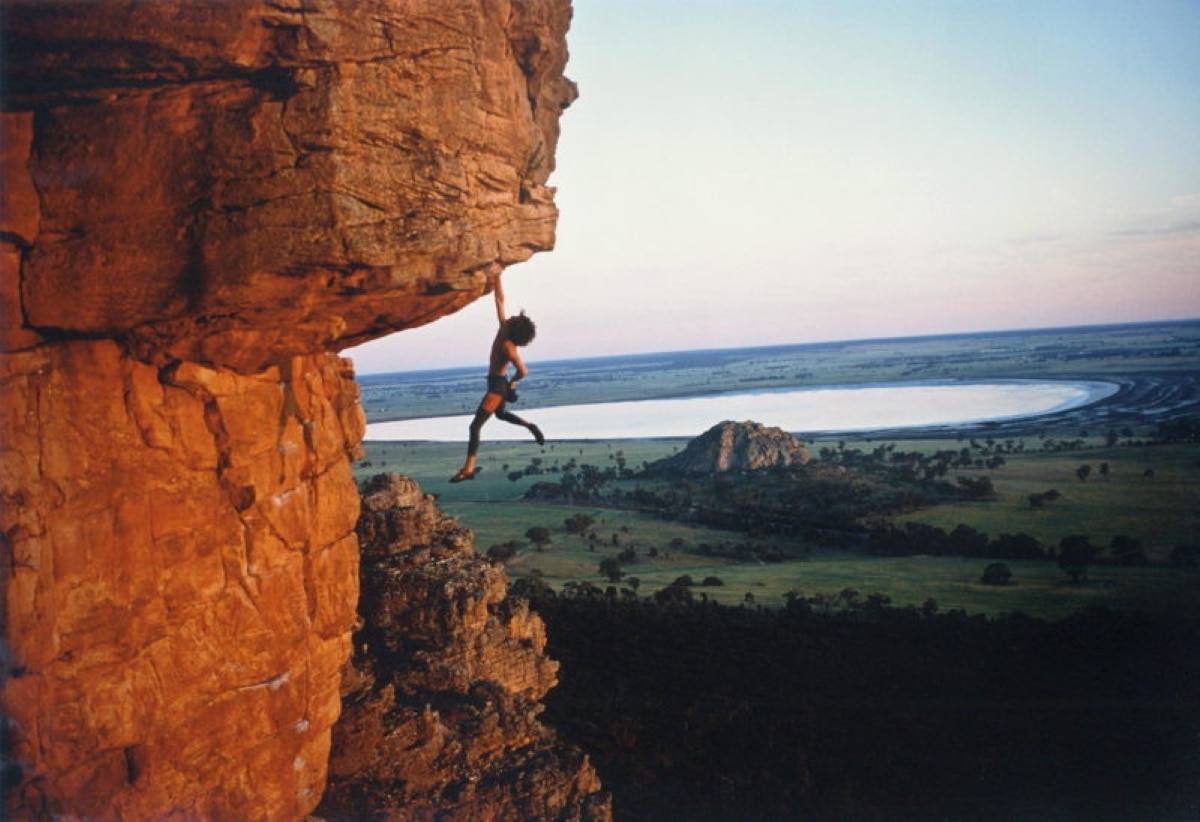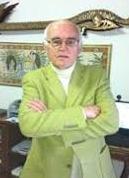Cesare contro Pompeo: la battaglia che decise il destino della Repubblica Romana
Quando, nell'anno 49 a.C., Giulio Cesare attraversò il Rubicone e si lanciò con il suo esercito alla conquista del potere a Roma, sapeva che davanti a lui si sarebbe alzato uno dei personaggi più potenti e popolari della politica romana dei decenni precedenti: Cneo Pompeo Magno.Tra i due non c'era odio. In un certo senso, avevano molte cose in comune. Si erano divisi il potere durante il periodo del primo triumvirato (60-53 a.C.) e si erano imparentati attraverso Giulia, la figlia di Cesare, che era diventata moglie di Pompeo. La morte di Giulia nel 54 a.C., in seguito a un parto, e la fine del triumvirato dopo la morte di Crasso (il terzo triumviro) in una battaglia contro i Parti l'anno successivo contribuirono ad allontanarli.Parallelamente, Pompeo si avvicinò a figure come Catone e Cicerone, che difendevano con passione l'ordine tradizionale della Repubblica romana contro le ambizioni palesi del grande vincitore della Gallia. Fu così che nel 49 a.C., unico console in carica, Pompeo si mise alla testa delle legioni del Senato per respingere l'assalto di Cesare.Ritirata strategicaDi fronte alla totale mancanza di resistenza opposta dalle città italiane all'avanzata di Cesare, Pompeo optò per una ritirata strategica, marciando verso il sud della penisola. Dal porto di Brindisi salpò verso est, dove contava su una vasta clientela e su notevoli risorse. Nella fuga fu accompagnato dalla maggior parte dei senatori che lo avevano sostenuto, timorosi delle ritorsioni di Cesare. Nei mesi successivi, Cesare sconfisse i pompeiani nelle battaglie di Massalia e Ilerda e al suo ritorno a Roma fu nominato console. Poi, sapendo che Pompeo stava radunando un potente esercito in Oriente per attaccare l'Italia, partì, in pieno inverno, verso le coste dell'Epiro, nell'attuale Albania, alla ricerca dello scontro definitivo con il suo rivale.Dopo sei mesi di scaramucce, Cesare si diresse verso la piazza portuale di Dyrrhachium (Dürres), base principale delle operazioni di Pompeo in Macedonia. Ma lungi dal conquistare la città, l'assalto finale, il 10 luglio, si concluse con centinaia di caduti nel suo campo. Di fronte all'inutilità di prolungare la lotta in quel luogo, Cesare decise di addentrarsi in Tessaglia. Ad Aeginion, l'odierna Kalambaka, incorporò nel suo esercito le legioni comandate dal suo luogotenente Domizio Calvino. Il parziale fallimento a Dyrrhachium aveva fatto sì che molte città della zona non riconoscessero più la sua autorità; per ristabilirla, Cesare saccheggiò Gomfi e ottenne la resa di Metropolis.Pompeo doveva condividere la strategia militare con i senatori che lo sostenevano, nonostante la totale inesperienza militare di alcuni di loro.Per quanto riguarda Pompeo, dopo Dirazio avrebbe potuto tornare in Italia e metterla sotto il suo controllo, come gli consigliavano i suoi luogotenenti. Ma preferì rimanere in Macedonia e, con il rinforzo delle legioni comandate da suo suocero Metello Scipione, si lanciò all'inseguimento di Cesare.Lo scontro decisivo tra i due ex triumviri avvenne all'inizio di agosto nella pianura di Farsalia. Pompeo si accampò sulle pendici del monte Dogandzis, mentre Cesare fece lo stesso sulla riva sinistra del fiume Enipeo, a cinque chilometri di distanza dal suo avversario. A prima vista, c'era una grande disparità di forze.Cesare aveva un esercito di circa 22.000 uomini, contro i 45.000 di Pompeo. Ma i soldati del primo erano veterani, in gran parte temprati dalle guerre galliche, mentre molti dei pompeiani avevano avuto il loro battesimo del fuoco poco prima, a Dyrrhachium. Inoltre, Cesare aveva il comando assoluto del proprio esercito, mentre Pompeo doveva tenere conto dell'autorità dei numerosi senatori che lo avevano seguito dall'Italia e con i quali doveva sostenere interminabili discussioni strategiche, nonostante la loro scarsa competenza militare.Cautela e pressioniPompeo era un generale di grande esperienza, e questa gli diceva che la superiorità numerica non era garanzia di vittoria, come sembravano credere i suoi alleati, che già facevano piani di governo, spartendosi le cariche per quando sarebbero tornati al potere.Per questo motivo, rimase accampato per diversi giorni nella sua posizione vantaggiosa, senza accettare le provocazioni di Cesare, che ogni mattina avanzava verso di lui schierando il suo esercito in formazione di battaglia. L'obiettivo di Pompeo era quello di logorare il nemico, costringendolo a vagare in un territorio ostile e privo di fonti di rifornimento.Alla fine, però, il 9 agosto, la pressione dei senatori lo costrinse a ordinare alle sue truppe di scendere nella pianura. Nel suo intimo, Pompeo credeva che fosse un errore: se avesse aspettato ancora, la mancanza di rifornimenti avrebbe reso insostenibile la situazione dei cesariani. Come scrisse Appiano, «era angosciato al pensiero che stavano marciando per combattere contro bestie selvagge».Organizzazione delle fazioniCesare, invece, vide che quella era l'occasione che stava cercando. Per ironia de

Quando, nell'anno 49 a.C., Giulio Cesare attraversò il Rubicone e si lanciò con il suo esercito alla conquista del potere a Roma, sapeva che davanti a lui si sarebbe alzato uno dei personaggi più potenti e popolari della politica romana dei decenni precedenti: Cneo Pompeo Magno.
Tra i due non c'era odio. In un certo senso, avevano molte cose in comune. Si erano divisi il potere durante il periodo del primo triumvirato (60-53 a.C.) e si erano imparentati attraverso Giulia, la figlia di Cesare, che era diventata moglie di Pompeo. La morte di Giulia nel 54 a.C., in seguito a un parto, e la fine del triumvirato dopo la morte di Crasso (il terzo triumviro) in una battaglia contro i Parti l'anno successivo contribuirono ad allontanarli.
Parallelamente, Pompeo si avvicinò a figure come Catone e Cicerone, che difendevano con passione l'ordine tradizionale della Repubblica romana contro le ambizioni palesi del grande vincitore della Gallia. Fu così che nel 49 a.C., unico console in carica, Pompeo si mise alla testa delle legioni del Senato per respingere l'assalto di Cesare.
Ritirata strategica
Di fronte alla totale mancanza di resistenza opposta dalle città italiane all'avanzata di Cesare, Pompeo optò per una ritirata strategica, marciando verso il sud della penisola. Dal porto di Brindisi salpò verso est, dove contava su una vasta clientela e su notevoli risorse. Nella fuga fu accompagnato dalla maggior parte dei senatori che lo avevano sostenuto, timorosi delle ritorsioni di Cesare. Nei mesi successivi, Cesare sconfisse i pompeiani nelle battaglie di Massalia e Ilerda e al suo ritorno a Roma fu nominato console. Poi, sapendo che Pompeo stava radunando un potente esercito in Oriente per attaccare l'Italia, partì, in pieno inverno, verso le coste dell'Epiro, nell'attuale Albania, alla ricerca dello scontro definitivo con il suo rivale.
Dopo sei mesi di scaramucce, Cesare si diresse verso la piazza portuale di Dyrrhachium (Dürres), base principale delle operazioni di Pompeo in Macedonia. Ma lungi dal conquistare la città, l'assalto finale, il 10 luglio, si concluse con centinaia di caduti nel suo campo. Di fronte all'inutilità di prolungare la lotta in quel luogo, Cesare decise di addentrarsi in Tessaglia. Ad Aeginion, l'odierna Kalambaka, incorporò nel suo esercito le legioni comandate dal suo luogotenente Domizio Calvino. Il parziale fallimento a Dyrrhachium aveva fatto sì che molte città della zona non riconoscessero più la sua autorità; per ristabilirla, Cesare saccheggiò Gomfi e ottenne la resa di Metropolis.
Pompeo doveva condividere la strategia militare con i senatori che lo sostenevano, nonostante la totale inesperienza militare di alcuni di loro.
Per quanto riguarda Pompeo, dopo Dirazio avrebbe potuto tornare in Italia e metterla sotto il suo controllo, come gli consigliavano i suoi luogotenenti. Ma preferì rimanere in Macedonia e, con il rinforzo delle legioni comandate da suo suocero Metello Scipione, si lanciò all'inseguimento di Cesare.
Lo scontro decisivo tra i due ex triumviri avvenne all'inizio di agosto nella pianura di Farsalia. Pompeo si accampò sulle pendici del monte Dogandzis, mentre Cesare fece lo stesso sulla riva sinistra del fiume Enipeo, a cinque chilometri di distanza dal suo avversario. A prima vista, c'era una grande disparità di forze.
Cesare aveva un esercito di circa 22.000 uomini, contro i 45.000 di Pompeo. Ma i soldati del primo erano veterani, in gran parte temprati dalle guerre galliche, mentre molti dei pompeiani avevano avuto il loro battesimo del fuoco poco prima, a Dyrrhachium. Inoltre, Cesare aveva il comando assoluto del proprio esercito, mentre Pompeo doveva tenere conto dell'autorità dei numerosi senatori che lo avevano seguito dall'Italia e con i quali doveva sostenere interminabili discussioni strategiche, nonostante la loro scarsa competenza militare.
Cautela e pressioni
Pompeo era un generale di grande esperienza, e questa gli diceva che la superiorità numerica non era garanzia di vittoria, come sembravano credere i suoi alleati, che già facevano piani di governo, spartendosi le cariche per quando sarebbero tornati al potere.
Per questo motivo, rimase accampato per diversi giorni nella sua posizione vantaggiosa, senza accettare le provocazioni di Cesare, che ogni mattina avanzava verso di lui schierando il suo esercito in formazione di battaglia. L'obiettivo di Pompeo era quello di logorare il nemico, costringendolo a vagare in un territorio ostile e privo di fonti di rifornimento.
Alla fine, però, il 9 agosto, la pressione dei senatori lo costrinse a ordinare alle sue truppe di scendere nella pianura. Nel suo intimo, Pompeo credeva che fosse un errore: se avesse aspettato ancora, la mancanza di rifornimenti avrebbe reso insostenibile la situazione dei cesariani. Come scrisse Appiano, «era angosciato al pensiero che stavano marciando per combattere contro bestie selvagge».
Organizzazione delle fazioni
Cesare, invece, vide che quella era l'occasione che stava cercando. Per ironia della sorte, proprio quel giorno aveva deciso di levare il campo per ritirarsi a Larissa, a pochi chilometri di distanza, ma vedendo avanzare le truppe nemiche interruppe i preparativi per la partenza e dispose in formazione di battaglia i suoi soldati, già ansiosi di combattere e vendicare l'umiliazione che i pompeiani avevano inflitto loro a Dirazio.
Pompeo sapeva che nel combattimento corpo a corpo i cesariani erano superiori, quindi puntò tutto sulla cavalleria, concentrata sulla sinistra, tranne un contingente di 600 cavalieri sulla destra. La sua strategia consisteva nel far circondare il nemico sulla destra dalla cavalleria che aveva schierato sulla sinistra, molto superiore di numero, e sorprenderlo attaccandolo alle spalle.
Tuttavia, poiché fu lui a schierarsi per primo, Cesare poté studiare la sua disposizione e prendere le contromisure necessarie. Dopo aver lasciato sette coorti a guardia del suo accampamento, Cesare rispose schierando le sue truppe. Entrambi i blocchi erano organizzati secondo la classica formazione a tre linee, o acies triplex, in cui l'ultima linea fungeva da riserva. Ma Cesare formò una quarta linea prendendo dalla terza una coorte di ogni legione, con il compito di contrastare la manovra della cavalleria di Pompeo. In sostanza, creò una doppia riserva sulla sua ala destra che rendeva la parte posteriore della sua formazione una barriera impenetrabile. Questa disposizione sarebbe stata fondamentale per la vittoria.
Guerra fratricida
Secondo Appiano, prima dell'inizio delle ostilità ci fu un momento di esitazione da entrambe le parti, nel vedere che avevano di fronte compatrioti che erano anche parenti e amici: «Quando tutto fu pronto, attesero ancora a lungo in profondo silenzio, esitanti e indecisi, con lo sguardo fisso l'uno sull'altro, in attesa di chi avrebbe dato inizio al combattimento [...].
In loro affiorava il pensiero che, dopo essere stati a lungo amici e parenti e aver collaborato in molte imprese per ottenere dignità e potere, ora impugnavano le spade gli uni contro gli altri e conducevano coloro che combattevano sotto il loro comando a un atto di empietà simile, nonostante fossero compatrioti, concittadini, della stessa tribù e parenti, e in alcuni casi persino fratelli». Cesare pose fine alle esitazioni e diede l'ordine di attaccare.
Gli uomini di Cesare si lanciarono in corsa, percorrendo i 400 metri che li separavano dalle file nemiche. Pompeo, invece, ordinò ai suoi di attendere lo scontro senza muoversi, confidando che gli avversari si sarebbero stancati.
Questa differenza di strategia fu un altro dei fattori chiave della vittoria di Cesare. Nei suoi Commentari sulla guerra civile, il vincitore della Gallia spiegava che un generale dovrebbe esaltare, non reprimere, l'eccitazione e lo slancio istintivo che i soldati provano prima di entrare in combattimento. Le sue truppe si lanciarono nella battaglia pronte a morire e convinte della vittoria. Un centurione, prima di lanciarsi all'attacco, disse al console: «Oggi, generale, vivo o morto, dovrai ringraziarmi».
I cesariani avevano previsto che i loro nemici avrebbero avanzato anche contro di loro. Vedendoli fermi, si fermarono a metà strada per riprendere fiato e riorganizzarsi. Poi ripresero la corsa e, quando ebbero i pompeiani a portata di mano, lanciarono contro di loro i giavellotti, la cui funzione era quella di rompere le file della formazione nemica, e caricarono con le spade. La mischia fu feroce. Secondo Dion Cassio, «accaddero cose incredibili. Un uomo, dopo aver messo in fuga un altro, fuggiva; un altro che aveva schivato un nemico tornava ad attaccarlo; uno, dopo aver colpito un altro, veniva ferito a sua volta, e un altro che era caduto uccideva il nemico rimasto in piedi».
Pompeo ordinò alla sua cavalleria, comandata da Tito Labieno, di attaccare per rompere l'equilibrio. Non appena vide partire i cavalieri pompeiani, Cesare fece avanzare la seconda riserva, che si presentò davanti ai caschi dei cavalli proprio mentre Labieno stava per lanciarsi contro la terza linea. Il console aveva dato ai suoi uomini un ordine molto preciso: non dovevano lanciare i giavellotti né cercare di tagliare i tendini dei cavalli, ma avanzare «tenendo le lance alzate contro il volto degli uomini, poiché questi, inesperti e giovani, ancora nel fiore della giovinezza, non avrebbero sopportato il pericolo davanti ai loro occhi». In effetti, le lance spaventarono i pompeiani, che si diedero alla fuga. Seguendo quell'impulso, queste coorti di riserva caddero sull'esercito nemico dalle retrovie.
La fuga di Pompeo
A quel punto, Cesare bastò introdurre in battaglia la sua terza linea di coorti per provocare, con forze fresche, la definitiva sconfitta dei pompeiani. Pompeo non fu testimone di ciò: con la sua esperienza, aveva capito, al momento della fuga della cavalleria, che la battaglia era persa, quindi si ritirò scoraggiato al suo accampamento. Nel frattempo, Cesare esortava i suoi a inseguire i nemici, affermando che «se i nemici si fossero riuniti di nuovo sarebbero stati vincitori per un solo giorno, ma se avessero conquistato il loro accampamento avrebbero posto fine alla guerra con questa sola azione».
Verso mezzogiorno, i cesariani raggiunsero l'accampamento di Pompeo, che trovarono addobbato per la vittoria prevista e senza difese. Pompeo non aveva esitato a spogliarsi dell'armatura, a montare a cavallo e a fuggire verso Larissa con una trentina di seguaci, lamentandosi, come scrive Plutarco, di come in un'ora avesse rovinato anni e anni di vittorie e trionfi. A quel punto, Cesare non ebbe altro che circondare con fortificazioni le colline dove si erano rifugiati i pompeiani in fuga e accettare la loro resa; erano circa 24. 000 uomini che si aggiunsero ai 15.000 che, secondo lui, erano caduti (anche se lo storico Asinio Polione, che era uno dei suoi ufficiali, riferisce di 6.000 caduti tra i vinti). Cesare, da parte sua, perse solo 200 soldati.
Tra coloro che accettarono il perdono, che permise a Cesare di mostrare ancora una volta (anche se sarebbe stata l'ultima) la sua proverbiale clemenza, c'erano due importanti pompeiani: Gaio Cassio Longino e, soprattutto, Marco Giunio Bruto, figlio dell'amante di Cesare, Servilia. L'implacabile persecuzione di Pompeo avrebbe portato Cesare, poco dopo, in Egitto, dove avrebbe ricevuto la testa del suo rivale, che aveva commesso l'errore di fidarsi dei consiglieri del faraone Tolomeo XIII, un bambino presso la cui corte aveva cercato asilo. Cesare pianse davanti a quel macabro trofeo, senza sapere che aveva segnato il proprio destino perdonando i due uomini che lo avrebbero pugnalato al Senato meno di tre anni dopo.
Questo articolo appartiene al numero 194 della rivista Storica National Geographic.