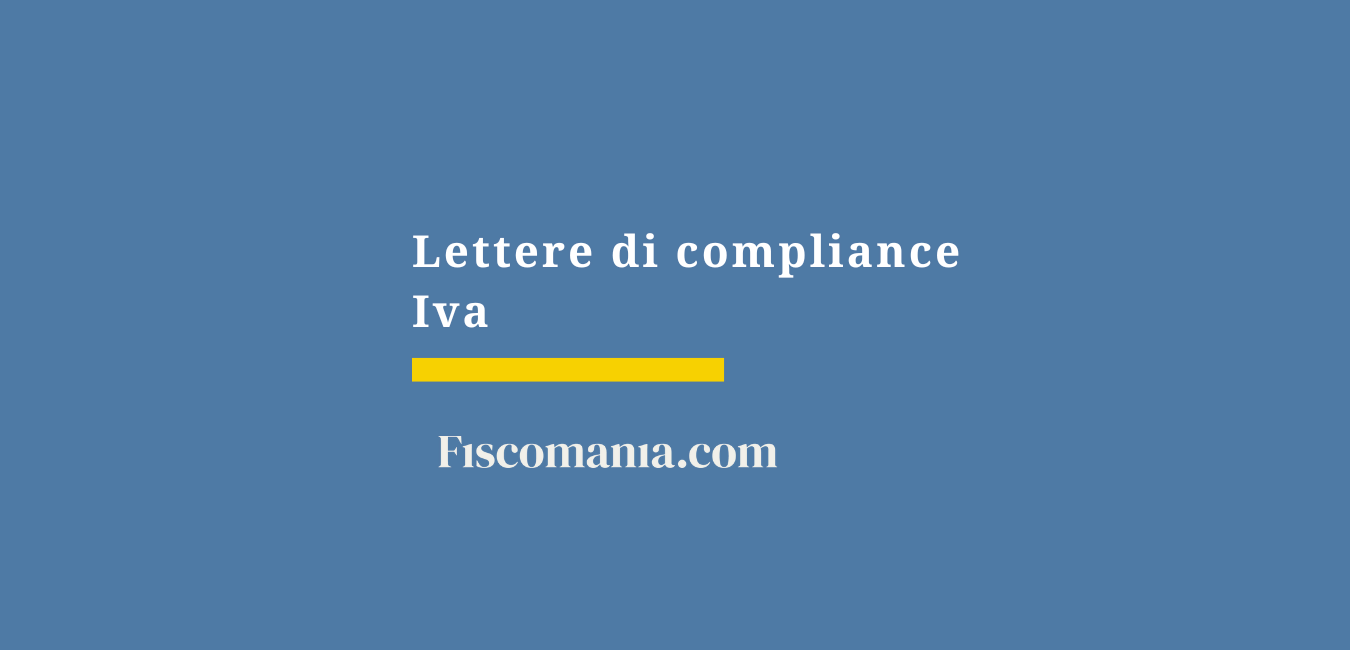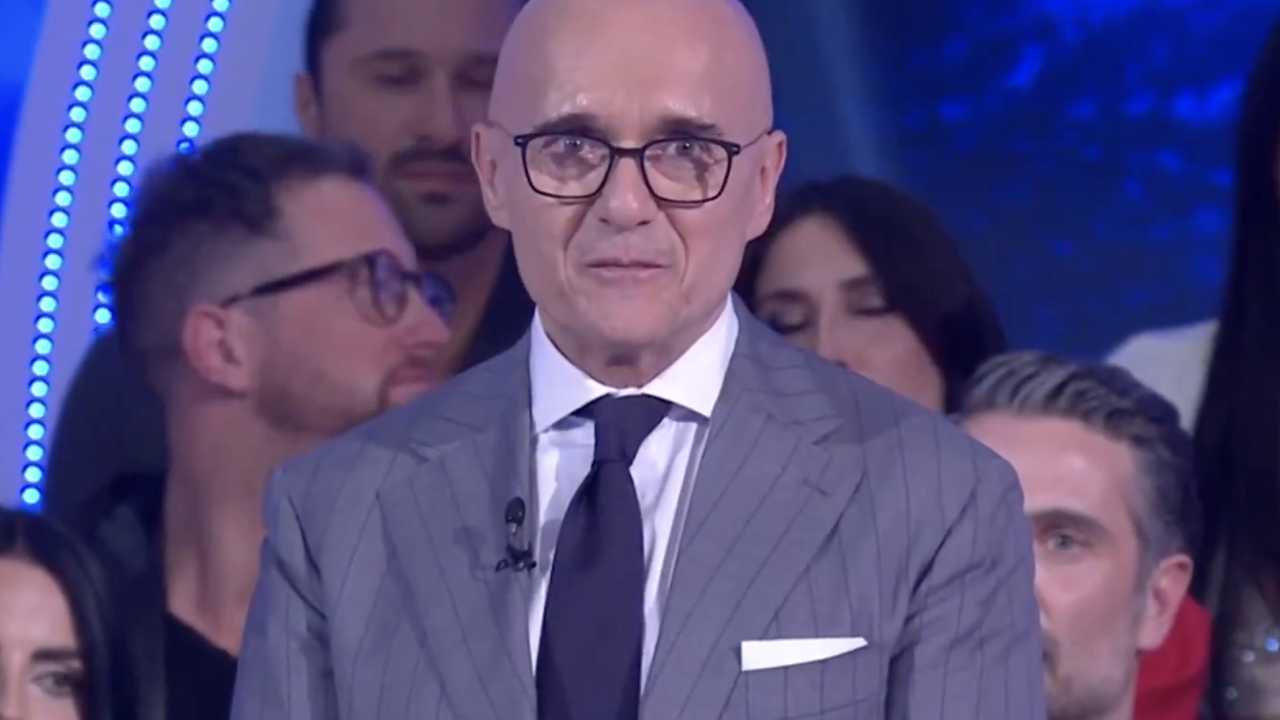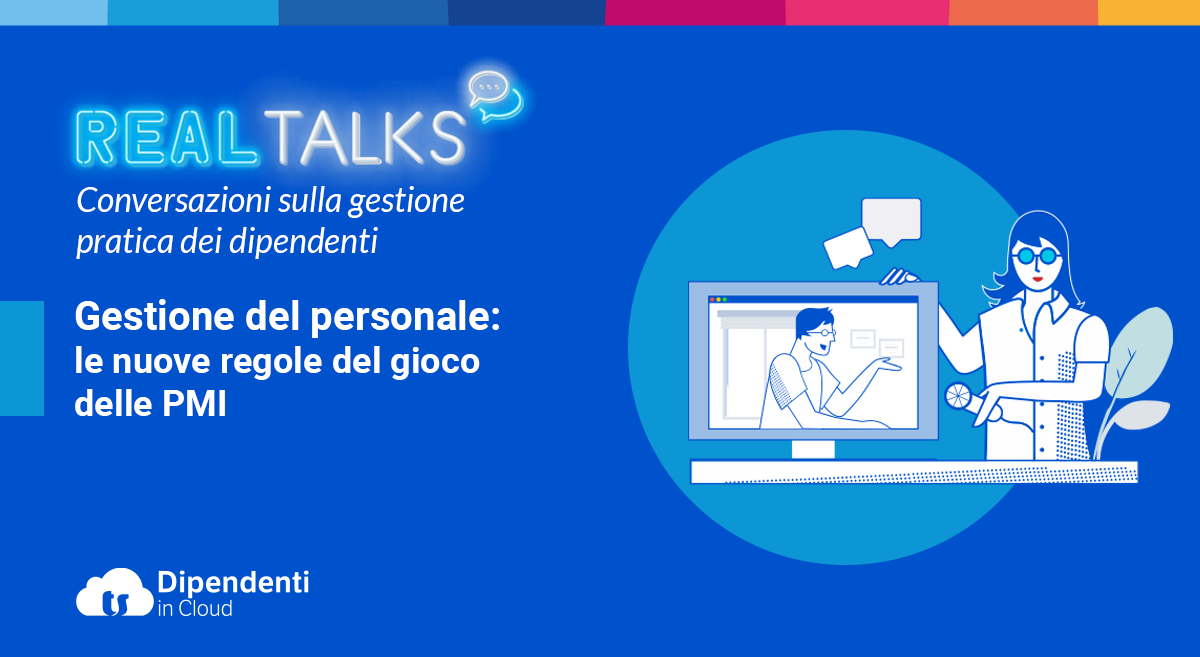Psicologia e denaro: come migliorare il nostro rapporto con i soldi
Il tabù del denaro e l’impatto emotivo nascosto Parlare di denaro resta, per molti, uno degli argomenti più delicati. Nonostante sia onnipresente nella nostra vita quotidiana, raramente lo si affronta apertamente, anche con le persone più vicine. Le conversazioni da parrucchiere, però, spesso rivelano molto. Durante un taglio prima di Natale, il mio parrucchiere ha […] Psicologia e denaro: come migliorare il nostro rapporto con i soldi


Il tabù del denaro e l’impatto emotivo nascosto
Parlare di denaro resta, per molti, uno degli argomenti più delicati. Nonostante sia onnipresente nella nostra vita quotidiana, raramente lo si affronta apertamente, anche con le persone più vicine. Le conversazioni da parrucchiere, però, spesso rivelano molto. Durante un taglio prima di Natale, il mio parrucchiere ha raccontato di clienti divisi da situazioni economiche vissute con forte disagio emotivo: sorelle in conflitto per una spesa da 20 sterline, regali giudicati “scarsi”, o parenti sopraffatti dall’ansia per cifre spese da altri.
Il divario economico è aumentato in modo marcato negli ultimi anni. Tra il 2011 e il 2019, nel Regno Unito, il divario di ricchezza tra famiglie ricche e povere è cresciuto del 50%, secondo la Fairness Foundation. E la situazione negli Stati Uniti è ancora più marcata. Ma solo recentemente la psicologia ha iniziato a comprendere a fondo perché i soldi scatenino emozioni tanto forti.
Il denaro può davvero rendere felici?
È assodato che una base economica solida garantisca la sopravvivenza, ma la relazione tra denaro e felicità è più complessa. Nel 2010, Daniel Kahneman indicava un tetto di 75.000 dollari annui oltre il quale il benessere emotivo non cresceva più. Ma studi successivi, incluso uno del 2023, hanno smentito questa soglia: più guadagni, più benessere, almeno per la maggior parte delle persone.
A livello neurologico, le perdite finanziarie attivano le stesse aree cerebrali associate al dolore sociale. Quando affrontiamo bollette impreviste, il cervello reagisce con stress fisico e mentale, come spiega la psicologa Giulia Sesini dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. L’ansia economica può diventare una sovraccarico cognitivo, compromettendo decisioni vitali.
Quando iniziamo a pensare come adulti… con il portafoglio
Secondo nuove ricerche, già a 15 mesi i neonati iniziano a preferire persone che mostrano segni visibili di ricchezza. Questo suggerisce che la percezione delle risorse e del potere economico è innata o acquisita molto presto, probabilmente per motivi evolutivi legati alla sopravvivenza.
Le abitudini finanziarie dei genitori influenzano profondamente la visione del denaro dei figli. Tuttavia, eventi forti nella vita – come diventare genitori o fallire economicamente – possono trasformare radicalmente queste convinzioni. Anche tra fratelli, le differenze di esperienze e personalità portano a atteggiamenti opposti verso il denaro, pur condividendo lo stesso contesto familiare.
Misurare l’amore per i soldi: lo fanno anche gli psicologi
Per comprendere queste dinamiche, la psicologia utilizza questionari che esplorano i valori personali, l’ansia finanziaria, l’impulsività negli acquisti e il grado di attaccamento emotivo al denaro. Esiste anche una scala che misura il “love of money”, cioè quanto una persona vede nella ricchezza un fine in sé.
Dalle analisi condotte da Sesini su oltre 226 studi, emerge che i giovani tendono ad attribuire maggiore importanza al denaro, legandolo a potere e libertà, ma provano anche più ansia. La personalità gioca un ruolo chiave: i nevrotici e i coscienziosi sono più vulnerabili all’ansia economica, mentre gli introversi tendono a vedere il denaro come qualcosa di negativo.
Al contrario, chi attribuisce al denaro un valore simbolico legato al potere o allo status è più incline a comportamenti poco etici. Alcuni studi hanno persino riscontrato correlazioni con tratti machiavellici: maggiore impulsività, minore empatia, maggiore tendenza alla manipolazione.
Uomini e donne: due visioni differenti del denaro
Nel confronto tra generi, emerge un quadro variegato. Gli uomini, a livello globale, tendono a usare il denaro come strumento di controllo e prestigio, attribuendogli un potere sociale più diretto. Hanno punteggi più alti nei test sul “love of money” e credono più spesso che arricchirsi li renda più desiderabili.
Le donne, invece, vivono il denaro in modo più ambivalente: lo vedono come fonte di sicurezza e amore, ma anche di ansia e preoccupazione. Nonostante i progressi in termini di indipendenza economica, queste differenze persistono anche nelle ricerche più recenti.
Influenza culturale: ricchi diversi, atteggiamenti diversi
La cultura modella profondamente il nostro rapporto con i soldi. Uno studio coordinato da Danila Medvedev dell’Università di Chicago ha evidenziato contrasti sorprendenti tra paesi WEIRD (Occidentali, Istruiti, Industrializzati, Ricchi e Democratici) come USA e Regno Unito, e paesi come India, Cina, Messico e Sudafrica.
In modo inaspettato, le persone di paesi meno ricchi attribuivano minore valore al denaro come incentivo. In una simulazione lavorativa, più del 90% dei messicani proseguiva il compito anche dopo aver guadagnato il compenso minimo, contro meno della metà degli statunitensi. Questo indica una concezione meno contrattualistica e più collettiva del lavoro.
L’amore per il denaro rovina la qualità della vita
Secondo le ricerche della psicologa Gabrielle Pfund dell’Università di Washington, chi dà troppo valore alla ricchezza sperimenta meno benessere emotivo: ridotta accettazione di sé, minor senso del proprio scopo e più emozioni negative. Chi vede il denaro come simbolo di prestigio tende a essere meno empatico e più impulsivo.
Uno studio condotto all’Università del Michigan ha dimostrato che ostentare ricchezza peggiora l’immagine sociale: chi mostrava un logo di lusso sulla propria maglietta veniva giudicato meno cooperativo, anche da chi aveva fatto scelte simili per se stesso. Secondo Deborah Small dell’Università di Yale, il problema non è la ricchezza in sé, ma il volerla ostentare.
Psicologia e denaro: come migliorare il nostro rapporto con i soldi