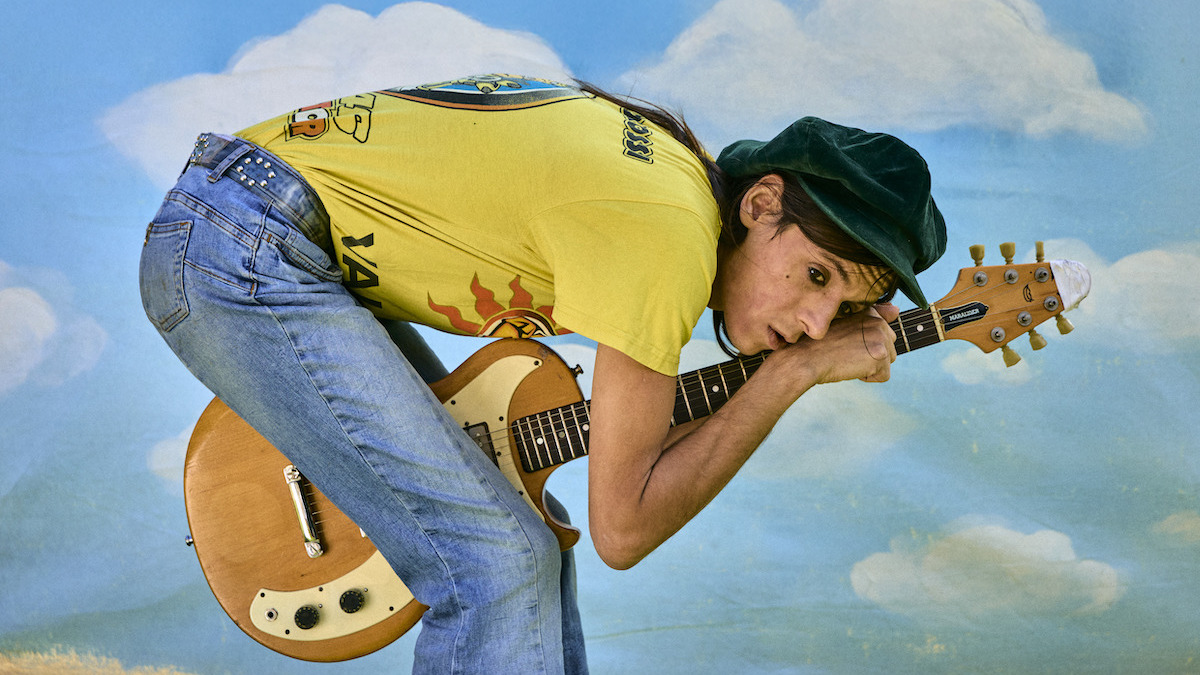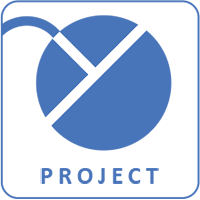Paure, furti e ritardi: l'avventura di viaggiare in treno nel XIX secolo
Nel 1830, la prima linea passeggeri regolare Manchester-Liverpool inaugurò un nuovo modo di viaggiare che simboleggiava l'ideale di progresso nel XIX secolo. In pochi decenni, i paesaggi di molte nazioni si riempirono di binari, gallerie, ponti e stazioni; divenne possibile coprire grandi distanze in treno, da Lisbona a Mosca, per esempio; e l'entusiasmo era tale che quando nel 1848 fu annunciata la prima linea ferroviaria della penisola iberica, che collegava Barcellona e Mataró, la stampa affermò con ottimismo: «Contempliamo solo la possibilità, la prossima realtà, di andare da Barcellona a Madrid in 9 ore e da un capo all'altro della penisola in 18!».Ma in quella velocità con cui, secondo quanto scriveva nel 1842 il giornalista e scrittore Sydney Smith, «l'uomo è diventato un uccello» e «il tempo, la distanza e il ritardo scompaiono», altri vedevano gravi rischi per la salute. Sette anni prima, un presunto rapporto dell'Accademia di Medicina di Lione aveva riassunto i timori dell'epoca, affermando che il passaggio eccessivamente rapido da un clima all'altro, o la polvere e il fumo generati dalla ferrovia, avrebbero avuto un effetto mortale sulle vie respiratorie, mentre la rapida successione di immagini avrebbe causato infiammazioni alla retina. Inoltre, concludeva il rapporto, il movimento frenetico e «il timore dei pericoli manterranno i viaggiatori ferroviari in uno stato di ansia perpetua, che provocherà malattie cerebrali. A una donna incinta, il viaggio può provocare un aborto prematuro».Treni a 40 km all'oraQuesto rapporto accademico non è stato individuato dagli storici e probabilmente si tratta di una bufala, ma ciò non toglie che sia un riflesso dei timori suscitati dalle prime ferrovie, simili a quelli che oggi provocano altri progressi tecnologici. La velocità raggiunta dai treni era modesta se misurata con i parametri attuali, ma rappresentava un enorme cambiamento rispetto ai viaggi in diligenza. Ad esempio, alla fine del XIX secolo, l'espresso da Madrid a San Sebastián, il più veloce della Spagna, raggiungeva una velocità massima di 41 chilometri all'ora e impiegava 15 ore e mezza per percorrere i 614 chilometri di distanza. Per quei primi utenti era veloce, rispetto ai tre giorni e due notti che fino ad allora impiegava la diligenza, a circa 10 chilometri all'ora, e più economico, poiché il biglietto ferroviario costava meno della metà.Nella prima fase della storia della ferrovia, i vagoni erano divisi in scompartimenti separati da pareti divisorie. Vi si accedeva dall'esterno attraverso porte laterali. A differenza del modello ferroviario nordamericano, oggi dominante, in cui ogni vagone aveva un corridoio centrale di accesso, nei treni europei non c'erano corridoi, il che rendeva difficile spostarsi all'interno del vagone. Durante il viaggio, questi spostamenti potevano essere effettuati solo tramite una pedana che correva lungo l'esterno della carrozza, ai piedi delle porte. Da lì passavano il controllore, chiunque volesse visitare altri passeggeri del treno o chi desiderasse recarsi, quando c'era, al vagone-servizio igienico che si trovava sempre alla fine del convoglio. Se non c'era, il viaggiatore doveva sporgersi dalla pedana con il rischio che il passaggio su un ponte o in una galleria causasse un incidente mortale.Inizialmente c'erano biglietti di tre e fino a quattro classi. Come veniva spiegato agli utenti della linea Madrid-Aranjuez nel 1851, i posti più economici «sono scoperti e i viaggiatori devono stare in piedi, potendo portare sulla testa un cesto o un fagotto il cui volume, odore o qualità non disturbino gli altri». In prima classe i sedili erano morbidi e le pareti divisorie tra i compartimenti arrivavano fino al soffitto. I sedili di seconda classe erano simili a quelli di prima classe ma di qualità inferiore, mentre quelli di terza classe consistevano in panche di legno e c'era pochissima separazione tra i compartimenti.La classe influiva anche sulle condizioni di sicurezza. I vagoni di prima classe erano posizionati al centro, affiancati da quelli di seconda, mentre quelli di terza si trovavano alle estremità, quindi erano i più esposti a eventuali collisioni. Essendo di legno, un urto poteva provocare la frammentazione dei vagoni in una moltitudine di schegge che causavano morti e feriti. Inoltre, prendevano fuoco facilmente quando si rovesciava l'olio delle lampade che illuminavano i viaggiatori durante la notte.I maledetti ritardiIl maltempo e la mancanza di manutenzione erano le cause principali della maggior parte degli incidenti ferroviari; se venivano evitati, era spesso grazie alla capacità di improvvisazione del personale di quei primi treni. Nel 1871, ad esempio, la posta dell'Andalusia subì ritardi fino a tre ore perché sul ponte di Vilches i vagoni dovevano essere sganciati dalla locomotiva e spinti uno ad uno fino all'altro lato, poiché non c'era alcuna garanzia che quella struttura potesse sopportarne il peso.Le nevicate potevano fermare un treno in me

Nel 1830, la prima linea passeggeri regolare Manchester-Liverpool inaugurò un nuovo modo di viaggiare che simboleggiava l'ideale di progresso nel XIX secolo. In pochi decenni, i paesaggi di molte nazioni si riempirono di binari, gallerie, ponti e stazioni; divenne possibile coprire grandi distanze in treno, da Lisbona a Mosca, per esempio; e l'entusiasmo era tale che quando nel 1848 fu annunciata la prima linea ferroviaria della penisola iberica, che collegava Barcellona e Mataró, la stampa affermò con ottimismo: «Contempliamo solo la possibilità, la prossima realtà, di andare da Barcellona a Madrid in 9 ore e da un capo all'altro della penisola in 18!».
Ma in quella velocità con cui, secondo quanto scriveva nel 1842 il giornalista e scrittore Sydney Smith, «l'uomo è diventato un uccello» e «il tempo, la distanza e il ritardo scompaiono», altri vedevano gravi rischi per la salute. Sette anni prima, un presunto rapporto dell'Accademia di Medicina di Lione aveva riassunto i timori dell'epoca, affermando che il passaggio eccessivamente rapido da un clima all'altro, o la polvere e il fumo generati dalla ferrovia, avrebbero avuto un effetto mortale sulle vie respiratorie, mentre la rapida successione di immagini avrebbe causato infiammazioni alla retina. Inoltre, concludeva il rapporto, il movimento frenetico e «il timore dei pericoli manterranno i viaggiatori ferroviari in uno stato di ansia perpetua, che provocherà malattie cerebrali. A una donna incinta, il viaggio può provocare un aborto prematuro».
Treni a 40 km all'ora
Questo rapporto accademico non è stato individuato dagli storici e probabilmente si tratta di una bufala, ma ciò non toglie che sia un riflesso dei timori suscitati dalle prime ferrovie, simili a quelli che oggi provocano altri progressi tecnologici. La velocità raggiunta dai treni era modesta se misurata con i parametri attuali, ma rappresentava un enorme cambiamento rispetto ai viaggi in diligenza. Ad esempio, alla fine del XIX secolo, l'espresso da Madrid a San Sebastián, il più veloce della Spagna, raggiungeva una velocità massima di 41 chilometri all'ora e impiegava 15 ore e mezza per percorrere i 614 chilometri di distanza. Per quei primi utenti era veloce, rispetto ai tre giorni e due notti che fino ad allora impiegava la diligenza, a circa 10 chilometri all'ora, e più economico, poiché il biglietto ferroviario costava meno della metà.
Nella prima fase della storia della ferrovia, i vagoni erano divisi in scompartimenti separati da pareti divisorie. Vi si accedeva dall'esterno attraverso porte laterali. A differenza del modello ferroviario nordamericano, oggi dominante, in cui ogni vagone aveva un corridoio centrale di accesso, nei treni europei non c'erano corridoi, il che rendeva difficile spostarsi all'interno del vagone. Durante il viaggio, questi spostamenti potevano essere effettuati solo tramite una pedana che correva lungo l'esterno della carrozza, ai piedi delle porte. Da lì passavano il controllore, chiunque volesse visitare altri passeggeri del treno o chi desiderasse recarsi, quando c'era, al vagone-servizio igienico che si trovava sempre alla fine del convoglio. Se non c'era, il viaggiatore doveva sporgersi dalla pedana con il rischio che il passaggio su un ponte o in una galleria causasse un incidente mortale.
Inizialmente c'erano biglietti di tre e fino a quattro classi. Come veniva spiegato agli utenti della linea Madrid-Aranjuez nel 1851, i posti più economici «sono scoperti e i viaggiatori devono stare in piedi, potendo portare sulla testa un cesto o un fagotto il cui volume, odore o qualità non disturbino gli altri». In prima classe i sedili erano morbidi e le pareti divisorie tra i compartimenti arrivavano fino al soffitto. I sedili di seconda classe erano simili a quelli di prima classe ma di qualità inferiore, mentre quelli di terza classe consistevano in panche di legno e c'era pochissima separazione tra i compartimenti.
La classe influiva anche sulle condizioni di sicurezza. I vagoni di prima classe erano posizionati al centro, affiancati da quelli di seconda, mentre quelli di terza si trovavano alle estremità, quindi erano i più esposti a eventuali collisioni. Essendo di legno, un urto poteva provocare la frammentazione dei vagoni in una moltitudine di schegge che causavano morti e feriti. Inoltre, prendevano fuoco facilmente quando si rovesciava l'olio delle lampade che illuminavano i viaggiatori durante la notte.
I maledetti ritardi
Il maltempo e la mancanza di manutenzione erano le cause principali della maggior parte degli incidenti ferroviari; se venivano evitati, era spesso grazie alla capacità di improvvisazione del personale di quei primi treni. Nel 1871, ad esempio, la posta dell'Andalusia subì ritardi fino a tre ore perché sul ponte di Vilches i vagoni dovevano essere sganciati dalla locomotiva e spinti uno ad uno fino all'altro lato, poiché non c'era alcuna garanzia che quella struttura potesse sopportarne il peso.
Le nevicate potevano fermare un treno in mezzo al nulla e lasciare i passeggeri in balia degli attacchi dei lupi. Nel 1867, in Belgio, i passeggeri dovettero difendersi con bastoni e pale forniti dal fuochista, mentre correvano a chiudersi nell'ultimo vagone, che essendo un vagone merci era più isolato.
C'erano molti altri rischi. Sono noti casi di lancio di pietre contro i treni in transito nei villaggi o nelle campagne, forse causati dal trambusto che il passaggio dei convogli provocava agli abitanti del luogo. Era anche comune l'invasione dei binari da parte di animali, che potevano causare il deragliamento. Come se non bastasse, i viaggiatori potevano essere vittime di uno dei numerosi furti, rapimenti e attentati che avevano come scenario la ferrovia e di cui la stampa diede ampio resoconto per tutto il XIX secolo.
Rapinatori di treni
I rapinatori di treni erano particolarmente temuti. Il loro modus operandi consisteva nel fermare i convogli, o addirittura farli deragliare, per derubare i passeggeri o rubare il carico di valore. Questo tipo di criminalità è spesso associato al Far West degli Stati Uniti, con le sue origini in un attacco compiuto nell'ottobre 1866 dalla banda dei fratelli Reno vicino a Seymour, nell'Indiana. Tuttavia, la prima rapina documentata a un treno ebbe luogo in Italia, nel 1858, sulla linea Roma-Frascati. Da allora si susseguirono attacchi a convogli in Europa e in America.
Infatti, pochi mesi dopo fallì un primo tentativo di rapina a un treno in Spagna. Dovette passare un decennio, fino al novembre 1867, prima che un gruppo di assalitori riuscisse a far deragliare il treno dellalinea Madrid-Irún in un tunnel vicino a Quintanapalla (Burgos) e a impossessarsi di un modesto bottino. Furono catturati poco dopo, al termine di un inseguimento degno dei romanzi a puntate tanto amati all'epoca e che gli occupanti di quei primi treni leggevano con grande piacere per ingannare il tempo durante i viaggi.
Questo articolo appartiene al numero 195 della rivista Stroica National Geographic.