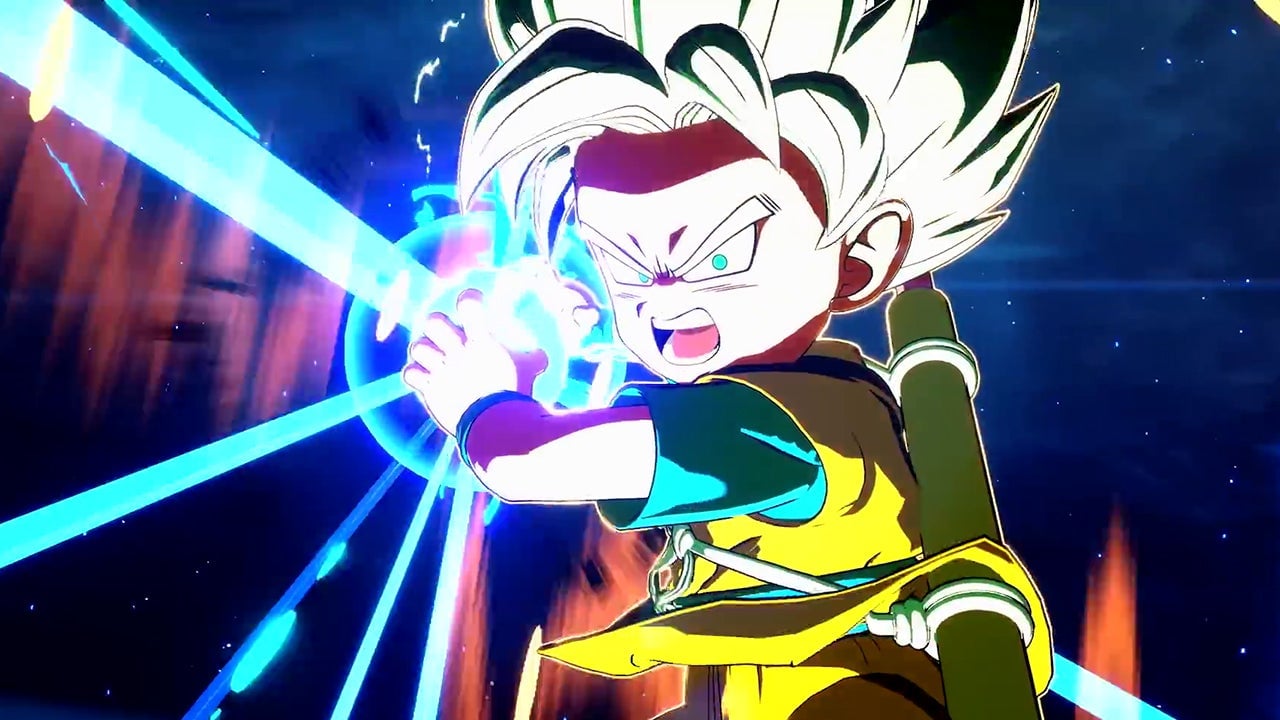Pace giusta o guerra infinita? Il mito occidentale della redenzione armata
Quando l’ideologia si traveste da diplomazia: come l’Occidente predica la pace mentre alimenta la guerra. La liturgia della pace: tra fede morale e strategia dell’impotenza Nel lessico diplomatico occidentale, il […]

Quando l’ideologia si traveste da diplomazia: come l’Occidente predica la pace mentre alimenta la guerra.
La liturgia della pace: tra fede morale e strategia dell’impotenza
Nel lessico diplomatico occidentale, il concetto di “pace giusta” è diventato una formula sacrale, ripetuta con la solennità di un atto liturgico, come se bastasse il suo enunciato a convocare miracolosamente l’ordine e la stabilità in un mondo in disfacimento. Ma come tutte le formule magiche, anche questa è efficace solo per chi ha deciso di credervi. E in Europa, a quanto pare, la fede abbonda. Realismo, invece, molto meno.
Quando i leader europei – accompagnati da un codazzo di consulenti, bandiere, fotografi e nobili intenti – parlano di “pace giusta”, intendono qualcosa di straordinariamente ambizioso: il ritorno dell’Ucraina ai confini del 1991, la completa restaurazione dell’ordine internazionale basato sulle regole (quelle che cambiano a seconda della latitudine), e, naturalmente, il ritiro unilaterale della Russia dai territori occupati. Il tutto senza alcuna concessione, politica o simbolica, a Mosca. Sarebbe bello, se non fosse tragicamente assurdo.
La mistica della “giustizia” in tempo di guerra
La “pace giusta”, nella sua formulazione attuale, non è un’analisi geopolitica, ma una teologia secolarizzata. È una narrazione morale, con buoni assoluti e cattivi ontologici, costruita per rimuovere ogni complessità e soprattutto per sospendere la domanda che più dovrebbe ossessionare ogni diplomatico: che cosa è possibile?
In questa parabola semplificata, l’Ucraina è il martire puro, la Russia il demone invasore, e l’Occidente il paladino armato di buone intenzioni e carri armati Leopard. Ogni compromesso è un tradimento, ogni trattativa un appeasement, ogni spiraglio negoziale un atto di codardia. Si preferisce dunque la guerra alla pace imperfetta, nella speranza che il sacrificio continuo del popolo ucraino possa redimere l’Europa dalle sue colpe storiche e restaurare l’ordine perduto.
Realismo strategico e narrativa mitologica
Peccato che nel frattempo la Russia, per quanto esecrabile si ritenga la sua condotta, sul campo sia militarmente in vantaggio – o quantomeno non stia perdendo. Dopo due anni di conflitto ad alta intensità, centinaia di migliaia di morti, miliardi spesi in armamenti e infrastrutture militari, l’esercito russo controlla stabilmente circa il 20% del territorio ucraino, difende linee fortificate e avanza, seppur lentamente, su vari fronti.
Immaginare che Mosca si ritiri ora, senza condizioni, sarebbe come pensare che Napoleone, dopo Austerlitz, avrebbe potuto restituire l’Europa agli Asburgo per cortesia. Le guerre, disgraziatamente, non finiscono con le invocazioni morali: finiscono quando uno dei contendenti non ha più nulla da guadagnare o da perdere. E oggi, per la Russia, un ritiro incondizionato non sarebbe solo umiliante: sarebbe esistenzialmente suicida. Vorrebbe dire giustificare, di fronte alla propria opinione pubblica e alla nomenklatura, centinaia di migliaia di morti per nulla, miliardi spesi per l’autodistruzione, e – cosa ancora più imperdonabile – ammettere che l’Occidente ha avuto ragione. Putin può essere molte cose, ma non è un dilettante della sopravvivenza.
La pace impossibile e la guerra necessaria
Ecco allora che la “pace giusta”, nella sua forma assoluta, si rivela per ciò che realmente è: un alibi retorico per giustificare la prosecuzione della guerra. Non potendo ottenere l’impossibile, si continua a combattere – o meglio, a far combattere gli altri – nella speranza che, prima o poi, un miracolo tecnologico o geopolitico ribalti i rapporti di forza. Ma non c’è alcun segnale che questo stia avvenendo. Al contrario: l’Ucraina è stremata, demograficamente dissanguata, militarmente logorata, e finanziariamente mantenuta in vita con respirazione artificiale da Washington e Bruxelles.
Continuare a sostenere che solo una pace “giusta” è accettabile significa, nella pratica, accettare che la guerra vada avanti a tempo indeterminato. È una posizione che si autoalimenta, un moto perpetuo della retorica bellica, dove ogni fallimento sul campo è l’occasione per invocare più aiuti, più armi, più sacrifici. Fino a quando? Fino all’ultimo ucraino? Fino al crollo politico della Russia? O fino a che i contribuenti europei non si renderanno conto che la loro bolletta energetica gonfia e il loro stipendio sempre più insufficiente hanno una qualche relazione con le visioni di grandeur strategica dei loro leader?
Il rifiuto del tragico
Ciò che colpisce, forse più di tutto, è il rifiuto ostinato del tragico. I leader occidentali, in particolare quelli europei, sembrano incapaci di accettare che nella storia vi siano momenti in cui la giustizia e la vittoria non coincidono, e in cui la sopravvivenza impone compromessi moralmente scomodi. La loro è una visione etica della politica che, proprio perché disancorata dal reale, finisce per produrre effetti cinicamente opposti alle intenzioni dichiarate. Sostenere una pace irrealizzabile equivale a condannare un intero popolo a una guerra senza fine.
Non si tratta di cedere a Mosca. Si tratta di riconoscere che la pace – qualsiasi pace – è per definizione un compromesso, non un premio per i buoni. L’alternativa, al netto della retorica, è una sola: accettare la guerra come stato permanente, come cornice normale del mondo post-2022, e assuefarsi alla logica dell’attrito infinito.
Conclusione: la retorica come strategia del fallimento
In ultima analisi, il concetto di “pace giusta” si rivela essere una trappola semantica: più lo si invoca, più si allontana. Come ogni mito moderno, serve più a placare le ansie morali del pubblico occidentale che a disegnare un futuro praticabile. La realtà, purtroppo, non si piega al comfort narrativo: le guerre non si vincono con i talk show, né le trattative si aprono con editoriali indignati. La vera giustizia, ammesso che possa ancora avere un posto in questa tragedia, sarà quella che salverà vite umane – non quella che avrà avuto ragione nei salotti.
Ma forse, dopotutto, il compito della politica europea non è più quello di vincere o negoziare. È quello di raccontare, con eleganza e indignazione, la propria irrilevanza.