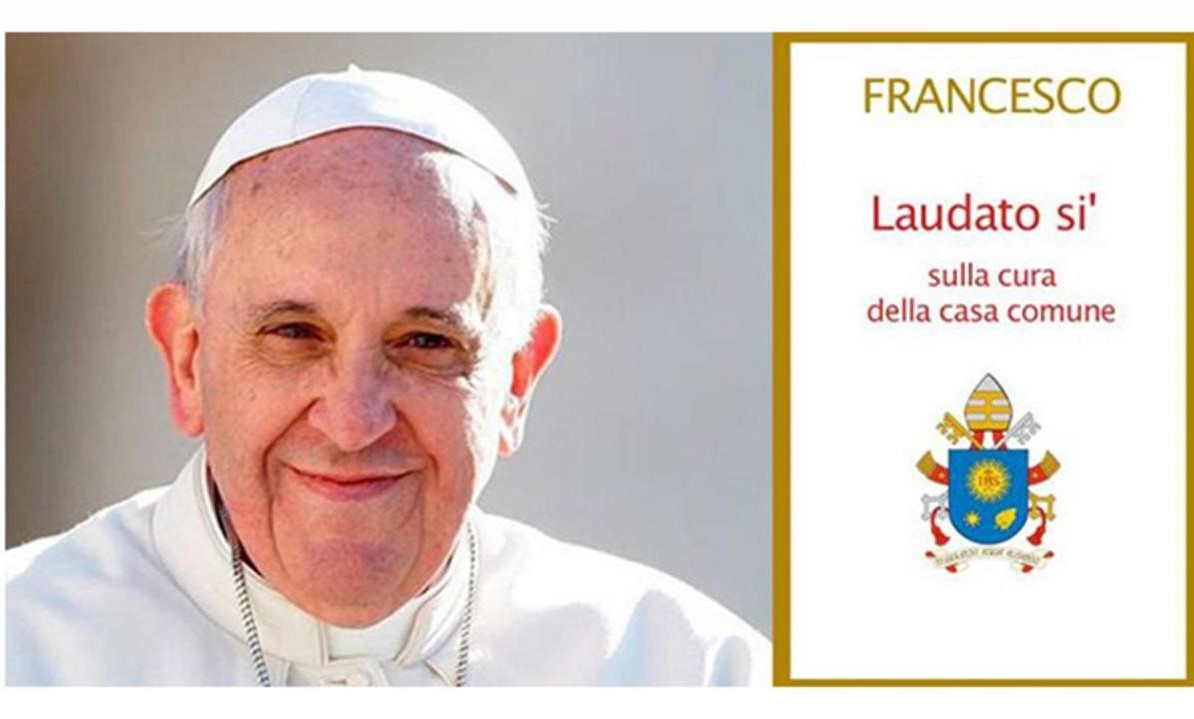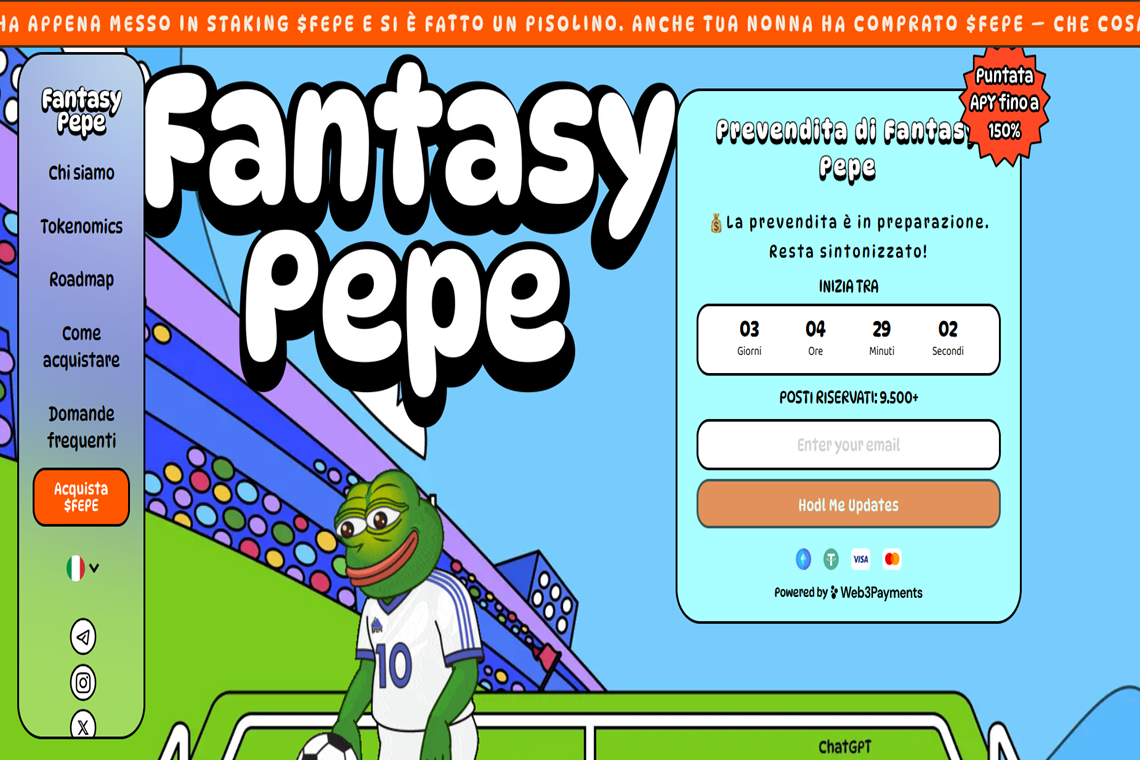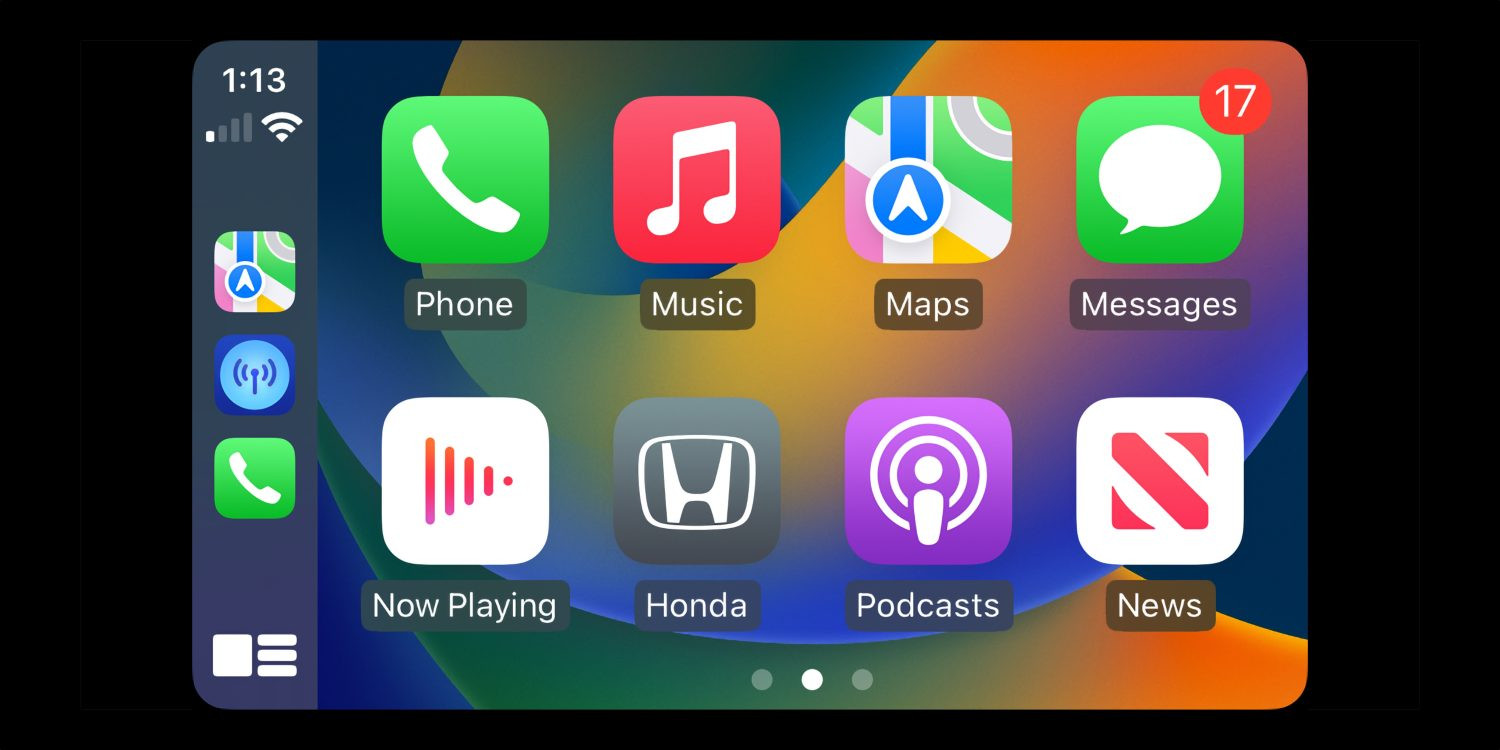Ucraina: il crepuscolo di una guerra infinita secondo John J. Mearsheimer
Un vicolo cieco chiamato pace Immaginate una scacchiera dove ogni mossa è un ultimatum, ogni pedone un sacrificio, e la partita non prevede pareggi. Questa è la guerra in Ucraina, […]

Un vicolo cieco chiamato pace
Immaginate una scacchiera dove ogni mossa è un ultimatum, ogni pedone un sacrificio, e la partita non prevede pareggi. Questa è la guerra in Ucraina, un conflitto che, a tre anni dall’invasione russa del febbraio 2022, sembra intrappolato in un eterno presente di morte e distruzione. John Mearsheimer, uno dei più lucidi analisti geopolitici, lo aveva previsto: nessuna pace significativa è possibile quando entrambe le parti – Russia da un lato, Ucraina e Occidente dall’altro – si percepiscono come minacciate nella loro stessa esistenza. E oggi, nell’aprile 2025, questa profezia si staglia come un monito: il conflitto non solo persiste, ma si è incancrenito, con prospettive sempre più cupe.
Perché non si arriva a un accordo? La risposta è semplice, ma brutale: gli obiettivi sono inconciliabili. La Russia vuole un’Ucraina neutrale, smilitarizzata, ridotta a un’ombra di Stato, incapace di rappresentare una minaccia al confine. L’Ucraina, sostenuta dall’Occidente, sogna invece la piena sovranità, l’ingresso nella NATO e la riconquista di ogni metro di territorio perduto, dalla Crimea al Donbass. Sono visioni opposte, che non lasciano spazio a compromessi. Mearsheimer lo aveva detto chiaramente: quando si combatte per la sopravvivenza, non si negozia, si distrugge. E i fatti gli danno ragione. I negoziati di Istanbul del 2022, che avrebbero potuto fermare la guerra, sono naufragati sotto le pressioni occidentali e l’intransigenza russa. Da allora, ogni tentativo di dialogo è stato un esercizio di facciata.
La Russia e la sua ossessione securitaria
Per capire dove va questa guerra, bisogna partire da Mosca. I leader russi, da Putin in giù, vedono nell’espansione della NATO verso est una minaccia esistenziale. Non è paranoia, ma storia: dal 2008, quando la NATO promise a Ucraina e Georgia un futuro nell’Alleanza, la Russia ha vissuto con il terrore di vedere basi militari occidentali a pochi chilometri da Mosca. Nel 2022, l’Occidente ha alzato la posta, armando l’Ucraina con miliardi di dollari in aiuti militari e parlando apertamente di “indebolire” la Russia. Per Putin, la guerra non è solo una questione di territorio, ma di sopravvivenza del suo regime e della Russia come potenza.
Gli obiettivi di Mosca, come li descriveva Mearsheimer, erano chiari: annettere Crimea e parti del Donbass, ridurre l’Ucraina a uno Stato disfunzionale e sostituire il governo di Kiev con uno filorusso. Nel 2025, questi obiettivi sono stati raggiunti solo in parte. La Crimea e quattro oblast’ (Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia) sono sotto controllo russo, ma l’Ucraina non è crollata. Il governo Zelensky, nonostante le difficoltà, resiste, sostenuto da un flusso continuo di armi e denaro occidentali. La “denazificazione” e “smilitarizzazione” di cui parlava Putin sono rimaste slogan: l’Ucraina combatte ancora, e la NATO è più presente che mai nella regione. Mearsheimer aveva ragione nel prevedere che una vittoria totale russa sarebbe stata improbabile: l’esercito di Mosca, pur avanzando lentamente, non ha le risorse per occupare l’intero Paese senza un costo insostenibile.
L’Ucraina: un Paese in bilico tra eroismo e rovina
Dall’altra parte, l’Ucraina vive un paradosso. È un Paese che resiste con un coraggio che ha stupito il mondo, ma che paga un prezzo devastante. Mearsheimer sottolineava che Kiev vede la Russia come una minaccia esistenziale, e questo non è cambiato. Ogni città distrutta, ogni civile ucciso, rafforza la determinazione ucraina a non cedere. Ma il costo è spaventoso: l’economia è in ginocchio, milioni di persone sono fuggite, e le città orientali sono cumuli di macerie. Nel 2025, l’Ucraina dipende quasi interamente dagli aiuti occidentali, che però iniziano a scricchiolare sotto il peso delle crisi economiche in Europa e delle elezioni negli Stati Uniti, dove il sostegno a Kiev non è più unanime.
Mearsheimer aveva previsto che l’Ucraina sarebbe diventata un “moncone di Stato disfunzionale”. Questa previsione si è avverata in parte: le regioni orientali sono perdute, e la ricostruzione richiederà decenni. Tuttavia, l’Ucraina non è collassata come Mosca sperava. La controffensiva del 2022 a Kharkiv e Kherson aveva dato speranze, ma quella del 2023, come Mearsheimer aveva anticipato, si è arenata contro le fortificazioni russe. Oggi, la guerra di logoramento continua a dissanguare entrambi gli eserciti, con l’artiglieria russa che mantiene un vantaggio decisivo. L’Ucraina combatte, ma ogni giorno che passa la avvicina a un punto di rottura.
L’Occidente: il grande burattinaio inceppato
E poi c’è l’Occidente, il terzo attore di questa tragedia. Per Stati Uniti ed Europa, la guerra in Ucraina è stata un’opportunità per riaffermare la leadership globale e contenere la Russia. Ma, come notava Mearsheimer, l’Occidente ha sottovalutato la determinazione di Mosca e sopravvalutato la propria capacità di sostenere Kiev indefinitamente. Nel 2025, le crepe sono evidenti. L’Europa, alle prese con recessione e crisi energetica, fatica a mantenere il ritmo degli aiuti. Negli Stati Uniti, le elezioni del 2024 hanno portato un Congresso più scettico sul continuare a finanziare una guerra lontana. La promessa di integrare l’Ucraina nella NATO rimane, ma è un miraggio: nessuno vuole rischiare un conflitto diretto con la Russia.
Mearsheimer aveva avvertito che l’Occidente avrebbe fatto di tutto per impedire una vittoria russa totale, e così è stato. Le sanzioni, gli aiuti militari, l’intelligence: tutto è stato messo in campo. Ma non è bastato a ribaltare le sorti del conflitto. La Russia, pur colpita economicamente, ha trovato nella Cina e in altri partner globali un’ancora di salvezza. L’Occidente, invece, si trova a un bivio: continuare a sostenere un’Ucraina sempre più fragile o accettare un negoziato che sancirebbe una parziale vittoria russa. Entrambe le opzioni sono amare.
Sul campo: una guerra che divora tutto
Sul terreno, la guerra è diventata ciò che Mearsheimer chiamava una “guerra di logoramento”. Dopo i successi ucraini del 2022, la Russia ha imparato dai suoi errori: ha mobilitato più uomini, rafforzato le linee difensive e puntato tutto sull’artiglieria, l’arma che decide le battaglie. La caduta di Bakhmut nel 2023 è stata un turning point: i russi hanno inflitto perdite enormi agli ucraini, dimostrando che il tempo gioca a loro favore. Nel 2025, il fronte è statico, con piccole avanzate russe nel Donbass e un’Ucraina che si difende disperatamente. La controffensiva ucraina del 2023, tanto attesa, è fallita, come Mearsheimer aveva previsto, contro le fortificazioni russe.
Oggi, entrambe le parti sono esauste, ma la Russia ha un vantaggio: una popolazione più grande, un’economia più resiliente e un’industria militare che produce senza sosta. L’Ucraina, invece, dipende da forniture occidentali che arrivano a singhiozzo. Ogni giorno di guerra erode ulteriormente le sue risorse umane e materiali. Mearsheimer aveva ragione: in una guerra di logoramento, il più forte alla lunga prevale.
Il futuro: un’Ucraina spezzata e un mondo diviso
Guardando al futuro, il quadro è desolante. Mearsheimer prevedeva che la Russia avrebbe ottenuto una “brutta vittoria”, annettendo territori e riducendo l’Ucraina a uno Stato fragile. Nel 2025, questo scenario si sta materializzando. Mosca controlla circa il 20% del territorio ucraino, e le regioni occupate sono ormai integrate de facto nella Federazione Russa. L’Ucraina sopravvive, ma è un Paese mutilato, con un’economia al collasso e una popolazione decimata. La promessa occidentale di ricostruzione è lontana, e la NATO, pur vicina, resta un sogno.
Le riflessioni di Mearsheimer si sono rivelate in gran parte corrette. Aveva previsto l’impossibilità di un accordo di pace, la trasformazione della guerra in un conflitto di logoramento e la difficoltà della Russia di ottenere una vittoria totale. Aveva anche anticipato che l’Occidente non sarebbe riuscito a piegare Mosca senza pagarne un costo enorme. Tuttavia, ha sottovalutato la resilienza ucraina e la capacità di Kiev di mantenere il fronte, pur con enormi sacrifici. Inoltre, non aveva previsto il ruolo crescente della Cina come alleato economico della Russia, che ha attenuato l’impatto delle sanzioni.
Una lezione per l’Occidente
Questa guerra, come scriveva Mearsheimer, è anche uno specchio per l’Occidente. La NATO ha voluto spingere i suoi confini fino al cuore della Russia, ignorando le linee rosse di Mosca. Ha armato l’Ucraina, ma non abbastanza per vincere; ha promesso protezione, ma non abbastanza per garantire la sicurezza. Il risultato è un’Ucraina devastata e un mondo più diviso che mai. Nel 2025, la guerra in Ucraina non è solo un conflitto regionale: è il simbolo di un ordine globale che si sgretola, dove le potenze si sfidano senza curarsi delle macerie che lasciano dietro.
“Abbiamo voluto giocare a scacchi con la storia, ma la storia non gioca. Vince sempre lei”. E la storia, oggi, ci sta mostrando un’Ucraina in ginocchio, una Russia ferita ma non doma, e un Occidente che deve fare i conti con i propri limiti. La pace? Forse un giorno, ma non oggi. Non in questo crepuscolo.