Liberty: l’arte che reinventò la bellezza
Nel 1902 i visitatori dell’Esposizione internazionale d'arte decorativa moderna di Torino rimasero estasiati dalla vista di oggetti dalle linee curve, floreali e sinuose. Si trattava di opere realizzate in materiali innovativi per l’epoca – ferro battuto, vetro colorato, ceramica smaltata – secondo lo stile Art Nouveau.Questa corrente artistica aveva un obiettivo ambizioso: reinventare la bellezza, abbattendo il confine tra arti “maggiori” come architettura, pittura e scultura, e arti “minori” o applicate, com’erano chiamate da qualche tempo. Il nuovo linguaggio, infatti, coinvolgeva ogni forma d’espressione, valorizzando soprattutto arti come l’illustrazione, l’oreficeria, la lavorazione dei tessuti e il design.La mostra torinese servì a consacrare anche in Italia un nuovo gusto artistico che si stava affermando in tutta l’Europa.Un’arte totale ispirata alla naturaNato intorno al 1890, il movimento Art Nouveau era caratterizzato da linee fluide, ondulate, ispirate alla natura: fiori che si intrecciano, steli che si piegano, sensuali corpi femminili fusi con lo spazio architettonico. La novità più profonda però non era solo visiva: ogni elemento era concepito come parte integrante di un’opera d’arte più ampia e organica.Un palazzo, una sedia o un lampadario non erano più semplicemente un palazzo, una sedia o un lampadario ma diventavano parti di un’opera d’arte più grande, in cui ogni elemento era incluso nella concezione progettuale.Un esempio emblematico è la casa progettata tra il 1892 e il 1893 dall’architetto belga Victor Horta per l’amico Emile Tassel. In questo edificio ogni dettaglio – dai vetri alle maniglie delle porte, dagli arredi alla scala interna – rispondeva a una visione stilistica coerente e unitaria.Il termine Art Nouveau divenne popolare a partire dal 1895 quando il mercante d’arte Siegfried Bing aprì a Parigi la Maison de l’Art Nouveau, una galleria specializzata in opere d’arte moderne. Tuttavia, il termine era già comparso alcuni anni prima sulle pagine della rivista L’Art Moderne. Questo nuovo linguaggio traeva le sue radici dalle correnti simboliste del secondo Ottocento e anche dal movimento Arts and Craft del britannico William Morris con cui condivideva la critica della produzione industriale di massa e la valorizzazione dell’artigianato.Curiosamente, questo nuovo gusto assunse un nome diverso in base ai luoghi in cui si diffuse. Jugendstil era chiamato in Germania, Secessione Viennese in Austria, Niewe Kunst nei Paesi Bassi, solo per fare alcuni esempi. In Italia qualcuno cominciò a chiamarlo “stile floreale”, ma, ben presto si radicò soprattutto il nome di Stile Liberty, in omaggio al gusto “alla Liberty” che aveva influenzato l’esposizione di Torino.Arthur Liberty: il mercante del belloArthur Lasenby Liberty, imprenditore londinese nato nel 1843, fu tra i protagonisti della diffusione di questo nuovo gusto.Agli inizi degli anni sessanta iniziò una collaborazione con un’impresa di moda femminile chiamata Farmer & Rogers ma a un certo punto di fronte al rifiuto dei titolari di farlo diventare un loro socio, aveva scelto di mettersi in proprio. Liberty chiese in prestito un gruzzolo di circa duemila sterline al futuro suocero e alla fine del 1875 aprì un piccolo negozio al numero 218 di Regent Street in cui commerciava tappeti, tessuti e manufatti orientali.Partito in sordina, con una manciata di dipendenti, nel giro di poco riuscì a renderlo il centro di vendita di oggetti pregiati importati dall’Asia e dal Medio Oriente. Arthur non solo saldò rapidamente il debito, ma nel corso del tempo ampliò il negozio acquistando man mano nuovi locali.Liberty era un uomo molto lungimirante: aveva intuito che il pubblico amava circondarsi di oggetti non solo funzionali ma anche belli e iniziò a collaborare con progettisti che promuovono uno stile nuovo, più decorativo, raffinato e moderno. Quando poi nel 1884 decise di incrementare un reparto di moda femminile affidandone la direzione all’architetto e progettista Edward Godwin e l’anno successivo ricreò un autentico villaggio indiano con tanto di abitanti fatti venire direttamente dall’Oriente, i suoi magazzini si trasformarono in un’esperienza estetica a tutto tondo. Divennero una meta obbligata per collezionisti, artisti e intellettuali che facevano a gara per acquistare l’ultima novità esposta in vetrina.Tra i clienti più noti vi erano molti preraffaelliti, come Dante Gabriel Rossetti, e anche lo scrittore Oscar Wilde che in un articolo pubblicato nel 1889 sulla rivista The Romans World, affermò che i magazzini di Liberty rappresentavano «il rifugio scelto degli acquirenti d’arte».L’estetica Liberty tra artigianato ed esotismoL’attività di Arthur Liberty divenne una vetrina delle avanguardie artistiche europee e promuoveva una visione estetica che univa esotismo, artigianato e modernità. In particolare, le caratteristiche distintive dell’Art Nouveau - le linee curve, i motivi decorativi (come fiori di loto, pavoni, arabeschi e calligrafie
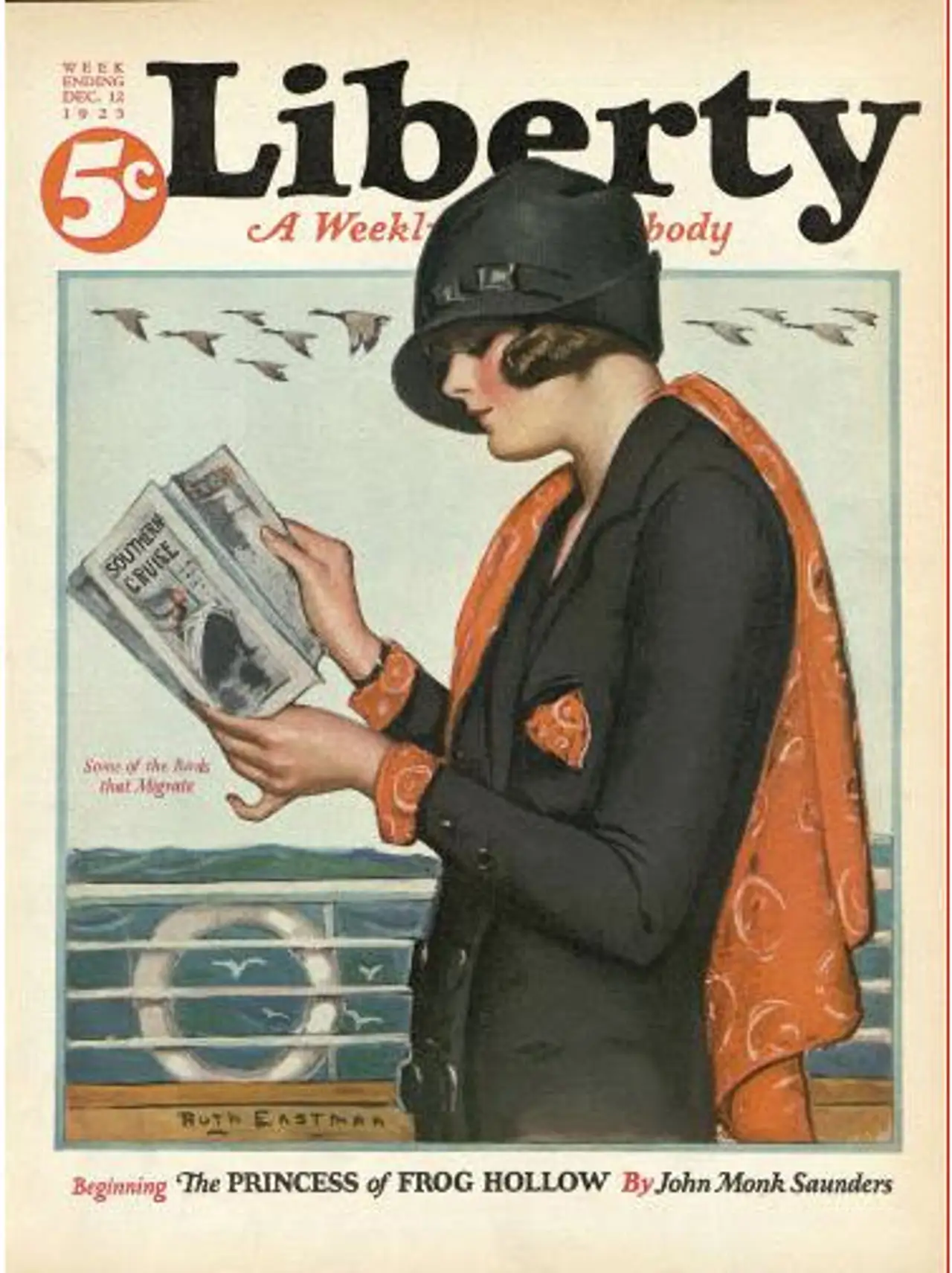
Nel 1902 i visitatori dell’Esposizione internazionale d'arte decorativa moderna di Torino rimasero estasiati dalla vista di oggetti dalle linee curve, floreali e sinuose. Si trattava di opere realizzate in materiali innovativi per l’epoca – ferro battuto, vetro colorato, ceramica smaltata – secondo lo stile Art Nouveau.
Questa corrente artistica aveva un obiettivo ambizioso: reinventare la bellezza, abbattendo il confine tra arti “maggiori” come architettura, pittura e scultura, e arti “minori” o applicate, com’erano chiamate da qualche tempo. Il nuovo linguaggio, infatti, coinvolgeva ogni forma d’espressione, valorizzando soprattutto arti come l’illustrazione, l’oreficeria, la lavorazione dei tessuti e il design.
La mostra torinese servì a consacrare anche in Italia un nuovo gusto artistico che si stava affermando in tutta l’Europa.
Un’arte totale ispirata alla natura
Nato intorno al 1890, il movimento Art Nouveau era caratterizzato da linee fluide, ondulate, ispirate alla natura: fiori che si intrecciano, steli che si piegano, sensuali corpi femminili fusi con lo spazio architettonico. La novità più profonda però non era solo visiva: ogni elemento era concepito come parte integrante di un’opera d’arte più ampia e organica.
Un palazzo, una sedia o un lampadario non erano più semplicemente un palazzo, una sedia o un lampadario ma diventavano parti di un’opera d’arte più grande, in cui ogni elemento era incluso nella concezione progettuale.
Un esempio emblematico è la casa progettata tra il 1892 e il 1893 dall’architetto belga Victor Horta per l’amico Emile Tassel. In questo edificio ogni dettaglio – dai vetri alle maniglie delle porte, dagli arredi alla scala interna – rispondeva a una visione stilistica coerente e unitaria.
Il termine Art Nouveau divenne popolare a partire dal 1895 quando il mercante d’arte Siegfried Bing aprì a Parigi la Maison de l’Art Nouveau, una galleria specializzata in opere d’arte moderne. Tuttavia, il termine era già comparso alcuni anni prima sulle pagine della rivista L’Art Moderne. Questo nuovo linguaggio traeva le sue radici dalle correnti simboliste del secondo Ottocento e anche dal movimento Arts and Craft del britannico William Morris con cui condivideva la critica della produzione industriale di massa e la valorizzazione dell’artigianato.
Curiosamente, questo nuovo gusto assunse un nome diverso in base ai luoghi in cui si diffuse. Jugendstil era chiamato in Germania, Secessione Viennese in Austria, Niewe Kunst nei Paesi Bassi, solo per fare alcuni esempi. In Italia qualcuno cominciò a chiamarlo “stile floreale”, ma, ben presto si radicò soprattutto il nome di Stile Liberty, in omaggio al gusto “alla Liberty” che aveva influenzato l’esposizione di Torino.
Arthur Liberty: il mercante del bello
Arthur Lasenby Liberty, imprenditore londinese nato nel 1843, fu tra i protagonisti della diffusione di questo nuovo gusto.
Agli inizi degli anni sessanta iniziò una collaborazione con un’impresa di moda femminile chiamata Farmer & Rogers ma a un certo punto di fronte al rifiuto dei titolari di farlo diventare un loro socio, aveva scelto di mettersi in proprio. Liberty chiese in prestito un gruzzolo di circa duemila sterline al futuro suocero e alla fine del 1875 aprì un piccolo negozio al numero 218 di Regent Street in cui commerciava tappeti, tessuti e manufatti orientali.
Partito in sordina, con una manciata di dipendenti, nel giro di poco riuscì a renderlo il centro di vendita di oggetti pregiati importati dall’Asia e dal Medio Oriente. Arthur non solo saldò rapidamente il debito, ma nel corso del tempo ampliò il negozio acquistando man mano nuovi locali.
Liberty era un uomo molto lungimirante: aveva intuito che il pubblico amava circondarsi di oggetti non solo funzionali ma anche belli e iniziò a collaborare con progettisti che promuovono uno stile nuovo, più decorativo, raffinato e moderno. Quando poi nel 1884 decise di incrementare un reparto di moda femminile affidandone la direzione all’architetto e progettista Edward Godwin e l’anno successivo ricreò un autentico villaggio indiano con tanto di abitanti fatti venire direttamente dall’Oriente, i suoi magazzini si trasformarono in un’esperienza estetica a tutto tondo. Divennero una meta obbligata per collezionisti, artisti e intellettuali che facevano a gara per acquistare l’ultima novità esposta in vetrina.
Tra i clienti più noti vi erano molti preraffaelliti, come Dante Gabriel Rossetti, e anche lo scrittore Oscar Wilde che in un articolo pubblicato nel 1889 sulla rivista The Romans World, affermò che i magazzini di Liberty rappresentavano «il rifugio scelto degli acquirenti d’arte».
L’estetica Liberty tra artigianato ed esotismo
L’attività di Arthur Liberty divenne una vetrina delle avanguardie artistiche europee e promuoveva una visione estetica che univa esotismo, artigianato e modernità. In particolare, le caratteristiche distintive dell’Art Nouveau - le linee curve, i motivi decorativi (come fiori di loto, pavoni, arabeschi e calligrafie orientali), l’asimmetria dinamica e l’integrazione delle arti decorative - si riflettevano nei tessuti, mobili e oggetti venduti nei magazzini londinesi.
Le collaborazioni di Liberty con vari artisti europei come il belga Henri Van de Velde, il britannico Charles Rennie Mackintosh e il francese Émile Gallé consolidano ulteriormente il ruolo dei suoi magazzini come punto d’incontro un punto d’incontro privilegiato tra le varie declinazioni dell’Art Nouveau. Gli artisti Liberty, inoltre, collaboravano strettamente con ebanisti, ceramisti, fabbri, vetrai e ricamatori per realizzare oggetti unici, caratterizzati da un’estrema cura nei dettagli. Le linee curve, i motivi floreali e l’armonia delle forme non erano solo tratti stilistici ma veri e propri manifesti di una cultura che voleva celebrare la dignità e bellezza dell’”arte del quotidiano”.
Il Liberty italiano: tra eleganza e misura
All’inizio del Novecento, quindi, il nuovo gusto si diffonde anche in Italia. Pur condividendo con le altre versioni continentali l’amore per le linee sinuose, i motivi floreali e l’integrazione tra arte e artigianato, in Italia lo stile Liberty si adattò anche al gusto locale, alla tradizione classica e alle peculiarità locali. Il risultato fu un Liberty più sobrio e misurato rispetto a quello francese o belga, ma non meno significativo.
Uno dei maggiori esponenti fu il palermitano Ernesto Basile, architetto e docente universitario, il quale riuscì a unire in nuovo gusto con le peculiarità artistiche mediterranee. Tra le sue opere più emblematiche spiccano i progetti per la famiglia Florio, importanti imprenditori e mecenati dell’epoca.
Altri illustri esponenti furono il milanese Giuseppe Sommaruga, autore tra il 1901 e il 1904 del famoso Palazzo Castiglioni e il torinese Pietro Fenoglio, progettista della bella Villa Scott (1902), celebre anche per essere stata utilizzata per alcune riprese del film Profondo Rosso.
Tra i pittori e decoratori Liberty si ricordano invece il fiorentino Galileo Chini (1873–1956), Ernesto Bellandi (1842–1916), Vittorio Zecchin (1878–1947), l’ebanista e decoratore d’interni Eugenio Quarti (1867–1931) ei il maestro del ferro battuto Alessandro Mazzucotelli (1865–1938).
Il crepuscolo del Liberty
L’Art Nouveau ebbe una durata piuttosto breve e in genere si colloca la sua fine attorno al 1910.
Già prima della Prima Guerra Mondiale, infatti, si percepivano i segni del declino: i costi di produzione erano molto elevati e, inoltre, in un’epoca di crescente industrializzazione, aumentava la richiesta di funzionalità, riproducibilità e standardizzazione. Inoltre, il gusto del pubblico mutava rapidamente: le forme floreali e ornamentali dell'Art Nouveau iniziarono a essere visti come eccessive o antiquate, soprattutto dopo l’esperienza traumatica della guerra.
Dopo il conflitto bellico, il mondo era cambiato. L’arte e l’architettura dovevano rispondere a esigenze di efficienza e ricostruzione. Nuovi movimenti – Futurismo, Costruttivismo, Modernismo, Razionalismo – presero il sopravvento, lasciando il Liberty come espressione di un tempo ormai lontano, elegante e decorativo, ma non più adatto alla nuova realtà.



















































