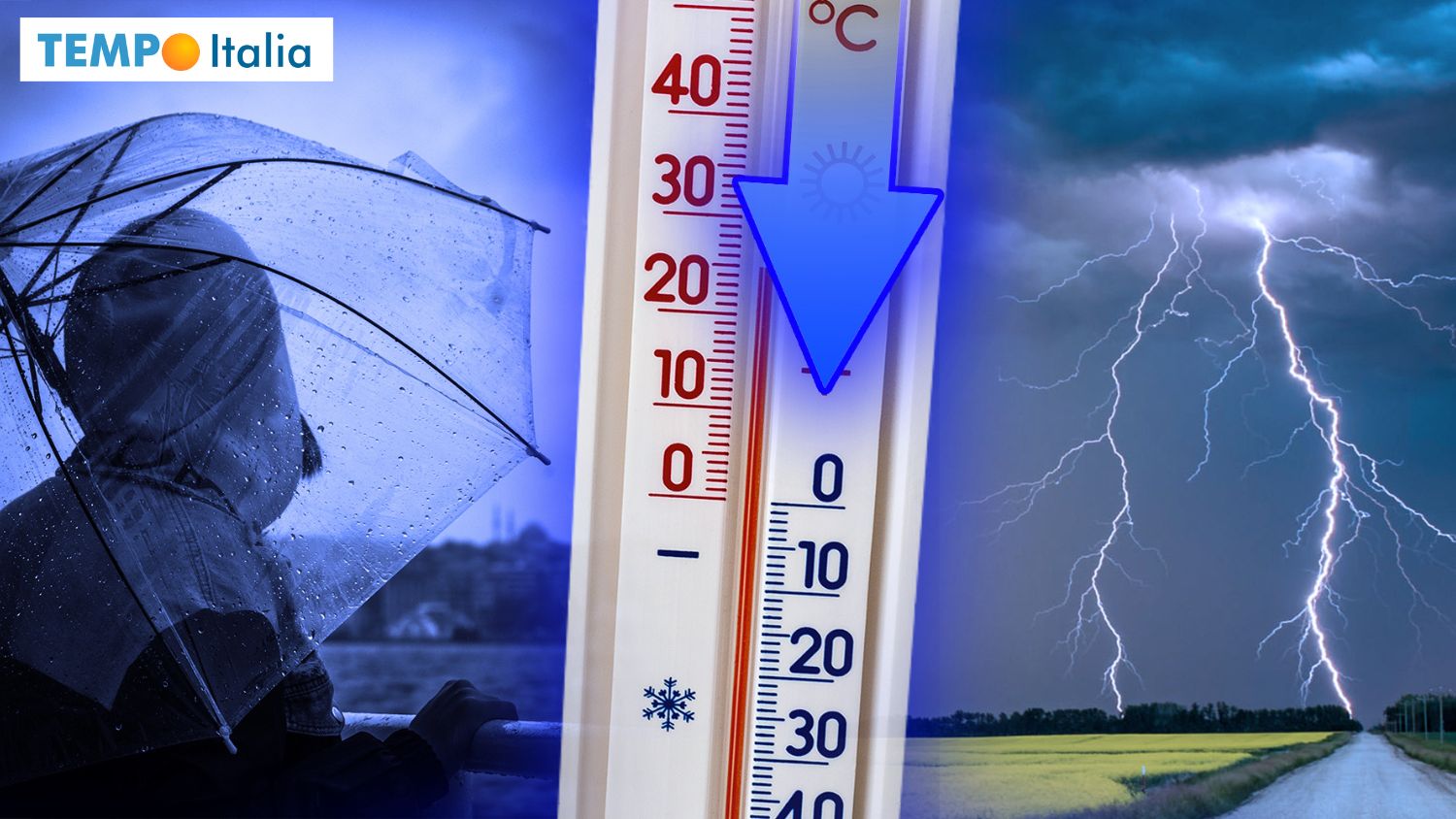Krisis
Riflessioni sulla situazione spirituale del tempo (a partire da alcune esperienze musicali recenti) Un mondo in crisi lo si può raccontare in modalità radicalmente differenti. Di più, lo si può […]

Riflessioni sulla situazione spirituale del tempo (a partire da alcune esperienze musicali recenti)
Un mondo in crisi lo si può raccontare in modalità radicalmente differenti. Di più, lo si può vivere, ed esperire, in termini quasi opposti. Quali sono dunque le possibili posture, o i possibili tentativi, da assumere di fronte alla crisi? Questo è il tema, oggi attualissimo – come poter ricostituire, o almeno mettere le primissime basi, di una prospettiva di trasformazione che non eluda, ma anzi assuma, sino in fondo, la disgregazione. Ecco il problematicismo dell’attualità: ridonare una forma, partendo da quella peculiarissima diade di crisi e rivoluzione. Non esser ciechi di fronte ad un’attualità che ci ha resi come immobili – non comportarsi, cioè, come se la frantumazione non sia mai esistita, o, peggio, come se essa sia un momento facilmente riassumibile in una filosofia della storia che volgerebbe ineluttabilmente verso il meglio… – ma, insieme, continuare ad avere memoria, continuare a “ripetere”, incessantemente, che questo mondo non sia Il mondo. Già ripeterlo, infatti, già non farsi egemonizzare (nello spirito) dalle categorie dominanti, sarebbe qualcosa. Per un motivo in realtà molto semplice: perché gli oppressi, i marginali, i “barbari” – chiamateli come volete! – esistono ancora (forse, da un certo punto di vista, anche di più rispetto a prima), ed allora, ecco, quel fardello è necessario continuare ad averlo, anche, e soprattutto, in una società che è, e rimane, una società Nemica.
È un problema liminare, di difficile, o impossibile, risoluzione, che riguarda ciascuno di noi da molto vicino: come combattere contro una società ridicola, senza apparire noi stessi ridicoli, fuori luogo, costitutivamente incompresi. Come, cioè, comprendere, e farci comprendere, da una società, innanzitutto antropologicamente (o esistenzialmente), allo sbando. Qualcuno disse che ogni tempo percepisce la propria epoca sull’orlo di una catastrofe – ma quel bordo, mi sembra, che oggi lo abbiamo (da un bel po’) oltrepassato, pur sotto il velo di una tenace difesa dei valori della Civiltà.
Ora, senza alcuna pretesa musicale, richiameremo due album, usciti di recente, quasi in contemporanea, in Italia: quello del rapper campano Anastasio e quello, inaspettato (perché dopo quasi dieci anni e senza alcuna presentazione), del progetto musicale denominato “I Cani”. Questi album, tuttavia, non verranno tratti in questo testo come un corpo autonomo – piuttosto costituiranno lo spunto per continuare il discorso a cui accennavamo in precedenza: e cioè il problema dell’oggi della nostra Cultura.
Posture differenti di fronte alla crisi, perché, infatti, entrambi gli album (e probabilmente il discorso si potrebbe ampliare al loro intero percorso musicale – ma qui il discorso si complicherebbe, soprattutto per quanto riguarda “I Cani”) partono dallo scacco di un tempo storico. Entrambi, cioè, si originano nell’assunzione, innanzitutto esistenziale, che in questa società, o in questo Mondo, è divenuto molto difficile vivere – e che quei racconti sognanti di una società in perenne evoluzione, costituita da luccichii e apparenti splendori tutti da scoprire, coprano solamente, in realtà, un sottosuolo sudicio, che viene sempre più imputridendosi. Civiltà versus barbarie: ricordate? Al centro di questi album vi è, cioè, ad una prima istanza una venatura tutta esistenziale (con Anastasio avremo un passaggio più esplicito verso il tema politico, ma su questo torneremo) – il fatto, cioè, che la crisi sia arrivata ormai fin dentro l’individuo e, allora, raccontare il privato, se fatto in un certo modo, può assumere una valenza più ampia, poiché, infatti, in contesti di crisi come questo, scindere nettamente esistenza e politica, problematica antropologica e problematica Culturale, non sembra esser più possibile.
Perché oggi, infatti, dovremmo, innanzitutto, riprendere il tema della lotta tra antropologie e forme di vita differenti: il proprio corpo come simbolo di qualcos’altro, ma non alla maniera della biopolitica – piuttosto come un esistenzialismo Kierkegaardiano che scende nell’arena del conflitto. Ma la critica, dicevamo, può assumere toni e sfumature differenti: si possono, cioè, vivere ed esperire mondi simili, ma esprimere, mediante il racconto, posture e possibilità radicalmente divergenti. La medesima crisi, infatti, può condurre a dei tentativi opposti. Ed è proprio su questo punto che mi sembra si divarichino le strade di questi album: nelle diverse modalità di fronteggiare una Cultura in decadimento – e cioè, ancora una volta, nel differente corpo a corpo che si istituisce con il problema della crisi. Perché se, infatti, fino adesso abbiamo individuato alcuni punti di contatto, ora è il momento, probabilmente più importante, delle differenze, perché da qui, forse, potremmo ricavare suggerimenti anche per il nostro tempo.
In una sintesi brutale, che poi tenterò brevemente di argomentare: nei confronti di questa Cultura ormai più che al tramonto, l’album de “I cani” sembra, al fondo, subordinato, eteronomo – Anastasio, invece, pur cantando dinamiche simili, sembra conservare uno stile (che diviene immediatamente contenuto) differente, alla ricerca, cioè, di un’autonomia e di un impossibile resto oltre la società/Tutto. Il tema, cioè, riguarda la differente relazione che si istituisce nei confronti di quello che potremmo definire il “mondo delle convenzioni”: in entrambi gli album è espresso un disagio, un malessere nei confronti di quest’ultimo – ma nel primo caso, quello de “I Cani”, è come se le dinamiche di questa Cultura fossero interiorizzate al punto che anche un’eventuale critica non può che procedere a rimorchio (un non riuscire, costantemente, ad essere qualcosa..), mentre in Anastasio, invece, è come se emergesse quel disprezzo, quella durezza, in grado di non farti consumare, mai, definitivamente.
In altri termini: se, con “I Cani”, l’antropologia di questa nuova società, che va sempre più livellandosi in direzione di una condizione medio-borghese, non può che avvolgere, e divorare, tutto, mutando la tua stessa esistenza, anche la più radicale critica non può essere che al fondo subalterna. Un’assunzione, o interiorizzazione, assoluta che si tramuta in un perenne non sentirsi all’altezza di questo mondo, il quale, evidentemente, così, continua a distribuire le carte ed assegnare punteggi e valori. Ecco, allora, come il raccontare il disagio nei pranzi (di Natale, di Santo Stefano ecc.), o ancora nelle cene di classe o con i colleghi, costituisca, in realtà, il riflesso deformato di un vivere costantemente alla rincorsa – l’esser critici, ma al contempo schiavi, di alcune dinamiche. L’esser dipendenti da questa forma di Cultura.
Ma a questo – e qui ritorniamo ad Anastasio, o agli embrioni che egli potrebbe lasciarci in eredità – si può contrapporre un tentativo differente. Una possibilità che anch’essa vive, esperisce e, dunque, in una qualche misura interiorizza questa società, ma non lasciandosi assorbire mai, definitivamente, tutti interi. Si continua ad abitare il mondo – sarebbe anzi impossibile, oltre che indesiderabile, esser tagliati completamente fuori dalle sue logiche perché è in esso, infatti, che, scorgendo barbari ed oppressi, aneliamo una trasformazione. Da qui la necessità di entrare al suo interno, ma con un’importantissima postilla: senza rimanerne schiavi. Questa dinamica oscillante tra un dentro ed un fuori, seguendo l’Amleto, potremmo descriverla come una “follia ragionata”. Ed ecco dunque ritornare la necessità di autonomia, di quella componente dura, o sanguigna, che ci impone di non-accettare tutte quelle più piccole dinamiche nelle quali ci ritroviamo a vivere. Un lavoro difficile, liminare: criticare quest’antropologia nei suoi lati più interni (interiori), ma per mostrare, o rivelare, la possibilità di un’altra forma di vita. Uno sdegno attivo, che non eluda il mondo senza, però, divenirne-dipendenti.
Sono questi anche i motivi per cui l’album di Anastasio evita di assumere quell’orizzonte medio-borghese come il solo ed unico, e tenti, piuttosto, pur partendo ancora dal lato esistenziale, di divenire alternativa Culturale. Un’alternativa, in realtà, tutta da costruire, che non scorge alcun cambiamento prossimo all’orizzonte, ma che crede, ancora, nella possibilità dell’esempio – come se solamente da qui, dalla messa in forma di un’altra antropologia, si potesse ricominciare a pensare simultaneamente ad un’alternativa politica. Un inizio, evidentemente, la cui meta è impossibile da vedere, e che non ci eluderà (ancora per moltissimo tempo) il compito di abitare qui, in questa Cultura, ma che almeno comincia a parlare di qualcos’altro a qualcun altro, non potendone più di ascoltare solo ed esclusivamente la litania di una borghesia al tramonto, ingabbiata da un mondo che si rimpicciolisce giorno dopo giorno.
Ed è proprio questo ciò che mi sembra tentasse di fare anche Papa Francesco, scomparso proprio in questi giorni – delineare un’alternativa antropologica (spirituale) che fosse in grado, simultaneamente, di assumere una postura Culturale, politica, entrando, cioè, nell’arena del conflitto e delle disuguaglianze conservando un resto, per parlare e farsi parlare dai marginali, o Barbari. Un esempio alto, altissimo, di sfida al “mondo delle convenzioni”, che anche questa rivista, La Fionda, pur in altri modi, o in altre forme, mi sembra stia perseguendo: oscillare, acrobaticamente, tra un dentro ed un fuori. La “follia ragionata” dell’Amleto: parlare a questo mondo tentando, disperatamente, di non vivere come questo mondo.