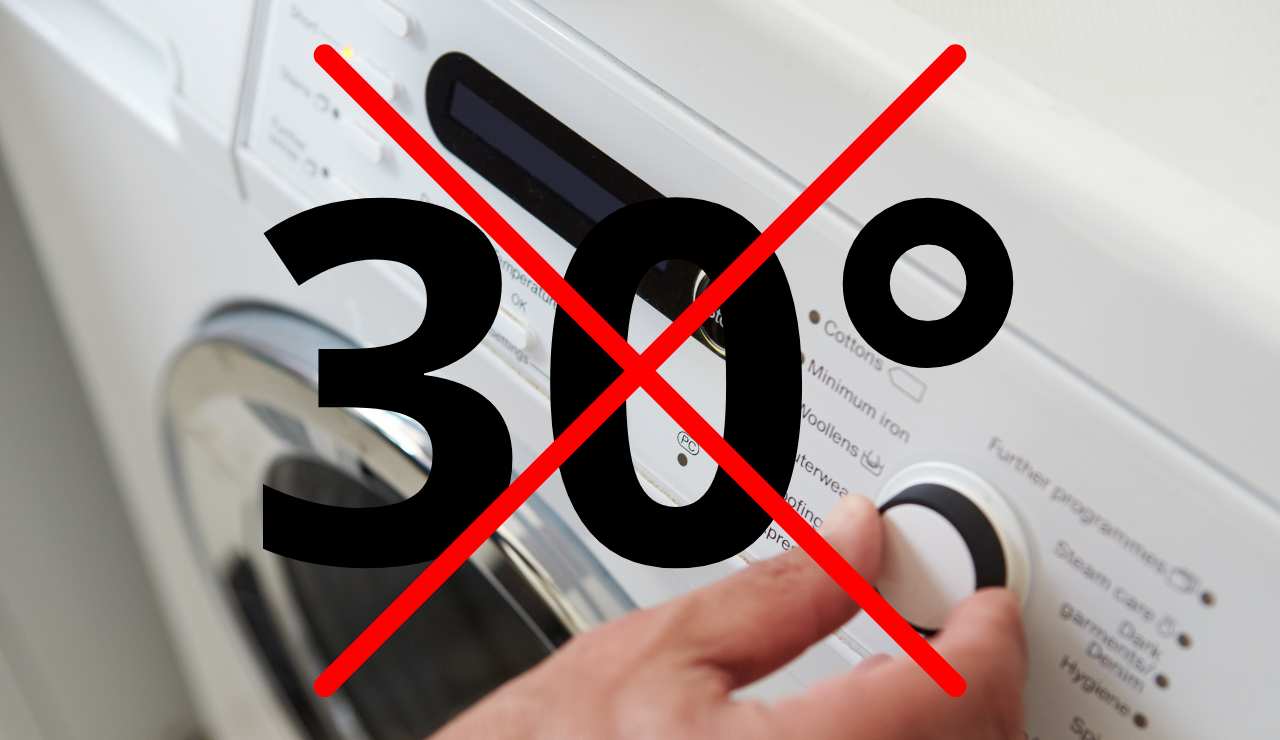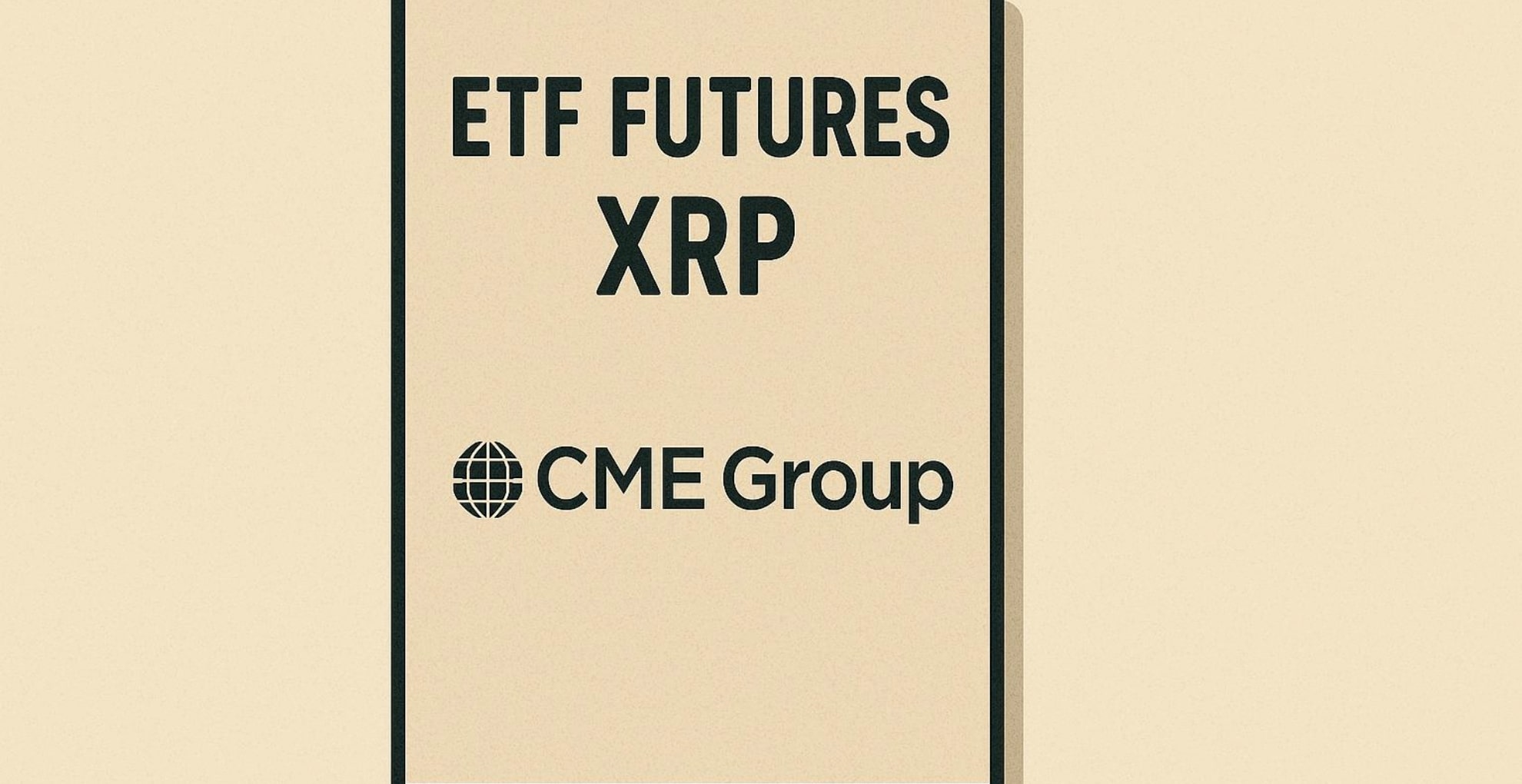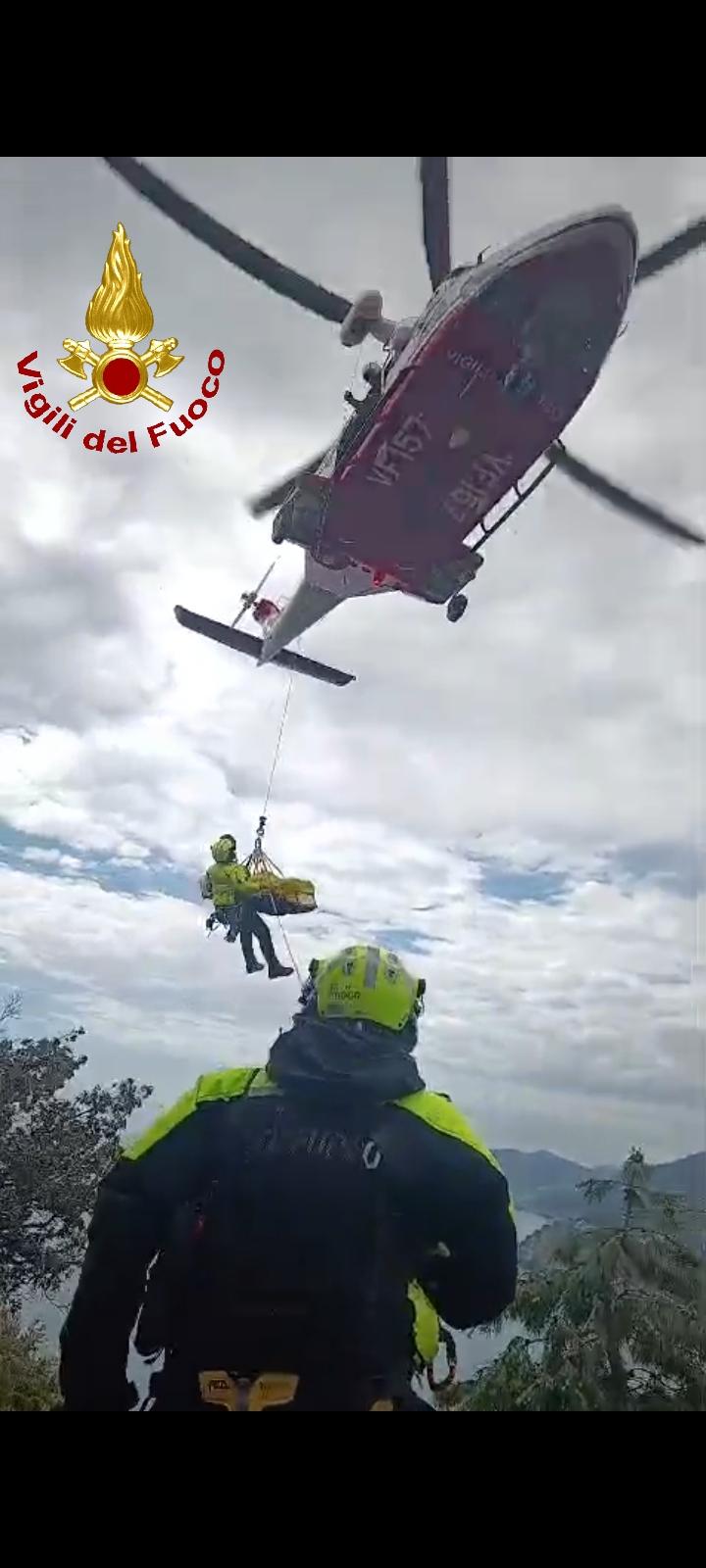In vigna si torna al futuro, puntando sulla biodiversità contro la desertificazione
Il museo Vites, parte della rete Sud heritage, testimonia come l’incontro fra tradizione e innovazione possa favorire la sostenibilità in viticoltura.

Liquirizia, bergamotto e ginestra sono solo alcuni dei profumi che caratterizzano la Calabria, e che si possono ritrovare anche nei suoi vini. E sono solo alcuni dei prodotti che si possono scoprire visitando i musei d’impresa della regione, che, grazie a un’idea di Nicodemo Librandi, hanno dato vita alla rete Sud heritage.
Si tratta di “luoghi che valorizzano una realtà produttiva importante, ma servono anche a favorire la sperimentazione e l’innovazione”, per usare le parole del presidente di Sud heritage, Florindo Rubbettino. Tutto è partito dal museo Vites, uno spazio dedicato a viticoltura, territorio e storia, che si trova all’interno di una delle tenute dell’azienda vinicola Librandi: la tenuta Rosaneti, a Rocca di Neto, in provincia di Crotone.

Il museo Librandi Vites tra passato, presente e futuro della vitivinicoltura
Il museo Vites mira a mantenere viva la memoria della cultura enologica locale, per capire come le pratiche agricole tradizionali possano essere attualizzate per assicurare un domani al mondo della vite e del vino, nel rispetto del territorio e della biodiversità.
Lo spazio è suddiviso in otto sale che illustrano passato, presente e futuro della vitivinicoltura e che accolgono una vasta collezione di attrezzi e testimonianze che sono stati raccolti, negli anni, dalla famiglia Librandi e da altre famiglie del posto.
- Le origini della viticoltura in Calabria
- L’impianto del vigneto e la lavorazione della terra
- La gestione e la cura del vigneto
- La vendemmia
- Il bottaio
- La cantina
- Il palmento
- L’imbottigliamento e la degustazione
Il ruolo dell’agricoltura rigenerativa
“Il museo testimonia un’epoca in cui il reddito di una famiglia dipendeva interamente da un piccolo appezzamento di terra: mantenerlo in salute era essenziale, grazie a consuetudini che, oggi più che mai, sono tornate attuali”, spiega Paolo Librandi, uno dei figli di Nicodemo, che gestisce l’azienda insieme al fratello e ai cugini. La famiglia si prende cura di oltre 200 ettari di vigneto, suddivisi fra sei tenute, di cui quattro nella DOC Cirò. La tenuta Rosaneti, la più grande, vanta anche ottanta ettari di uliveto.
La produzione agricola, oggi, è minacciata dalla crisi climatica. La Calabria è fra le regioni d’Italia dove la viticoltura sta subendo le conseguenze peggiori dei cambiamenti climatici, tant’è che i Librandi si stanno trovando a fare i conti con fenomeni opposti, come la siccità dell’anno scorso e le gelate di quest’anno. Se una volta il “problema” era l’eccessiva vigoria delle viti, ora purtroppo è l’opposto. “In alcune aree della Calabria addirittura non si fa più vino”, racconta il fratello di Paolo, Raffaele.
Per scongiurare il pericolo della desertificazione, non resta che trarre ispirazione dalle usanze dei nonni, molte delle quali potrebbero essere attualmente descritte come soluzioni basate sulla natura e rientrare nella definizione di agricoltura rigenerativa. Fra queste pratiche, volte a preservare e migliorare la qualità del suolo, rientra la tecnica del sovescio, che consiste nella semina di piante erbacee, destinate a essere trinciate e interrate, affinché agiscano da fertilizzanti naturali. Parliamo per esempio delle graminacee, fra cui orzo, segale o avena; delle crucifere, come la senape bianca, e delle leguminose, come il favino, che consente di aumentare la quota di azoto nel suolo e la porosità del terreno grazie ai canali lasciati dalle radici qualche tempo dopo la trinciatura.

Il concetto di semina polifunzionale
Tradizione e innovazione si incontrano quando alla tecnica del sovescio si abbina una procedura, nota come Biopass (Biodiversità, paesaggio, ambiente, suolo, società), che consente di monitorare l’impatto dell’intervento umano. Questo metodo, messo a punto dallo studio agronomico Sata, prevede vari passaggi, fra cui l’esame visivo dello stato fisico e strutturale del suolo (visual soil assessment) e l’analisi della microfauna in esso presente, come spiega la dottoressa Marta Donna, agronoma dello studio Sata e consulente dell’azienda Librandi. La tutela del suolo è il primo passo per la salvaguardia dell’intero ecosistema: ecco perché il concetto di sovescio finisce per evolversi nel più ampio concetto di semina polifunzionale.
“Le piante che seminiamo – racconta Davide De Santis, responsabile agronomo dell’azienda – attirano anche le api e altri insetti che si cibano di quelli dannosi per le viti, garantendo l’equilibrio dell’ecosistema vigneto”. De Santis ha contribuito anche allo studio del comportamento dei lepidotteri notturni che frequentano le vigne, un progetto con cui il Crea mira a catalogare le specie presenti nell’area e capire come rispondono alle pratiche agricole e ai cambiamenti climatici.
La famiglia Librandi e la conservazione dei vitigni autoctoni
“Possiamo dire che la biodiversità sia il tassello mancante del terroir”, aggiunge la dottoressa Donna. In enologia, questo termine fa riferimento all’insieme di elementi che portano alla nascita di un vino e lo distinguono dagli altri: le peculiarità del vitigno, la composizione del terreno, le caratteristiche del clima e l’intervento dell’uomo. È per salvaguardare i vitigni autoctoni della regione – come gaglioppo, magliocco dolce, greco bianco, mantonico e altri meno conosciuti – che la famiglia Librandi si sta impegnando a raccogliere e studiare in modo analitico il germoplasma viticolo calabrese, un patrimonio ricchissimo e scarsamente conosciuto, dal quale si può imparare molto in termini di adattamento climatico.
Da questa intensa attività di ricerca sono nati il volume Il gaglioppo e i suoi fratelli e il giardino varietale della tenuta Rosaneti, che accoglie attualmente circa duecento varietà di vite recuperate su tutto il territorio regionale e disposte in un vigneto dalla caratteristica forma a spirale. La famiglia si sta impegnando anche a preservare tecniche di allevamento tradizionali come quella dell’alberello, che si adatta perfettamente a climi caldi e siccitosi.

Il rispetto della natura
Altre pratiche volte a rispettare la natura sono la lavorazione superficiale dei suoli, che favorisce la ritenzione idrica; la potatura rispettosa delle viti, effettuata senza intaccare le parti dove scorre la linfa, e l’innesto in campo, che prevede l’innesto di nuovi tralci su portinnesti che si sono sviluppati in loco, anziché in vivaio.

E non bisogna dimenticare che, per ridurre l’impatto dell’agricoltura, si può agire anche al di fuori dei campi: i Librandi, per esempio, hanno installato un impianto fotovoltaico che soddisfa buona parte del fabbisogno energetico dell’azienda, e hanno ridotto il peso delle proprie bottiglie da 750 ml. Grazie alla collaborazione con altri imprenditori, gli scarti della produzione vinicola vengono trasformati in distillati, energia e biodigestato, in ottica di economia circolare.
L’obiettivo, insomma, è quello di restituire alla terra tutto ciò che ci dona. E così, quando saremo colpiti dal profumo di bergamotto in un calice di bianco, o dal profumo di liquirizia in un calice di rosso, ci ricorderemo che, dietro ogni bottiglia di vino, si cela un’interpretazione unica del rapporto fra l’uomo e la natura.