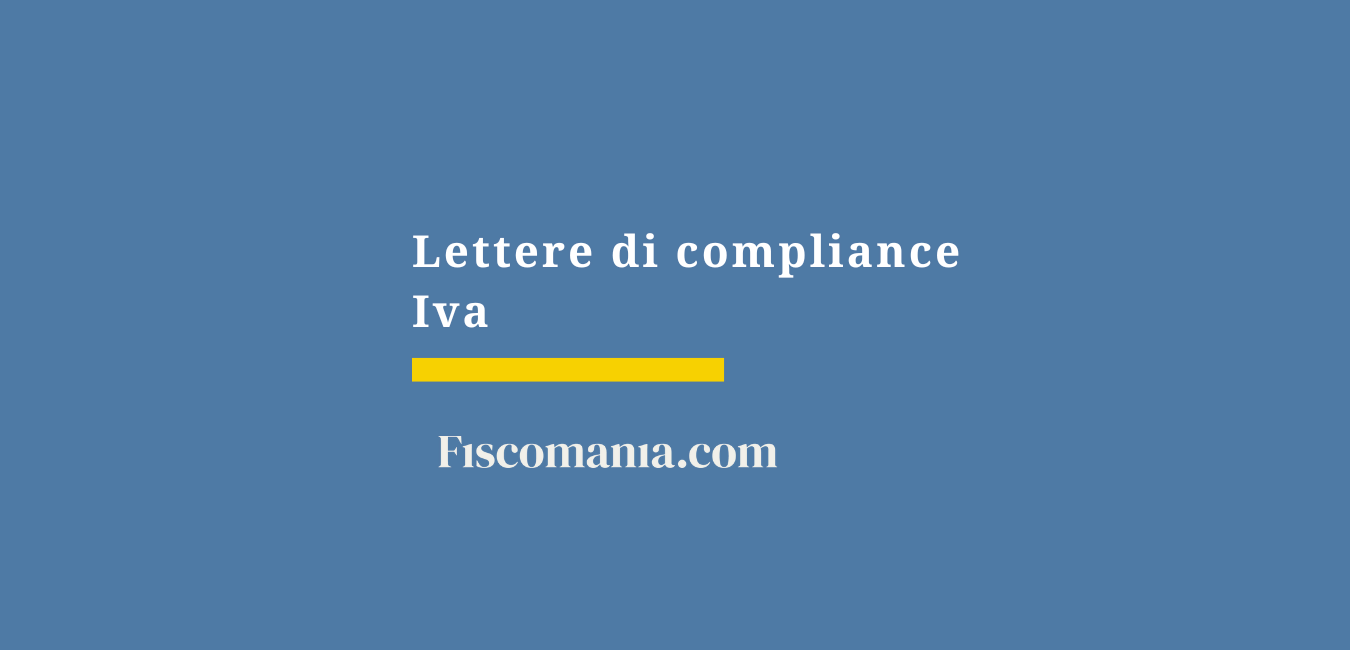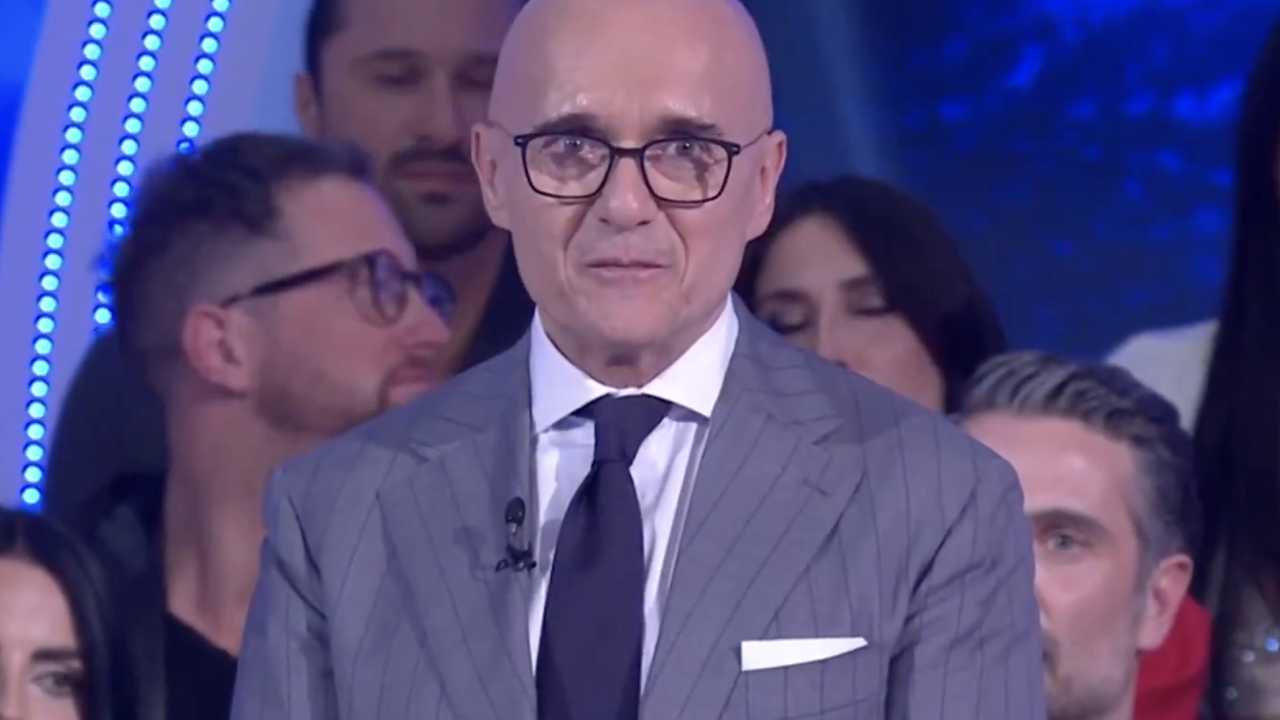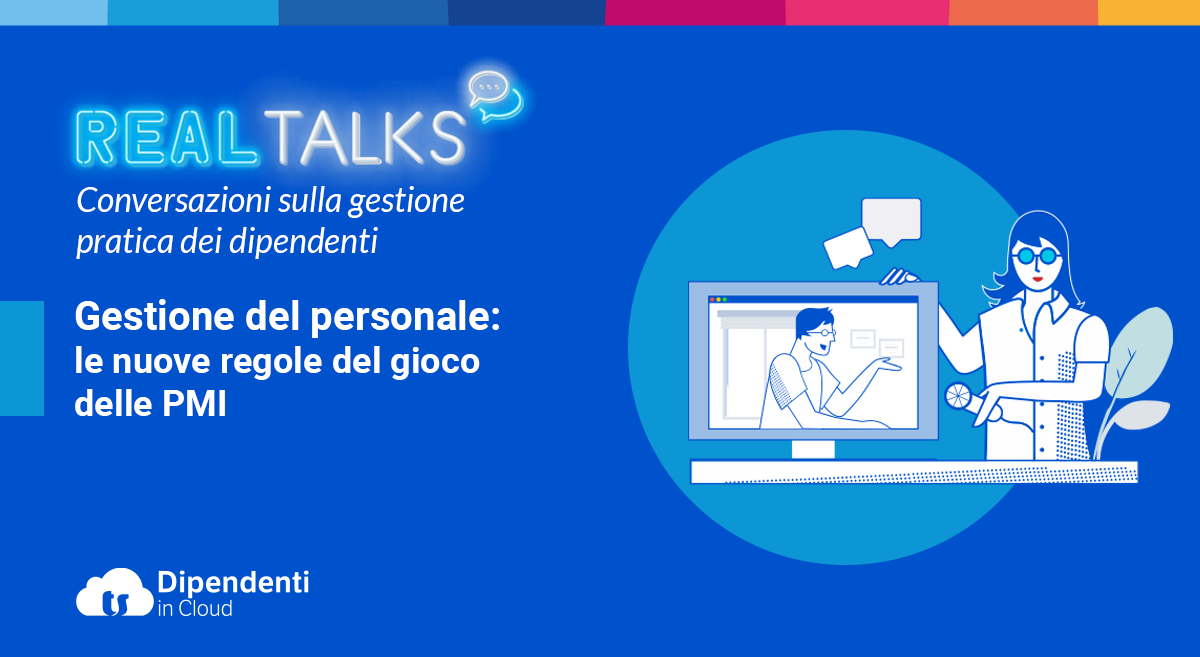Greenpeace e la maxi-condanna negli Usa: cosa succede adesso?
In attesa del verdetto ufficiale del giudice, passaggio formale necessario per presentare ricorso, Greenpeace prova a tutelarsi contro il maxi-risarcimento cui verrà presto ufficialmente condannata negli Stati Uniti in favore di Energy Transfer, una major texana del fossile che ha citato in giudizio l’associazione nel 2017. La speranza dell’associazione è che possa venire applicata la […] The post Greenpeace e la maxi-condanna negli Usa: cosa succede adesso? first appeared on QualEnergia.it.

In attesa del verdetto ufficiale del giudice, passaggio formale necessario per presentare ricorso, Greenpeace prova a tutelarsi contro il maxi-risarcimento cui verrà presto ufficialmente condannata negli Stati Uniti in favore di Energy Transfer, una major texana del fossile che ha citato in giudizio l’associazione nel 2017.
La speranza dell’associazione è che possa venire applicata la direttiva europea anti-SLAPP, che tutela le persone e le associazioni che si esprimono su questioni di interesse pubblico da azioni legali abusive volte a metterle a tacere.
Ma andiamo con ordine.
La decisione della giuria
Secondo una giuria del tribunale di Mandan, nel North Dakota, Greenpeace ha danneggiato il colosso energetico americano Energy Transfer guidando le proteste che quasi dieci anni fa hanno coinvolto diversi attori e associazioni conto il Dakota Access Pipeline, un oleodotto sotterraneo necessario a trasportare il greggio dalla Bakken Formation (una zona al confine tra Montana e North Dakota) fino all’Illinois, attraversando il South Dakota e l’Iowa.
L’associazione è stata giudicata colpevole di violazione di proprietà privata, diffamazione e associazione a delinquere ed è stata condannata a pagare un risarcimento da 660 milioni di dollari.
Nel 2016 infatti (e in parte anche nel 2017) gruppi di nativi americani e attivisti ambientalisti si schierarono contro la costruzione di questa infrastruttura, ritenendo che avrebbe inquinato le acque del fiume Missouri e danneggiato terre sacre per i nativi americani.
La Energy Transfer aveva fatto causa a Greenpeace per circa 300 milioni di dollari. La giuria ha quindi più che raddoppiato la somma a carico dell’associazione. Il verdetto del giudice non è ancora stato emesso, ma si tratta solo di una formalità: la decisione dei giurati, fortemente contestata, verrà confermata.
“Il processo si sta svolgendo in una location fortemente impattata dalla presenza dell’azienda, avevamo chiesto di spostarlo in una sede neutrale, ma ce l’hanno negato”, commenta a QualEnergia.it Simona Abbate, Campaigner “Energia e Clima” di Greenpeace Italia.
La Corte infatti si trova nello stesso luogo in cui sono avvenuti gli eventi del 2016. “Popolazione e giuria sono troppo influenzati, non c’è il giusto distacco”, spiega Abbate.
Mandan si trova un’ottantina di chilometri a nord di Standing Rock, la riserva indiana abitata dai Sioux dove si concentrarono le proteste, alle quali si unirono anche membri di altre tribù, attivisti e celebrità. Ci furono anche scontri violenti con le forze dell’ordine.
La genesi delle proteste
Nel giacimento petrolifero di Bakken nel North Dakota, il boom del fracking (la pratica estrattiva di idrocarburi altamente inquinante che avviene tramite fratturazione idraulica, ndr) ha fatto salire alle stelle la produzione di petrolio, tanto che l’industria fossile ha avuto bisogno di un metodo più semplice per far arrivare il suo prodotto alle raffinerie e ai mercati globali. Così, nel 2014, Energy Transfer e i suoi partner hanno proposto il Dakota Access Pipeline.
Fin dall’inizio, i membri della tribù Sioux di Standing Rock, insieme ad altre Nazioni Sioux, si sono opposti.
A partire da aprile 2016 sono stati allestiti accampamenti lungo il corso del fiume Missouri e alcuni giovani “Protettori dell’Acqua” (Water Protectors) hanno organizzato una staffetta di 500 miglia per consegnare una lettera all’US Army Corps of Engineers (il corpo degli ingegneri dell’Esercito degli Stati Uniti) per chiedere l’annullamento dei lavori.
Mentre la costruzione del “Black Snake” (“serpente nero”, come l’oleodotto è stato soprannominato) avanzava verso il fiume, nell’estate e nell’autunno del 2016 le crescenti proteste hanno attirato l’attenzione nazionale e poi globale.
Decine di migliaia di persone, tra cui membri di oltre 300 nazioni tribali, si sono aggiunte alla contestazione. Molte altre hanno agito chiedendo all’amministrazione Obama di bloccare i permessi e presentando petizioni alle banche per interrompere i finanziamenti al progetto.
Poi, l’8 novembre 2016, Donald Trump è stato eletto presidente. Mentre il suo predecessore aveva respinto nel dicembre 2016 la servitù di passaggio (il diritto che permette di raggiungere la propria proprietà in caso quest’ultima non abbia un accesso autonomo), uno dei primi atti di Trump è stato ordinare all’Army Corp di annullare questo provvedimento.
Nel mese di giugno 2017 la costruzione è stata completata e l’oleodotto è entrato in funzione. Da quel momento sono inoltre state promulgate numerose leggi anti-protesta sui combustibili fossili in 18 Stati.
Energy Transfer ha dapprima citato in giudizio il Tribal Chairman Archambault e altri Water Protectors per danni monetari (il caso è stato poi archiviato) e nel 2017 ha citato in giudizio Greenpeace presso la Corte federale. In alcune interviste dell’epoca, il Ceo della major texana, Kelcy Warren, disse che era sua intenzione “far crollare le donazioni” per l’associazione e che il suo obiettivo non fosse avere un risarcimento ma “inviare un messaggio”.
Warren aveva da poco donato 250mila per l’insediamento di Trump. In seguito avrebbe anche organizzato una raccolta fondi di 10 milioni di dollari per supportare la rielezione del candidato repubblicano nel 2020.
La strada della direttiva anti-SLAPP
Greenpeace ha sostenuto di aver avuto un ruolo marginale nelle proteste guidate dalla tribù Sioux di Standing Rock e ha detto che cause come questa sono pensate per limitare il diritto alla libertà di parola e quello a riunirsi per protestare in maniera pacifica sanciti dal primo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti.
“Siamo di fronte a un contesto sociale e culturale in cui cause di questo tipo sono all’ordine del giorno. In Francia recentemente abbiamo vinto contro TotalEnergies, in Italia ce n’è una pendente (quella contro Eni, ndr). È un modo che le major del fossile usano per zittire le organizzazioni”, ci spiega ancora Abbate.
L’azione legale di Energy Transfer è giudicata da Greenpeace un esempio di “Strategic Lawsuit Against Public Participation” (“Causa strategica contro la partecipazione pubblica” o Slapp): un’azione legale intentata per bloccare gli attivisti e le organizzazioni non profit con ingenti spese legali.
Secondo la direttiva Ue anti-Slapp, chi ritiene di essere bersaglio di questo tipo di azioni legali può chiedere agli organi giurisdizionali competenti di rigettare il prima possibile una denuncia manifestamente infondata.
Greenpeace International conta di vedersi riconosciute le proprie ragioni contro Energy Transfer presentando un’azione legale presso un tribunale dei Paesi Bassi.
L’eventuale riconoscimento da parte del tribunale olandese avrebbe effetto “anche se la causa è mossa al di fuori dell’Europa”, chiarisce Abbate, a condizione che l’associazione che ha mosso l’azione legale abbia sede nel Vecchio Continente.The post Greenpeace e la maxi-condanna negli Usa: cosa succede adesso? first appeared on QualEnergia.it.