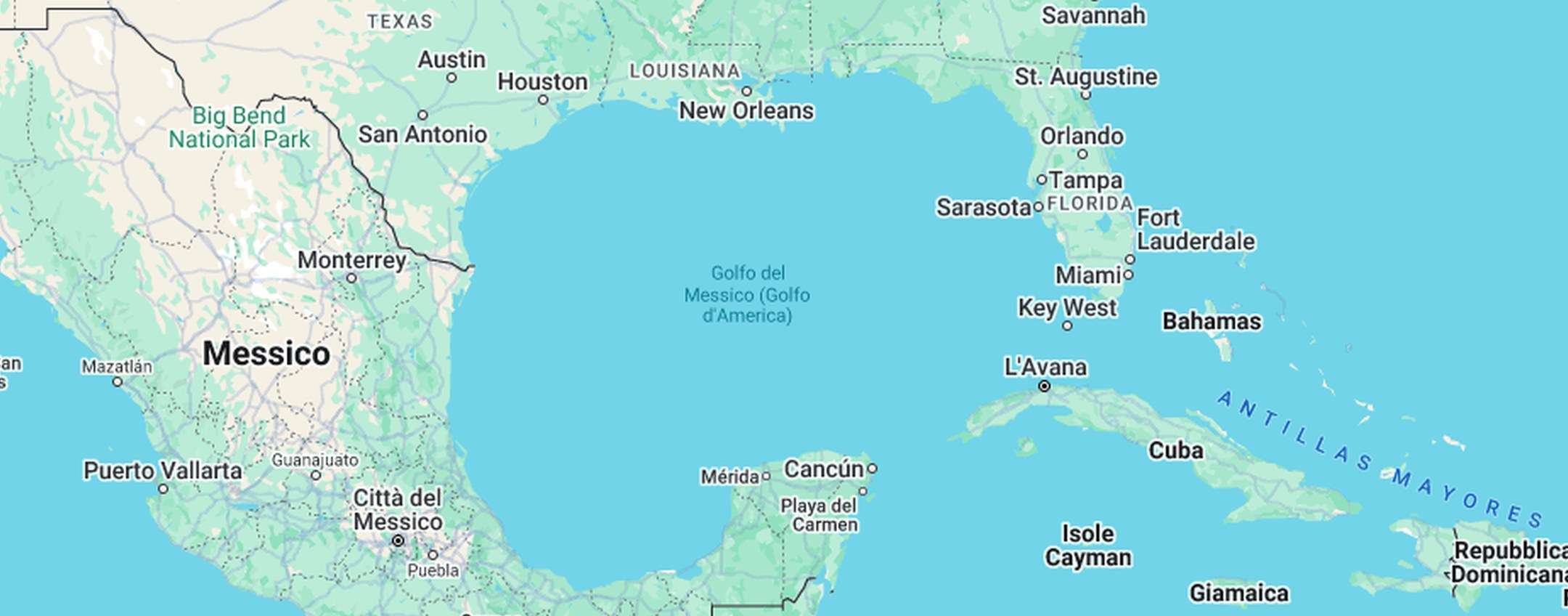Dalla colomba al conclave: così è stata l'elezione dei papi
Tutto ebbe inizio con la nomina di San Pietro a capo degli apostoli da parte di Gesù Cristo con le seguenti parole riportate dall'evangelista Matteo: «Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non prevarranno contro di essa». Con questa nomina, Pietro divenne capo della Chiesa e rappresentante di Cristo sulla terra.Dopo la morte e la resurrezione di Gesù, Pietro e i discepoli predicarono la buona novella in tutto l'Impero romano, fondando una comunità nella capitale stessa dove il santo sarebbe stato crocifisso nel 65 o 67. Tuttavia, prima del suo martirio, Pietro aveva nominato come suo successore il romano Lino, che divenne così il primo vescovo di Roma e il secondo nella linea dei papi.Per questo motivo, i primi pontefici della Chiesa cattolica non furono nominati tramite elezioni o conclavi, ma, seguendo l'esempio di Pietro, erano designati come eredi dal loro predecessore, con passaggi di potere da padre a figlio in un'epoca in cui il celibato non era ancora obbligatorio per i sacerdoti.Ma con l'accumularsi di potere e preminenza da parte della comunità romana, il suo vescovo divenne una figura di spicco per i cristiani occidentali, a imitazione del sommo pontefice pagano; per questo motivo i fedeli si opposero a questo modello di successione dinastica e imposero la sua elezione collettiva da parte di tutta la comunità romana, votazione alla quale partecipavano, a quanto pare, anche i vescovi in qualità di mediatori.A questo primitivo conclave partecipavano sia laici che religiosi, influenzando la nomina “la testimonianza favorevole di quasi tutto il clero, i voti dei laici allora presenti e l'assemblea dei vescovi”, e qualche segno divino come la colomba bianca che si posò sulla testa di Fabiano I nel 236, interpretata come l'intervento dello Spirito Santo.Tuttavia, i problemi sarebbero iniziati con la cristianizzazione dell'Impero, momento in cui la Chiesa divenne un'istituzione statale supervisionata dall'imperatore. Così, lo stesso Costantino si attribuì il potere di nominare Giulio I vescovo di Roma, inventando il titolo di παππάς o papa per designare l'influente prelato romano. Un'ingerenza perpetuata dai suoi successori che avrebbe provocato non pochi scismi quando la Chiesa si sarebbe trovata ad affrontare il sovrano di turno.Con la caduta dell'Impero nel 476, Roma recuperò temporaneamente l'indipendenza quando il re ostrogoto Teodorico il Grande restituì il privilegio di eleggere il successore del papa, misura che durò solo un pontificato (quello di Bonifacio II) fino a quando il popolo chiese il ritorno alle elezioni. Queste erano così segnate dalla corruzione e dalla simonia che il re Atalarico dovette porre un limite legale alle tangenti e ai patrocinati in una delle prime leggi elettorali della storia.Ma tutto sarebbe cambiato nuovamente con il ritorno dell'Impero bizantino in Italia, posta da Belisario sotto il dominio di Giustiniano I, il quale, come Costantino, tornò a nominare di proprio pugno i papi fino a quando i bizantini furono espulsi dai Longobardi e questi a loro volta sostituiti dai Franchi di Carlo Magno. L'imperatore franco impose allora un sistema in cui i nobili romani e i cardinali eleggevano il pontefice, che doveva poi ricevere l'approvazione dell'imperatore prima di diventare papa.Con la disintegrazione dell'impero carolingio, l'elezione del pontefice divenne sempre più una questione interna a Roma, con le varie fazioni nobiliari ed ecclesiastiche che lottavano per il potere sostenendo cardinali affini, dando origine a periodi oscuri come la pornocrazia: quando la nobile romana Marozia e i suoi sostenitori elessero cinque papi con la coerciione e l'assassinio.Le ingerenze dell'imperatore tedesco Ottone I e dei suoi discendenti non fecero che peggiorare la situazione, trasformando il conclave in un evento tumultuoso da cui emersero numerosi antipapi, fino a quando finalmente Nicola II si ribellò con l'appoggio delle truppe del duca di Lorena e convocò nel 1059 un concilio a Roma per restituire l'indipendenza alla Chiesa.Fu con la bolla In Nomine Domine che il papa stabilì finalmente il processo elettorale seguito ancora oggi: in base a esso, sono i cardinali a eleggere il pontefice, preferibilmente a Roma, senza la partecipazione della nobiltà laica, dei re o degli imperatori, rendendo così il conclave una questione interna alla Chiesa.-----Questo contenuto è stato originariamente pubblicato nella nostra newsletter settimanale. Ti è piaciuto? Iscriviti alla newsletter che più ti interessa e ricevi gratuitamente ogni settimana i migliori reportage, fotografie e notizie direttamente nella tua casella di posta elettronica.

Tutto ebbe inizio con la nomina di San Pietro a capo degli apostoli da parte di Gesù Cristo con le seguenti parole riportate dall'evangelista Matteo: «Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non prevarranno contro di essa». Con questa nomina, Pietro divenne capo della Chiesa e rappresentante di Cristo sulla terra.
Dopo la morte e la resurrezione di Gesù, Pietro e i discepoli predicarono la buona novella in tutto l'Impero romano, fondando una comunità nella capitale stessa dove il santo sarebbe stato crocifisso nel 65 o 67. Tuttavia, prima del suo martirio, Pietro aveva nominato come suo successore il romano Lino, che divenne così il primo vescovo di Roma e il secondo nella linea dei papi.
Per questo motivo, i primi pontefici della Chiesa cattolica non furono nominati tramite elezioni o conclavi, ma, seguendo l'esempio di Pietro, erano designati come eredi dal loro predecessore, con passaggi di potere da padre a figlio in un'epoca in cui il celibato non era ancora obbligatorio per i sacerdoti.
Ma con l'accumularsi di potere e preminenza da parte della comunità romana, il suo vescovo divenne una figura di spicco per i cristiani occidentali, a imitazione del sommo pontefice pagano; per questo motivo i fedeli si opposero a questo modello di successione dinastica e imposero la sua elezione collettiva da parte di tutta la comunità romana, votazione alla quale partecipavano, a quanto pare, anche i vescovi in qualità di mediatori.
A questo primitivo conclave partecipavano sia laici che religiosi, influenzando la nomina “la testimonianza favorevole di quasi tutto il clero, i voti dei laici allora presenti e l'assemblea dei vescovi”, e qualche segno divino come la colomba bianca che si posò sulla testa di Fabiano I nel 236, interpretata come l'intervento dello Spirito Santo.
Tuttavia, i problemi sarebbero iniziati con la cristianizzazione dell'Impero, momento in cui la Chiesa divenne un'istituzione statale supervisionata dall'imperatore. Così, lo stesso Costantino si attribuì il potere di nominare Giulio I vescovo di Roma, inventando il titolo di παππάς o papa per designare l'influente prelato romano. Un'ingerenza perpetuata dai suoi successori che avrebbe provocato non pochi scismi quando la Chiesa si sarebbe trovata ad affrontare il sovrano di turno.
Con la caduta dell'Impero nel 476, Roma recuperò temporaneamente l'indipendenza quando il re ostrogoto Teodorico il Grande restituì il privilegio di eleggere il successore del papa, misura che durò solo un pontificato (quello di Bonifacio II) fino a quando il popolo chiese il ritorno alle elezioni. Queste erano così segnate dalla corruzione e dalla simonia che il re Atalarico dovette porre un limite legale alle tangenti e ai patrocinati in una delle prime leggi elettorali della storia.
Ma tutto sarebbe cambiato nuovamente con il ritorno dell'Impero bizantino in Italia, posta da Belisario sotto il dominio di Giustiniano I, il quale, come Costantino, tornò a nominare di proprio pugno i papi fino a quando i bizantini furono espulsi dai Longobardi e questi a loro volta sostituiti dai Franchi di Carlo Magno. L'imperatore franco impose allora un sistema in cui i nobili romani e i cardinali eleggevano il pontefice, che doveva poi ricevere l'approvazione dell'imperatore prima di diventare papa.
Con la disintegrazione dell'impero carolingio, l'elezione del pontefice divenne sempre più una questione interna a Roma, con le varie fazioni nobiliari ed ecclesiastiche che lottavano per il potere sostenendo cardinali affini, dando origine a periodi oscuri come la pornocrazia: quando la nobile romana Marozia e i suoi sostenitori elessero cinque papi con la coerciione e l'assassinio.
Le ingerenze dell'imperatore tedesco Ottone I e dei suoi discendenti non fecero che peggiorare la situazione, trasformando il conclave in un evento tumultuoso da cui emersero numerosi antipapi, fino a quando finalmente Nicola II si ribellò con l'appoggio delle truppe del duca di Lorena e convocò nel 1059 un concilio a Roma per restituire l'indipendenza alla Chiesa.
Fu con la bolla In Nomine Domine che il papa stabilì finalmente il processo elettorale seguito ancora oggi: in base a esso, sono i cardinali a eleggere il pontefice, preferibilmente a Roma, senza la partecipazione della nobiltà laica, dei re o degli imperatori, rendendo così il conclave una questione interna alla Chiesa.
-----
Questo contenuto è stato originariamente pubblicato nella nostra newsletter settimanale. Ti è piaciuto? Iscriviti alla newsletter che più ti interessa e ricevi gratuitamente ogni settimana i migliori reportage, fotografie e notizie direttamente nella tua casella di posta elettronica.