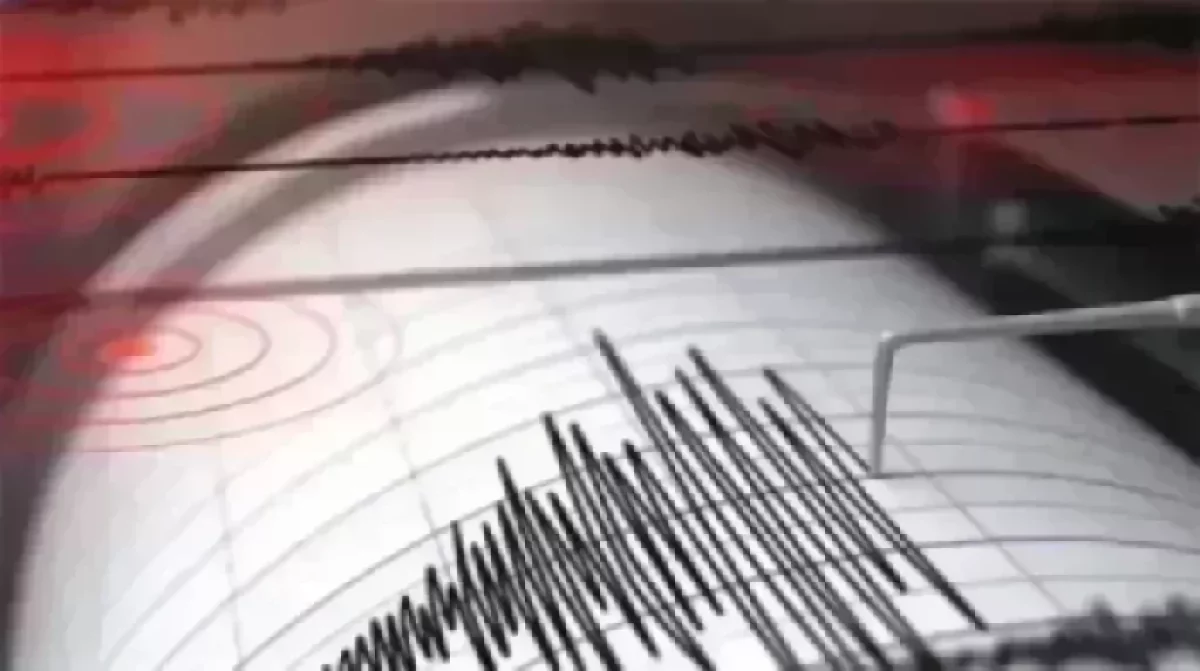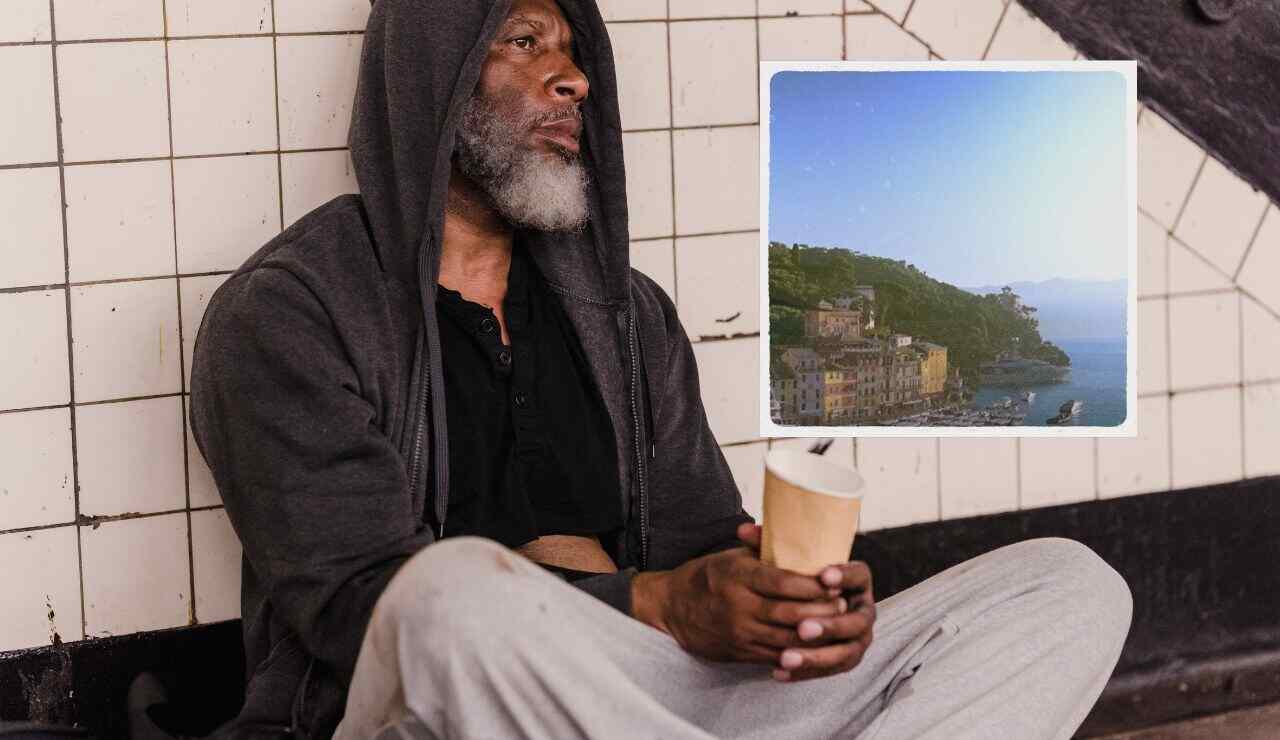Tutte le mosse della Cina, tra i dazi di Trump e il nazionalismo interno. Parla Sisci
Conversazione di Marco Mayer con Francesco Sisci, sinologo di fama internazionale, collabora con la pubblicazione cattolica Settimananews ed è direttore di Appia Institute.

Conversazione di Marco Mayer con Francesco Sisci, sinologo di fama internazionale, collabora con la pubblicazione cattolica Settimananews ed è direttore di Appia Institute
Per contrastare gli effetti negativi dei dazi di Trump la propaganda del Partito Comunista Cinese cerca di far leva sui sentimenti patriottici. Questa retorica sta funzionando?
Sì perché i dazi mettono a rischio milioni di posti di lavoro e sono presentati come contro la Cina (quindi contro i comuni cittadini cinesi) non contro certe pratiche usate da alcuni cinesi “compradores” e dai loro soci occidentali. Quindi rischiano di sollevare un nuovo nazionalismo.
A proposito di patriottismo, in un recente articolo su Appia Institute racconti che il governo ha chiesto a 18 università cinesi di elaborare una nuova disciplina etno-antropologica che si liberi da tutte le influenze e le metodologie occidentali. In cosa consiste concretamente questo progetto?
Ancora non lo sappiamo. Ma l’intento pare essere limitare o eliminare l’influenza occidentale presente e futura, in caso di aumento di tensioni.
Il tentativo di ridimensionare (se non cancellare) le centinaia di differenti identità tradizionali, territoriali e linguistiche che convivono in Cina accentuerà i conflitti generazionali in un paese caratterizzato tuttora da un forte invecchiamento della popolazione?
Qui ci sono due livelli di analisi. Le minoranze in quanto tali e le minoranze come percepite dalla legge. Il partito comunista cinese adottò la definizione e l’implementazione legale di minoranze nazionali assumendole dall’Unione Sovietica. L’Unione Sovietica aveva creato questa organizzazione per dare identità e rafforzare le varie minoranze della ex Russia che si erano alleate ai comunisti contro i russi bianchi zaristi.
La situazione in Cina era molto diversa in realtà da quella della Russia, ma esistevano delle similitudini: in Mongolia interna, nel grande Tibet, nel Xinjiang, gli Han, l’etnia maggioritaria della Cina, era una minoranza. Quindi una affermazione, è un sostegno a quelle minoranze nazionali era importante per averne l’appoggio contro i nazionalisti del KMT Guomindang che invece non riconoscevano quelle minoranze. Settant’anni dopo la situazione è molto diversa e il partito non vuole che potenze straniere usino i contrasti etnici all’interno del paese per destabilizzarlo. Quindi ora prova a eliminare quelle differenze legali, anche perché in nessuna regione gli han sono più minoranza.
Ci sono rischi che il progetto di costruire una nuova e uniforme identità nazionale cinese finisca per creare una reazione di rigetto come è accaduto con la rivoluzione culturale di Mao o (sia pur con in paesi molto più diversificati) con il fallimento dell’identità sovietica o di quella yugoslava?
È possibile, ma la situazione è diversa da 75 anni fa, appunto. Allora inoltre metà del territorio nazionale era composto da minoranze etniche, molto distinte dagli Han, i mongoli, gli Uiguri, i tibetani, erano in maggioranza. Oggi ovunque gli han sono maggioranza.
È possibile che in seguito alle politiche protezionistiche di Trump in Cina inizi una nuova stagione di chiusura all’esterno oppure la fortissima interdipendenza economica con il resto del mondo prevarrà rispetto all’isolazionismo e costringerà la Cina a parlare con il mondo?
Credo che la Cina si sia preparata per essere isolata. Naturalmente molte cose sono incerte ed è impossibile al momento capire cosa succederà fra un anno o due, anche perché non sappiamo in che misura gli Stati Uniti continueranno con la loro politica dei dazi.
In marzo a Boston ho incontrato Nazli Crouchi, celebre studiosa di scienza politica al Mit. A suo avviso é importante immaginare – tra gli scenari possibili – un mondo in cui l’influenza politica e tecnologica cinese potrebbe superare quella degli Stati Uniti. In questa prospettiva più o meno probabile esiste il rischio che il totalitarismo digitale prevalga sui valori della democrazia liberale e della società aperta?
Non lo so, ma mi sembrano questioni ancora molto remote. Molto più urgenti mi paiono i rischi di scivolare casualmente già nei prossimi mesi in una nuova guerra.
Il deficit commerciale Usa è il sintomo di un crescente processo di finanziarizzazione della economia americana che per anni ha aperto all’ingresso di capitali cinesi e stranieri. Perché a tuo avviso Trump insiste tanto sulla produzione di merci e non solleva il tema centrale su cui la Cina dal 2001 non rispetta le regole di mercato: la mancanza di libertà per gli imprenditori stranieri che investono in Cina?
Credo che ci siano dinamiche complesse all’interno dell’amministrazione americana. E credo che ci sia una analisi forse troppo superficiale della questione China.
In questo momento il mondo sembra assumere un assetto tripolare: da una parte Cina e Russia da un’altra gli Stati Uniti e i suoi alleati e poi c’è un terzo gruppo molto numeroso di paesi che io ho definito “doppiamente allineati” ovvero che perseguono la politica dei due forni sia con Washington che con Pechino. Un tipico esempio è l’Arabia Saudita. Questo equilibrio precario può reggere di fronte al risorgere dei nazionalismi (non solo in Cina)?
Credo che la Russia non sia un polo sia al massimo un pollo, senza l’appoggio cinese la Russia oggi non esisterebbe. Certo l’appoggio cinese non è dittatoriale con la Russia, e Mosca a margini di manovra. Ma credo che sia errato pensare alla Russia, come ad una superpotenza.
Tu sostieni che molti concetti e categorie “occidentali” non sono più significative. Puoi far qualche esempio concreto in cui l’approccio cinese potrebbe indicare una metodologia più adatta ai tempi in cui viviamo?
Vediamo oggi anche in università occidentali quello che si chiama approccio interdisciplinare. Questo è una ammissione che le discipline antiche da sole non funzionano. Bisogna pensare in altri termini naturalmente bisogna vedere anche cosa propone la Cina in questo momento. Ma la debolezza metodologica occidentale offre uno spunto di pensiero che può essere anche positivo.
Oggi si riscoprono le tradizioni storiche del Dragone, ma quanto incidono ancora il marxismo e il pensiero di leader come Mao o dello stesso Presidente Xi Jiping nella formazione scolastica e universitaria dei giovani cinesi?
Io credo che marxismo e soprattutto il maoismo, come forma mentis, siano ancora molto importanti. Fondamentale è l’idea di “caratteristiche cinesi”, adottato da Mao. La peculiarità della Cina, della sua storia, della sua cultura rispetto all’esperienza di altri paesi. Questo è al fondo forse della ricerca attuale.