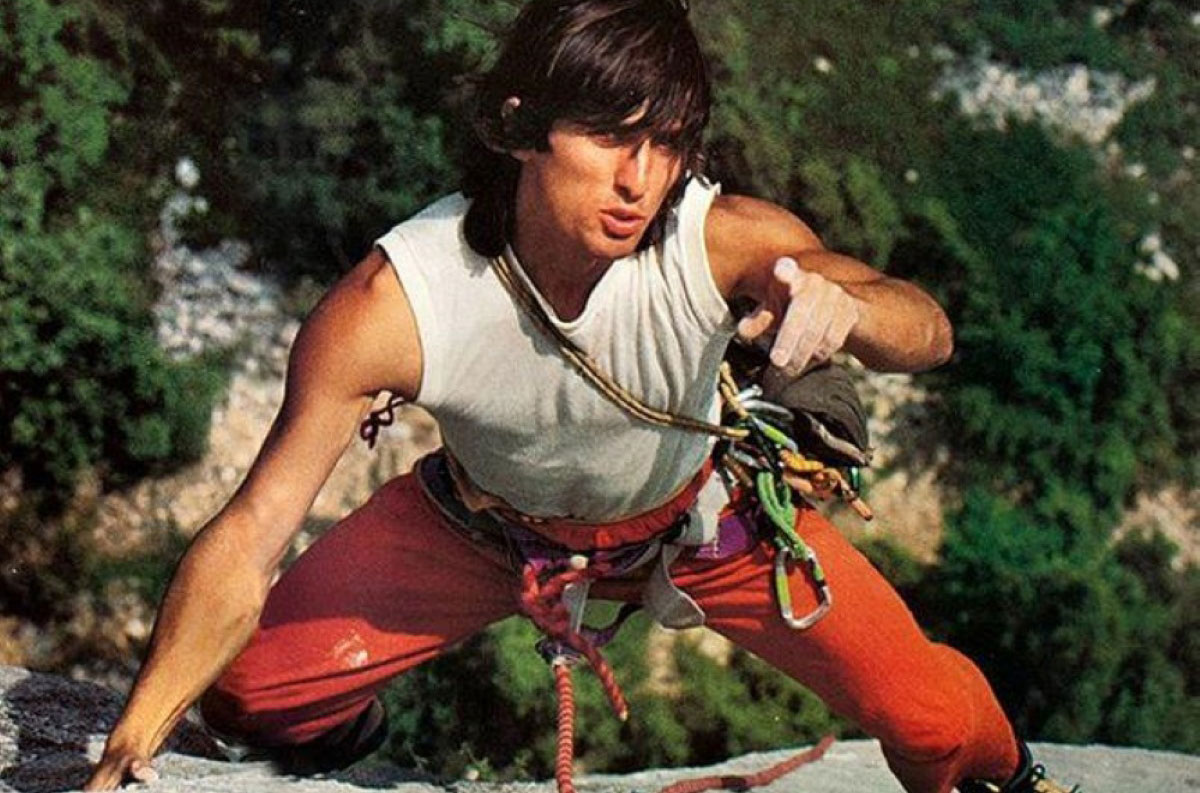Questa la nostra selezione di libri letti ad aprile 2025
L'articolo Questa la nostra selezione di libri letti ad aprile 2025 proviene da THE VISION.
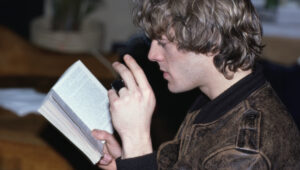
Mai come oggi il concetto di “confine” è al centro del dibattito pubblico, analizza un saggio che ci porta nelle vite di chi è sempre dall’altro lato, mentre altre storie ci guidano alla scoperta dell’industria alimentare e del suo impatto climatico, dei rapporti generativi con l’intelligenza artificiale o in una vicenda all’interno della Stazione Spaziale Internazionale. Ecco cosa abbiamo letto ad aprile 2025.
Il cibo è politica, di Fabio Ciconte (Einaudi)
Il cibo è ovunque. Nei nostri discorsi, nella cultura, nel timore della sua assenza o nella sicurezza della sua abbondanza, sui social, nelle foto, ma anche sempre più nelle nostre scelte: cosa decidiamo di mangiare e cosa no, cosa scegliamo di acquistare e cosa no. A un certo punto, infatti, come scrive Massimo Montanari, uno dei massimi esperti di storia dell’alimentazione, nel saggio Il cibo è politica “C’è stato un momento in cui ognuno di noi ha capito che con i cambiamenti climatici non si scherza e che il pianeta non se la passa bene […] e ci siamo ripromessi di mangiare meno carne, ci siamo impegnati a usare meno plastica e a non sprecare cibo. Persino nei supermercati tutto il cibo sembra essere diventato sostenibile, green”. È il cosiddetto atteggiamento del “voto con il portafoglio”, ovvero usare i propri soldi come un capitale da investire in maniera etica, in modo da sostenere le aziende che rispettano l’ambiente e i diritti dei lavoratori. Eppure basta guardarsi attorno per capire che gli effetti non sono stati proprio quelli desiderati: in Italia lo spreco alimentare continua a crescere, segnando un aumento del 10% rispetto allo scorso anno; nella grande distribuzione, la plastica è praticamente ovunque. Le nostre scelte individuali, cioè, non sono abbastanza e non possono farcela da sole. La narrazione mediatica dell’emergenza climatica finisce infatti per concentrare l’attenzione sulla nostra impronta ambientale individuale, tralasciando però spesso le responsabilità del sistema capitalista e delle grandi aziende.
E allora, è davvero sufficiente essere dei bravi consumatori? È da questa domanda che Montanari inizia per indagare l’industria alimentare e dell’agricoltura, e le conseguenze delle scelte politiche e dei mercati, cercando di ragionare su cosa non va e sulle possibili soluzioni, e interrogandosi sul cibo, perché parlare di cibo significa parlare anche di chi siamo, non solo come individui, ma anche come comunità. È un tema che è normale tocchi corde profonde: non solo quelle sensoriali, nella declinazione più diffusa del food porn, ma emozionali, per elevare il mangiare a una forma di pensiero, un modo di portare il mondo dentro al cibo e raccontare di noi. “Il cibo c’è sempre, anche quando sembra che non ci sia”, scrive, pur non essendo per tutti la stessa cosa. Tuttavia, nessuna trasformazione sistemica può basarsi solo sulla scala individuale, anche se riconoscere la natura sistemica dell’emergenza climatica non significa arrendersi come individui. Le scelte di vita sostenibili sono utili per creare maggiore sensibilità nelle aziende da cui acquistiamo e per la nostra salute, per incentivare azioni politiche e soprattutto per muoverci come collettività. Perché è nelle azioni comuni che possiamo davvero cambiare le cose.
L’intelligenza condivisa. Vivere e lavorare insieme all’AI, di Ethan Mollick (Luiss University Press)
Mano a mano che l’intelligenza artificiale si integra sempre più profondamente nel tessuto della nostra vita quotidiana, diventa sempre più cruciale comprenderne il potenziale e le implicazioni. Viviamo infatti in tempi in cui da un lato ne ammiriamo le occasioni presenti e future che offre, mentre dall’altro temiamo giustamente le possibili ripercussioni che potrebbe comportare a livello di lavoro, società, educazione e intelligenza umana. In un periodo in cui si riflette maggiormente su cosa significhi “creare” e su quanto gli output artistici delle intelligenze artificiali possano essere considerati validi, Ethan Mollick, professore associato alla Wharton School dell’Università della Pennsylvania, presenta l’AI non semplicemente come uno strumento o un’estensione delle capacità umane, ma come un partner in un percorso condiviso di scoperta e innovazione. È la modalità della “co-intelligenza”, un processo che enfatizza una relazione simbiotica tra esseri umani e tecnologie. Piuttosto che considerare l’AI come un sostituto dell’intelligenza umana, Mollick sostiene un approccio collaborativo in cui innovazione e capacità umane si completano a vicenda.
Portando a esempio casi concreti, come l’innovazione nella ricerca medica o il ricorso massiccio ai chatbot generativi per svolgere i temi assegnati a scuola, L’intelligenza condivisa. Vivere e lavorare insieme all’AI delinea quattro regole fondamentali per favorire una relazione co-intelligente con le macchine, sottolineando l’importanza dell’inclusività, della collaborazione, dell’empatia e dell’adattabilità. Questi principi fungono da guida per sfruttare il potenziale dell’AI tutelando al contempo i valori e l’identità umana. Gran parte dell’attenzione di Mollick è poi rivolta a come l’AI stia cambiando la natura del lavoro e della società. Oggi, infatti, diamo per scontati determinati elementi, come le strutture organizzative, che sono costrutti di epoche passate. Ma non sono l’unico modo di fare le cose. Anzi, sottolinea Mollick, prima di ogni altra cosa l’AI potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui gli esseri umani lavorano. Nel bene e nel male.
Attraversare i confini, Valerio Nicolosi (UTET)
Sin dagli albori dell’umanità, sui confini del mondo si sono scritte storie di sangue e speranza. Mai come oggi, il concetto di “confine” è al centro del dibattito pubblico: da un lato c’è la destra nazionalista, che alza muri; dall’altro, la sinistra sociale che invoca ponti senza riuscire mai ad agire concretamente per costruirli. Questa distinzione politica, in un periodo di crisi economica, sociale e identitaria come quella che stiamo attraversando, potrebbe sembrare secondaria. E invece è il perno su cui si giocano molte delle decisioni che plasmano, nel bene e nel male, le vite di milioni di persone.
Mentre merci, capitali e cittadini in possesso di passaporti privilegiati si muovono senza problemi da una parte all’altra del globo, in nome del profitto e della libertà di movimento, per i poveri, i disperati, i profughi – molti dei quali provenienti dall’Africa e dalle zone più povere dell’Asia – quelle linee sono mura invalicabili. La Fortezza Europa ha spalancato giustamente le porte a donne e bambini vittime della guerra in Ucraina, ma assiste indifferente alla morte di migliaia di persone ogni anno che provano a raggiungerla dalle zone sbagliate del mondo. Le guerre vicine ai confini, com’è forse scontato che sia, accolgono molta più empatia di quelle percepite come lontane. La responsabilità dell’occidente, tuttavia, non è inferiore. Anzi.
Con Attraversare i confini Valerio Nicolosi, reporter romano testimone del dramma della migrazione e della guerra, ci porta sulle rive fangose del fiume che separa Grecia e Turchia, lungo la rotta balcanica, sulle barche che sfidano le onde del Mediterraneo, in un’Ucraina devastata dalla guerra e dietro al muro che imprigiona la Palestina con i suoi decenni di apartheid. Attraverso il suo racconto fatto di nozioni, eventi avvenuti sul campo ed empatia, Nicolosi ci mostra lucidamente il mondo con gli occhi di chi si trova dall’altra parte, di chi è nato, per caso o per destino, sul lato sbagliato della linea.
Orbital, Samantha Harvey (NN Editore)
Orbital, vincitore del Booker Prize all’unanimità, Samantha Harvey compie un piccolo miracolo narrativo. Il romanzo infatti si svolge nell’arco di una sola giornata in un luogo letteralmente sospeso fuori dal mondo, la Stazione Spaziale Internazionale, riuscendo in questo spazio angusto e fuori dal tempo, a raccontare tutta la complessità dell’esistenza umana, in maniera magnetica ed evocativa. Quattro astronauti e due cosmonauti, provenienti da diverse nazioni, orbitano sopra la Terra e, mentre compiono esperimenti scientifici, manutenzioni e osservazioni, sono immersi in riflessioni intime su ciò che hanno lasciato sulla superficie del pianeta: famiglie, relazioni, rimpianti, speranze.
Harvey usa la loro condizione del tutto extra-ordinaria – segnata dalla lontananza fisica, che per una strana dinamica psichica fa sì che si sentano emotivamente molto più prossimi a essa – come una lente d’ingrandimento sulla nostra condizione umana e sul nostro pianeta. In assenza di gravità, ogni gesto si fa diverso, più pensato e pesato, più carico di significato: così anche i pensieri dei protagonisti fluttuano, passando dalla contemplazione del paesaggio terrestre alla memoria di eventi personali dolorosi o felici.
Il tempo in Orbital è scandito dal passaggio sopra diverse parti del mondo: dal Mar Glaciale Artico ai deserti australiani, dalle coste frastagliate dell’America del Sud alle luci pulsanti delle città notturne. Harvey scrive con una prosa poetica ma precisa, capace di restituire sia l’immensità della visione sia il dettaglio minimo, l’attimo privato. Sfida stilistica tutt’altro che scontata. La vita sulla stazione – fatta di piccoli riti, di attese, di piccoli rischi – diventa il riflesso di quella sulla Terra, in un gioco continuo di paralleli, rimandi, cesure e corrispondenze.
In Orbital non ci sono catastrofi imminenti né scoperte sconvolgenti, la tensione narrativa è tutta emotiva, costruita sull’alternarsi dei punti di vista e sull’equilibrio sottile tra il bisogno di connessione e il desiderio di isolamento dei personaggi, e di noi stessi. Alla fine, ciò che resta è una sensazione di struggente bellezza: il pensiero che, da lontano, il nostro pianeta appare fragile, minuscolo e prezioso, e che forse anche i nostri dolori, i nostri errori, i nostri amori – visti da quella distanza – assumono una dimensione e una prospettiva diversa, forse più dolce.
Radical Love, Satish Kumar (Aboca Edizioni)
Viviamo in un’epoca dominata dalla separazione: tra esseri umani, tra noi e la natura, tra mente e corpo. In questo libro Satish Kumar ci invita a riscoprire l’amore come forza rivoluzionaria capace di ricucire queste fratture e distanze. Ex monaco giainista e attivista per la pace, Kumar distilla nel libro una vita di esperienze, proponendo l’amore non solo come sentimento romantico, ma come pratica quotidiana di connessione e responsabilità, forze che davvero muove il sole e le altre stelle.
Kumar ci guida attraverso un percorso che va dall’amore per sé stessi all’amore per gli altri, le altre specie e la Terra. Sottolinea l’importanza di superare l’egoismo e l’individualismo per abbracciare una visione olistica dell’esistenza. L’amore, in questa prospettiva, diventa un atto più che mai politico: scegliere di amare significa infatti opporsi alla cultura del consumo, della competizione, dello sfruttamento e della distruzione dell’ambiente.
Il libro è intriso di saggezza spirituale, ma mantiene un tono accessibile e pratico. Kumar condivide aneddoti personali, riflessioni filosofiche e suggerimenti concreti per coltivare l’amore radicale nella nostra vita quotidiana, invitandoci a rallentare, ad ascoltare, a vivere con attenzione e gratitudine.
Radical Love è un richiamo a riconsiderare le nostre priorità e a costruire un mondo fondato sulla compassione e sull’interconnessione, una lettura che sfida e ispira, offrendo una visione alternativa e profondamente umana del progresso e della felicità.
L'articolo Questa la nostra selezione di libri letti ad aprile 2025 proviene da THE VISION.









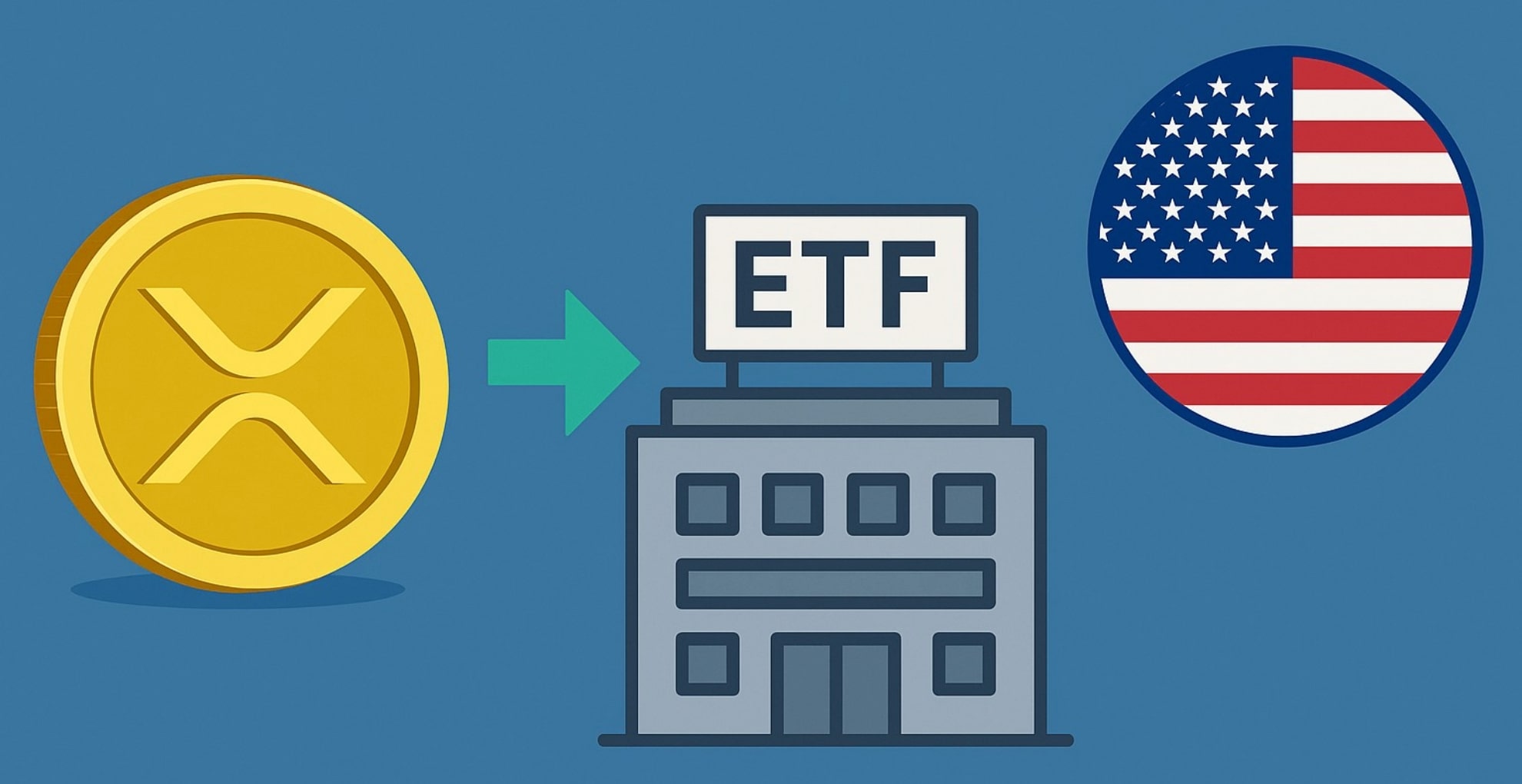















![Frankenstein: un nuovo sguardo a Oscar Isaac nei panni del dottore nel film di Del Toro [FOTO]](https://www.lascimmiapensa.com/wp-content/uploads/2025/04/image-305.png)