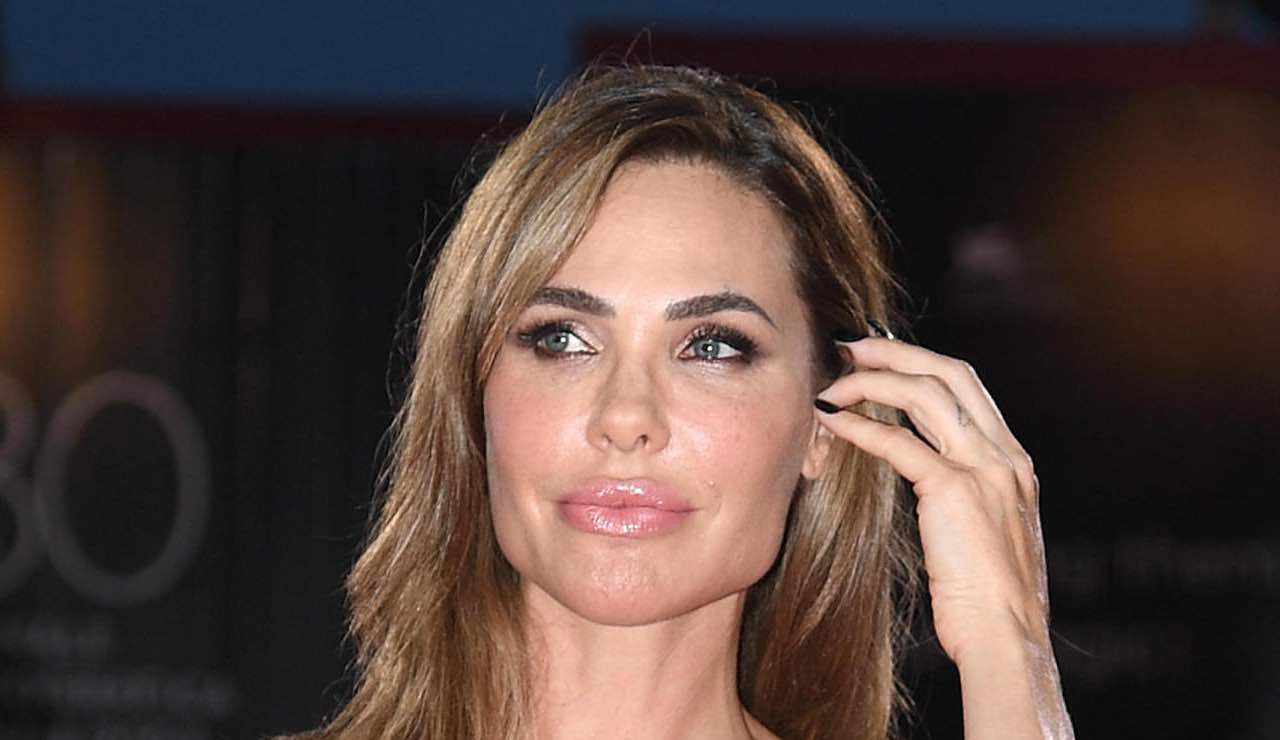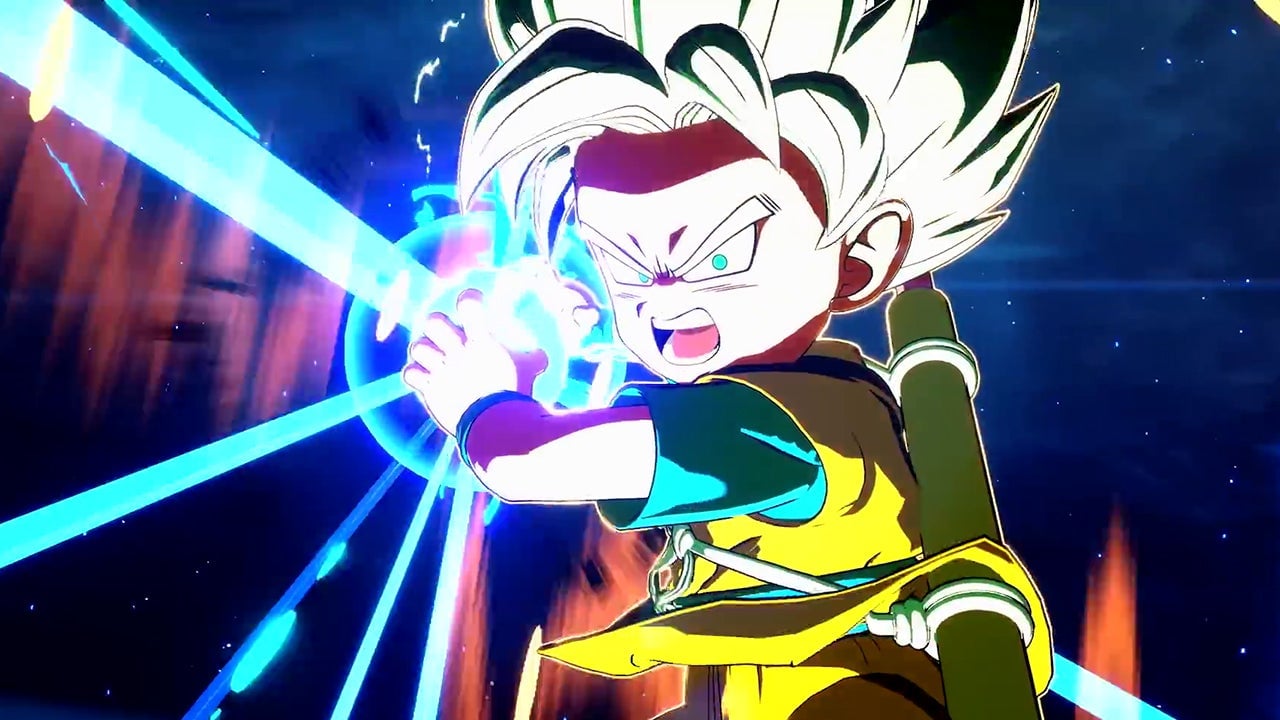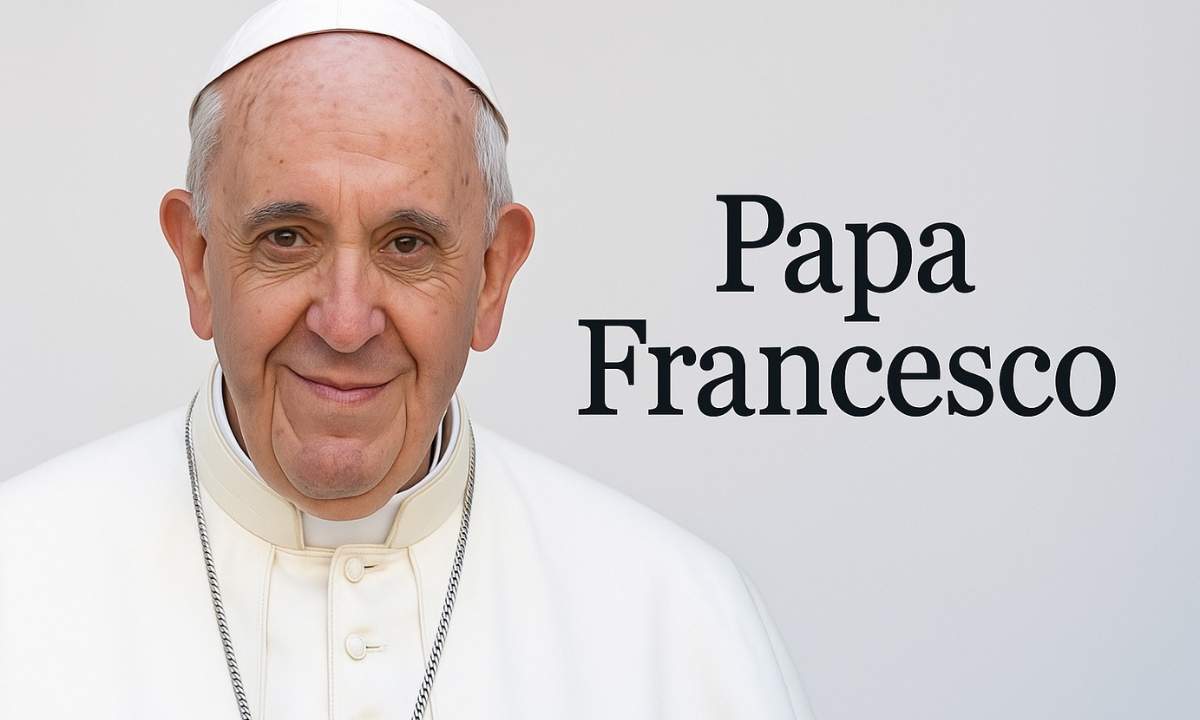Prestazioni accessorie dei soci: come funzionano?
Una delle problematiche gli imprenditori si trovano a dover affrontare riguarda la remunerazione dei soci di SRL che prestano attività per conto della stessa. Senza entrare nel dettaglio della distribuzione di dividendi o del compenso amministratore che non riguardano l’attività lavorativa del socio, le uniche possibilità a disposizione rimangono: In questo articolo andremo ad affrontare […] L'articolo Prestazioni accessorie dei soci: come funzionano? proviene da Fiscomania.

Una delle problematiche gli imprenditori si trovano a dover affrontare riguarda la remunerazione dei soci di SRL che prestano attività per conto della stessa. Senza entrare nel dettaglio della distribuzione di dividendi o del compenso amministratore che non riguardano l’attività lavorativa del socio, le uniche possibilità a disposizione rimangono:
- L’assunzione del socio come lavoratore dipendente. Aspetto questo che può essere possibile solo in determinate circostanze, ovvero solo nel caso in cui il socio sia di minoranza e non abbia una influenza dominante sulle decisioni assembleari. Abbiamo affrontato tale casistica, in dettaglio, in questo articolo: “Socio lavoratore: rischi e vantaggi“;
- L’utilizzo delle prestazioni accessorie. Si tratta di una modalità permessa per remunerare il socio che presta la propria attività lavorativa per conto della società.
In questo articolo andremo ad affrontare la migliore soluzione possibile per regolamentare i compensi da corrispondere ai soci per l’attività lavorativa prestata a favore della propria SRL.
Che cosa sono le prestazioni accessorie e perché possono remunerare i soci di SRL?
Poter regolare l’attività lavorativa del socio di SRL è da sempre un aspetto che riguarda molte SRL, soprattutto a gestione familiare. Per disciplinare questo aspetto è possibile ricorrere alle c.d. “prestazioni accessorie” dei soci. A disciplinare questa fattispecie è l’art. 2345 del codice civile, il quale (per le SPA) prevede quanto segue.
Nonostante la disciplina sia prevista per le SPA e non venga espressamente richiamata per le SRL, i soci possono convenire di obbligare tutti o soltanto alcuni tra essi a eseguire questo tipo di prestazioni verso la società.
Condizioni di applicazione
Secondo quanto previsto dall’art. 2435 c.c. l’atto costitutivo della società deve espressamente prevede, le condizioni, la natura e la portata delle prestazioni che i soci (alcuni o tutti) apportano alla società. In particolare, indicazioni da fornire nell’atto costitutivo sono le seguenti:
- Il contenuto specifico delle prestazioni: quale attività lavorativa andrà ad effettuare il socio per conto della società;
- La durata dell’obbligo: per quanto tempo è prevista l’espletazione dell’attività;
- Le modalità e i termini di esecuzione: deve essere specificato in che modo ed in quali termini avverrà la prestazione;
- Il compenso pattuito: deve essere congruo rispetto alla natura e all’entità delle prestazioni rese e in linea con i valori di mercato per servizi simili. Compensi sproporzionati potrebbero essere interpretati come elusivi;
- Eventuali sanzioni per l’inadempimento: devono essere specificate le sanzioni spettanti in caso di inadempimento dell’obbligazione.
Questa soluzione permette di regolare statutariamente gli obblighi dei singoli soci, vincolandoli allo svolgimento di specifiche prestazioni a favore della società con in cambio una remunerazione correlata alle attività effettivamente svolte.
Pertanto, possiamo dire che la prestazione accessoria può essere una valida modalità per andare a remunerare l’attività lavorativa del socio di SRL. Aspetto fondamentale è quello formale che richiede l’indicazione precisa di tutti gli aspetti inerenti l’attività lavorativa.
Previsione anche fuori dall’atto costitutivo
La clausola relativa alle prestazioni accessorie può essere introdotta anche successivamente alla costituzione della società. Secondo la giurisprudenza, tali prestazioni possono essere introdotte con un atto diverso dall’atto costitutivo, successivamente alla data di costituzione della società (Cassazione civile, 5 luglio 1978 sentenza n. 3319; Tribunale di Milano 17 aprile 1982). Il riferimento è ad una specifica delibera assembleare. In ogni caso debbono risultare con chiarezza contenuto, durata, modalità e compenso delle prestazioni in parola e le relative sanzioni in caso di inadempimento.
Nonostante quanto indicato dalla giurisprudenza, l’Amministrazione finanziaria non sembra essere dello stesso avviso. Questa, infatti, nella Risoluzione n. 81/E/2002 afferma che l’obbligazione derivante dalle prestazioni accessorie ha natura propriamente sociale, con tutte le conseguenze tipicamente societarie, con la conclusione che si ritiene che il rapporto (tra società e socio) non possa essere istituito al di fuori dei documenti tipicamente regolatori della vita associativa.
Divieto di erogazione di denaro
Per quanto attiene al contenuto della prestazione, la stessa deve ritenersi liberamente configurabile dalle parti, con la sola eccezione del divieto di erogazione di denaro. Tale previsione deriva dal fatto che l’accessorietà delle prestazioni deve intendersi aggiuntiva rispetto al conferimento (che solitamente viene fatto in denaro). Tuttavia, su questo punto occorre effettuare qualche precisazione.
Non devono considerarsi in denaro le prestazioni di garanzia da parte dei soci in favore dei terzi creditori dell’ente, che dunque ben possono rientrare tra le prestazioni accessorie. In via generale, si può affermare che rientra nella previsione di cui all’articolo 2345 del Codice qualsiasi tipologia di utilità, materiale o immateriale fruibile dalla società, comprese prestazioni del tutto occasionali, sempre con l’eccezione sopra ricordata delle dazioni dirette di denaro.
Disciplina fiscale
Il compenso per l’attività lavorativa del socio attraverso le prestazioni accessorie è soggetto all’ordinaria tassazione IRPEF legata al percepimento di redditi da lavoro dipendente. In particolare, si tratta di redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, ex art. 50, co. 1, lett. c-bis) del TUIR (vedasi la risoluzione n. 81/E/2002 dell’Agenzia delle Entrate). La particolarità del rapporto sottostante la prestazione fa sì che questa non possa qualificarsi come prestazione derivante da contratto di lavoro subordinato ma piuttosto come un’obbligazione sociale prevista dallo statuto il cui compenso viene pattuito nel rispetto del criterio civilistico. La norma, però, precisa che non deve trattasi di attività rientranti nell’oggetto dell’arte o professione eventualmente esercitata dallo stesso prestatore perché, in tal caso, il relativo reddito assumerebbe, per attrazione, la natura di reddito di lavoro autonomo professionale e sarebbe disciplinato secondo le relative regole.
Sul piano fiscale, deve essere ammessa la deducibilità dal reddito d’impresa (ex art. 109 del TUIR) di tali particolari oneri, pur derivanti da obblighi assunti in qualità di socio, in quanto le prestazioni rese sono strettamente inerenti allo svolgimento dell’attività di impresa. Tali compensi, quindi, rappresentano dei costi deducibili dal reddito di impresa, ai fini IRES, della società. Tali oneri, rientrano, comunque, all’interno della base imponibile IRAP.
Disciplina previdenziale
Per quanto riguarda profili contributivi collegati alle prestazioni accessorie, la tesi circa la loro non assoggettabilità alla Gestione separata ex art. 2, co. 26 della Legge n. 335/95 nell’ambito delle STP (e per analogia le SRL) può essere sostenuta in base al combinato disposto di due interventi di prassi, ossia la Risoluzione Agenzia Entrate 11.3.2002 n. 81 e la circ. INPS 9.3.2018 n. 45.
Con il primo intervento, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che i compensi erogati ai soci d’impresa per prestazioni lavorative di carattere accessorio costituiscono, da un lato, reddito di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 50 co. 1, lett. c- bis ) del TUIR (in generale, reddito assimilato a quello di lavoro dipendente) per il socio e, nel contempo, costi deducibili dal reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 109 del TUIR, per la società erogante.
Successivamente, l’INPS, con la circ. 9.3.2018 n. 45 (§ 4), intervenendo in materia di contribuzione indebitamente versata alla Gestione separata, ha chiarito che i professionisti che esercitano l’attività per il cui esercizio è obbligatoria l’iscrizione agli Albi professionali e, conseguentemente alle relative Casse previdenziali private di cui ai D.Lgs. n.509/94 e n. 103/96, come nel caso delle STP, sono tenuti a versare la contribuzione alla propria Cassa anche nel caso di reddito prodotto ai sensi dell’art. 50 co. 1, lett. c- bis ) del TUIR o eventuali ulteriori redditi, come nel caso delle prestazioni accessorie, così come ricondotte nell’alveo dei redditi assimilati a quello di lavoro dipendente dalla citata risoluzione dell’Agenzia delle Entrate.
Di fatto, l’INPS permette al socio di essere remunerato, senza dover versare contributi previdenziali alla gestione separata INPS, nel momento in cui viene il reddito viene attratto alla contribuzione presso la gestione previdenziale di appartenenza, come nel caso della gestione artigiani o commercianti INPS o nel caso in cui il socio sia iscritto ad una propria cassa previdenziale autonoma (caso dei soci che operano a favore di una STP).
Pianificazione preventiva e valutazioni
Come abbiamo visto, la natura delle prestazioni lavorative da parte dei soci per la società, ha natura pattizia e per l’Amministrazione finanziaria deve essere un’indicazione ricavabile dall’atto costitutivo della società. Tuttavia, l’utilizzo di questo strumento deve essere attentamente valutato in modo tale da evitare possibili situazioni di contestazione.
Le problematiche maggiori si riscontrano soprattutto nelle SRL a ristretta base societaria dove, spesso, la figura del socio è anche quella dell’amministratore. Quando le due posizioni si confondono, l’applicazione delle prestazioni accessorie non è sempre agevole. Infatti, questo tipo di compensi sono sostenibili fiscalmente, solo a condizione che siano reali e congrue nell’ammontare. Inoltre, l’attività svolta deve essere realmente distinta rispetto all’attività di amministrazione. La coesistenza del ruolo di socio prestatore d’opera accessoria e di amministratore richiede particolare attenzione per evitare contestazioni sulla natura dei compensi.
Infatti, è cruciale che le prestazioni accessorie siano effettivamente diverse e distinguibili dalle mansioni tipiche della carica di amministratore. Se le prestazioni accessorie si sovrappongono o coincidono sostanzialmente con l’attività di gestione e amministrazione, l’Agenzia delle Entrate potrebbe riqualificare tali compensi come emolumenti per amministratore o, nel peggiore dei casi, come distribuzione occulta di utili.
Conclusioni e consulenza online
Le prestazioni accessorie rappresentano una valida opportunità per la remunerazione delle attività prestate dai soci a favore della società. Si tratta di una delle modalità con le quali la SRL può erogare compensi ai propri soci, tuttavia, è necessario che vengano rispettati precisi formalismi per l’applicazione di questo istituto. In particolare, il fatto che le stesse debbano essere indicate in atto costitutivo ne limita l’applicazione, tuttavia la giurisprudenza ha aperto anche all’istituzione dello strumento con delibera assembleare, anche se l’Agenzia delle Entrate non pare essere dello stesso avviso (almeno nei suoi documenti). In ogni caso se desideri approfondire questo tema contattaci per ricevere una consulenza personalizzata.
L'articolo Prestazioni accessorie dei soci: come funzionano? proviene da Fiscomania.