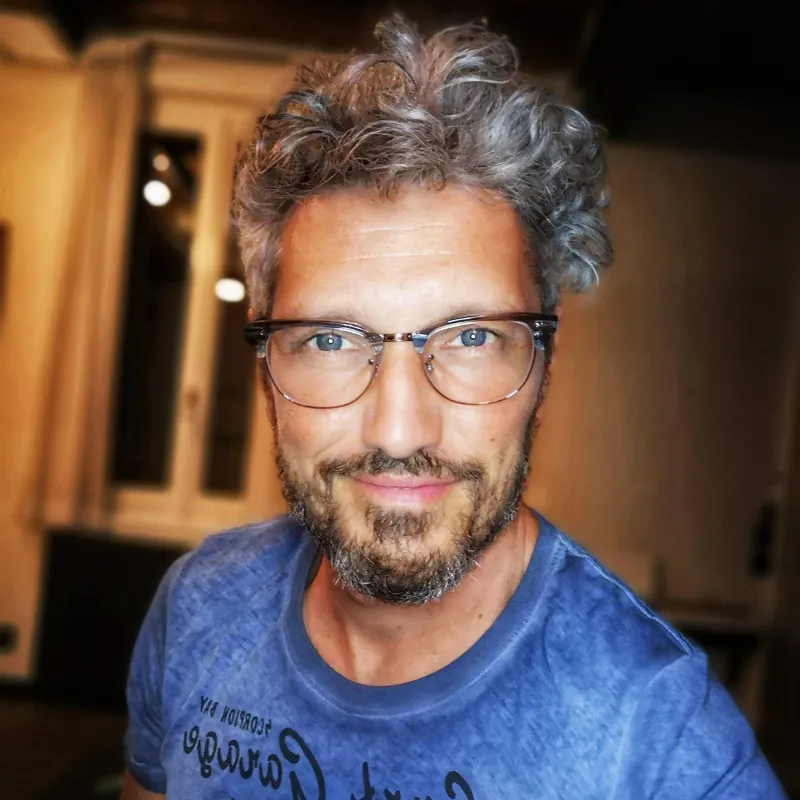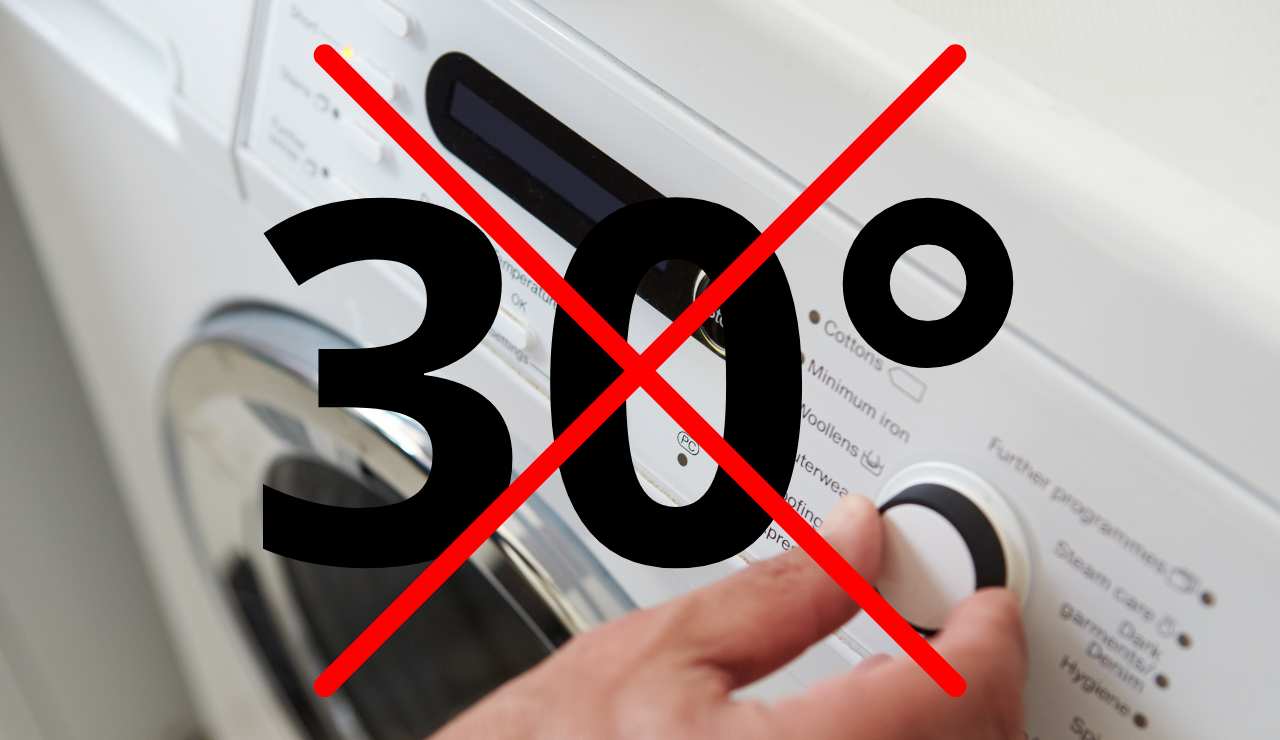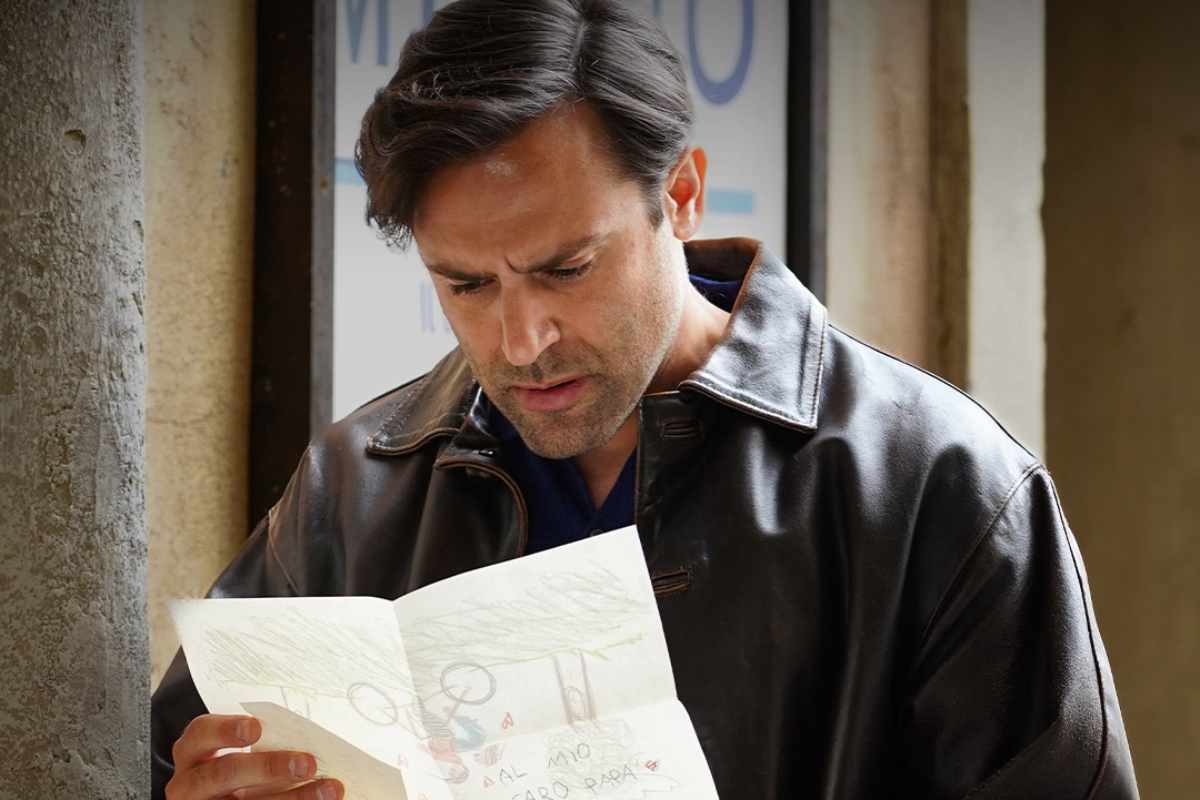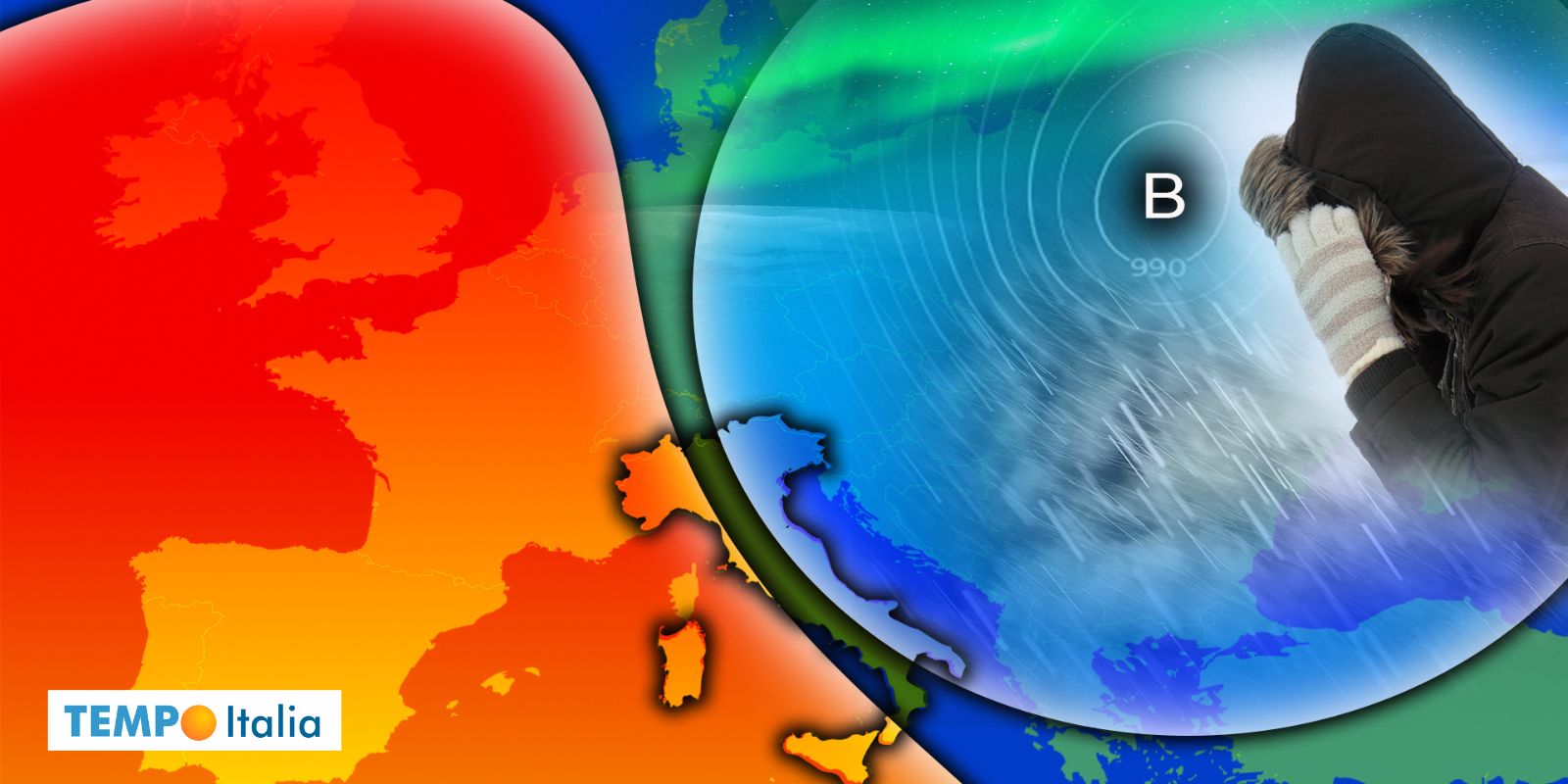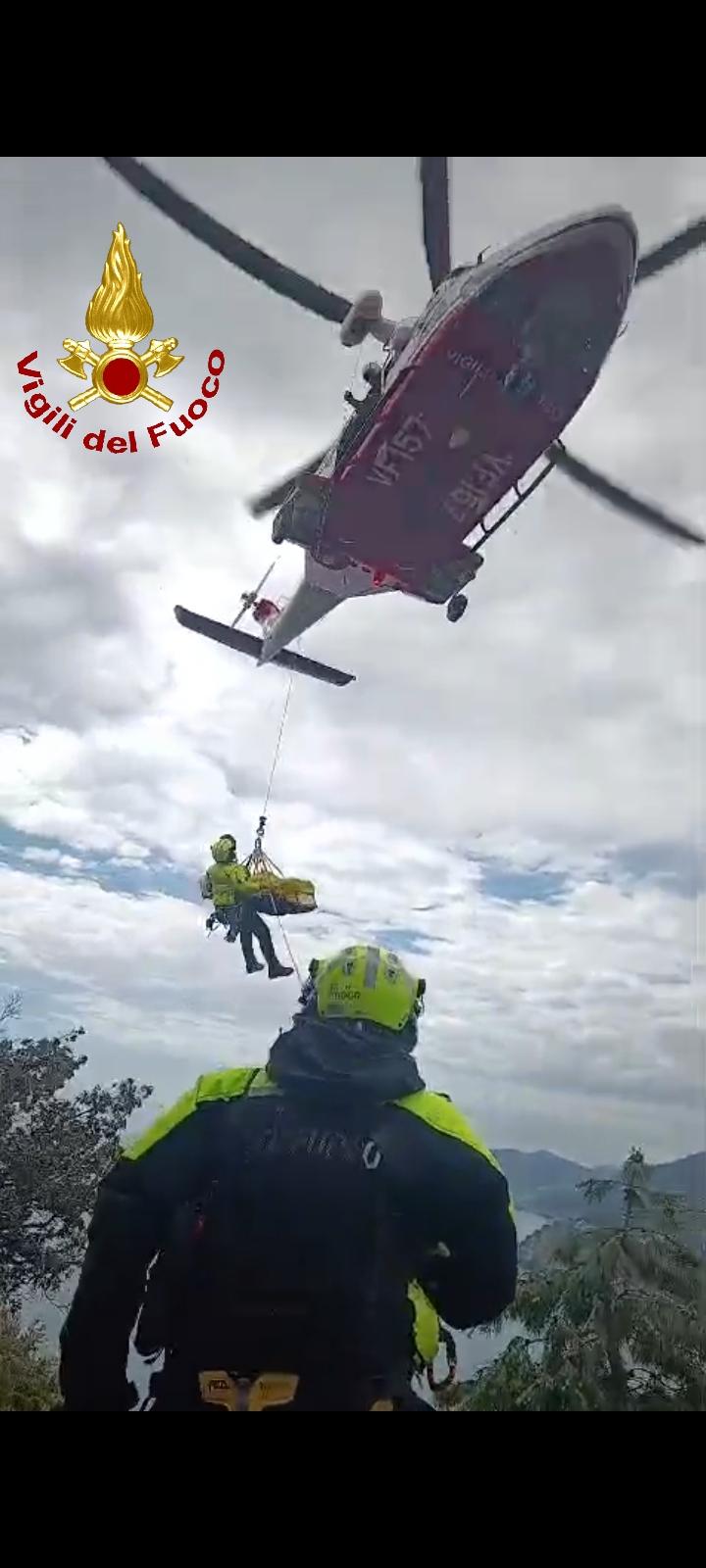Perché la Liberazione è stata il 25 aprile: l’insurrezione contro il nazifascismo “ritardata” anche dalle pressioni degli angloamericani
Il 25 aprile inizia il 24. Niguarda, quartiere operaio a Nord di Milano, alza le barricate, requisisce edifici e armi ai fascisti e si libera prima del resto della città che da incubatrice del regime è diventata capitale della Resistenza. Il 25 aprile comincia il 23: Genova lancia la sua ultima battaglia e diventa l’unica […] L'articolo Perché la Liberazione è stata il 25 aprile: l’insurrezione contro il nazifascismo “ritardata” anche dalle pressioni degli angloamericani proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il 25 aprile inizia il 24. Niguarda, quartiere operaio a Nord di Milano, alza le barricate, requisisce edifici e armi ai fascisti e si libera prima del resto della città che da incubatrice del regime è diventata capitale della Resistenza. Il 25 aprile comincia il 23: Genova lancia la sua ultima battaglia e diventa l’unica città d’Europa a costringere alla resa un comando tedesco senza l’intervento degli eserciti alleati. L’alba del 25 aprile è il 20 quando i nazisti scappano da Bologna, seguiti come per abitudine dai fascisti, dopo 12 giorni di combattimenti: dopo poche ore sfilano gli uomini della Resistenza, reparti polacchi, carri armati americani. Il 25 aprile si trova già nel giorno 4 quando per la prima volta compare in un documento del comando militare che guida le formazioni partigiane il proclama inchiodato alla parete dalla Storia dalla voce di Sandro Pertini: “Una sola via di scampo e di salvezza resta ancora a quanti hanno tradito la patria, servito i tedeschi, sostenuto il fascismo: arrendersi o perire!”. Il 25 aprile è nascosto negli scioperi degli ultimi mesi – sempre più frequenti, sempre più partecipati – di operai, impiegati, macchinisti a Milano, Genova, Torino: fabbriche, tram, treni, poste, uffici comunali. Il 28 marzo a Milano si fermano 104 aziende è la prova generale.
L’insurrezione è il 25 aprile, è la Liberazione: l’ora o mai più, l’attacco finale, la resa dei conti, l’ultima spallata ai nazisti in fuga, il colpo di grazia al fascismo. E’ un momento più volte immaginato, nominato, desiderato, organizzato e riaggiornato dai vertici della Resistenza durante gli ultimi mesi della guerra partigiana. È data a lungo per imminente eppure non arriva, è quasi un assillo che i partigiani si portano dietro per settimane, in bilico tra l’ansia dell’atto liberatorio che metta fine alle sopraffazioni del regime e alle schifezze della guerra in cui Mussolini ha gettato l’Italia e, dall’altra parte, la necessità vitale di non farlo né troppo presto né troppo tardi. “La posta in gioco è ‘l’insurrezione perfetta‘ – scrive lo storico Carlo Greppi – E’ troppo alto il rischio che, nella fuga, i nazifascisti lascino una scia di sangue alle loro spalle. E si vuole provare a mettere gli Alleati di fronte al dato di fatto: l’Italia del Nord si libera da sola”. Sarà così: “Quando gli Alleati sono arrivati nel nostro Paese e nelle città hanno trovato i vigili che davano la strada ai carri armati poiché le città italiane erano state liberate dagli italiani” scrive Ferruccio Parri, leader della Resistenza, capo del Partito d’Azione, primo presidente del Consiglio dell’Italia liberata. Secondo la storia ufficiale delle operazioni alleate nell’ultimo mese di guerra i partigiani liberano “con le loro forze” 125 città, obbligano ad arrendersi oltre 80mila tedeschi, ne uccidono circa 3mila.
E’ l’ora del riscatto, anche morale, dopo gli oltre vent’anni che identificano l’Italia con le brutture della dittatura, del Duce e dei suoi complici. La Liberazione prima dell’arrivo delle truppe alleate è ritenuta indispensabile da tutti i partiti che costituiscono il Cln Alta Italia, dai comunisti ai democristiani. Quando nelle sue memorie Achille Marazza, il delegato della Dc, ne illustra le ragioni, sembra che parli di un groviglio di cavi di un esplosivo, per il cui disinnesco sono necessarie in misura equivalente coraggio e cautela: per evitare altre rappresaglie ed altri saccheggi dei nazisti, per “assicurare ai partigiani italiani, e per essi all’Italia, i riconoscimenti e il prestigio di cui avremmo avuto un così amaro bisogno al tavolo della pace”, per “dimostrare agli Alleati che il Paese era pronto a governarsi da sé”. Ha l’apparenza di un orgoglio velleitario dopo la vergogna eterna del fascismo. Eppure starà al centro di quella convinzione dei capi della Resistenza l’attestato con il quale la nuova classe dirigente italiana potrà di lì a poco – le macerie fuori riempiono ancora le strade – scrivere la Costituzione in autonomia a differenza della Germania, sottoposta a una umiliante bollinatura del testo da parte delle forze alleate.
Insurrezione significa requisire caserme, espugnare edifici pubblici, disarmare i fascisti, mettere in fuga i tedeschi e soprattutto occupare fabbriche. Non è solo un fatto di “riconquista”: il timore che resta lungo l’intera, lunga, lenta ritirata è che i tedeschi facciano saltare impianti produttivi, infrastrutture, centrali energetiche e il pensiero degli italiani che combattono per la Liberazione è già alla vita di dopo.
L’ultimo tratto che porta incontro alla Liberazione ha l’andatura di una locomotiva: servirà tempo prima che sia lanciata a tutta velocità verso il 25 aprile. L’avanzata degli Alleati incontro alla Linea Gotica – da Massa a Fano – sul finire del 1944 si è trasformata in una distesa di sabbie mobili. La risalita si ferma fuori Bologna, lungo le sponde del Senio, sbarrata anche dalla brutta stagione. Questo dilata i tempi della bolla di clandestinità in cui hanno racchiuso le proprie vite i partigiani da più di un anno: la vita aspra sulle montagne, pasti improvvisati, giacigli di fortuna, l’ansia per le imboscate ai fascisti, lettere scritte di nascosto, nomi falsi, alloggi cambiati di continuo, cespugli di delatori, un disco con le canzoni del regime a tutto volume per ingannare i vicini, le risposte cucite giuste negli interrogatori, gli arresti scampati, il cuore in gola, gli sguardi per strada per riconoscersi, gli abbigliamenti incongrui per fingere un’altra esistenza, un paio di baffi ossigenati. Pensare, comunicare, vivere è solo di nascosto, in segreto, fuori legge, da individui al bando e lontano da padri, madri, mogli, figli, amici. “Capisco che la mia esistenza personale è finita – fa dire Nicoletta Verna alla partigiana Iris ne I giorni di Vetro – Adesso vivo per qualcosa che non è più mio ma è di tutti, e però nell’essere di tutti cessa di appartenermi. Va bene così, è la scelta che ho compiuto già da anni insieme a Diaz. Mi piace avere preso posizione. Ha a che vedere con il futuro, forse persino con quella che qualcuno chiama fede”.
La guerriglia delle formazioni partigiane fa impazzire i nazisti. Nell’ottobre 1944, dopo un anno di occupazione, il generale Albert Kesselring, comandante di tutte le forze tedesche in Italia, al quale è dedicato il celebre componimento di Piero Calamandrei, scrive stizzito: “L’attività delle bande nel settore italiano è negli ultimi tempi costantemente aumentata. (…) Il traffico dei rifornimenti è fortemente ostacolato. Gli atti di sabotaggio crescono. Ci si deve opporre con tutti i mezzi a disposizione a tale peste”. E’ una guerra senza fronte: quello che possono fare i partigiani è rendere la vita dei tedeschi quasi un gioco d’azzardo: imboccare la strada sbagliata a un bivio e un braccio, una gamba, magari il cranio di una manciata di soldati finiscono sgretolate come le sicurezze di un’armata, perfino votata alla morte come quella hitleriana. “I servizi resi dai partigiani furono molti e molto importanti, compresa l’occupazione di parecchie città e di parecchi villaggi” scriverà il generale statunitense Mark Clark.
Proprio quando arriva il 1945 – che a vederlo da qui ha sempre il suono e il colore della rinascita – l’insurrezione è così vicina ma resta così lontana. Gli angloamericani sono paralizzati dietro la Linea Gotica e ora il movimento partigiano è sul punto di finire decapitato. Il 2 gennaio viene arrestato Ferruccio Parri, l’irriducibile antifascista, l’amico fraterno di Carlo e Nello Rosselli, martiri di Mussolini. Tra i partigiani si fa chiamare Maurizio, molti lo chiamano “lo Zio”, in questo momento a Milano è il “professor Pasolini”. Ha cambiato 4 abitazioni, è scampato all’arresto almeno tre volte: non è bastato, non basta mai. Viene portato via sostanzialmente per un caso: le SS sono nel palazzo in cui è rifugiato per perquisire la casa del piano di sopra. Quel giorno è l’anniversario del matrimonio con Ester. È con la moglie che viene caricato e portato a San Vittore: la polizia nazista lo interroga, lo picchia a sangue, ma non sa chi è. “Entrambi mi colpiscono a gara con gli scarponi chiodati mentre afferrandomi per i capelli cercano di farmi inginocchiare. Poiché resisto, mi trascinano di peso per un lungo corridoio che porta ai sotterranei”. Ha quasi 55 anni. Resiste alle botte, viene trasferito (incredibilmente in tram) all’Albergo Regina, comando della polizia nazista a Milano. E’ qui che un agente fascista riconosce Parri, l’irriducibile: lo ha già arrestato nel 1942, nella sua casa di via Vincenzo Monti, per delle cose che aveva scritto. “Ha la memoria buona questo cane, e cita particolari su particolari”. Maurizio si ritrova davanti Theodor Saevecke, il boia di piazzale Loreto, l’ufficiale delle SS che il 10 agosto 1944 per rappresaglia ha fatto fucilare 15 prigionieri e ha ordinato di lasciarli esposti in strada per ventiquattro ore. Paradossalmente per Parri finire di fronte al nazista assetato di sangue è la salvezza perché un prigioniero di tale valuta ha le fattezze di una contropartita: sta per cominciare l’operazione Sunrise, la trattativa separata tra il comandante tedesco in Italia Karl Wolff e la spia americana Allen Dulles: Hitler e Mussolini ne sono all’oscuro.
Da alcuni mesi il Corpo volontari della libertà, cioè la struttura militare delle formazioni partigiane, ha un comandante e due vice. Un vice, Parri, è appena finito in galera. Il comandante, Raffaele Cadorna, nome di battaglia Valenti, dà le dimissioni a febbraio. Per essere qui ad agosto si è lanciato con i suoi 55 anni e un paracadute da un quadrimotore britannico passato sopra la Val Cavallina, atterrando a Ranzanico, sulle Prealpi della Bergamasca. Porta quel cognome famoso in tutte le piazze d’Italia perché è figlio del generale di Caporetto, Luigi, e nipote del generale – suo omonimo – che guidò la Breccia di Porta Pia. Un militare di carriera, conservatore, che ha sempre detestato il fascismo. Ma ora, a febbraio del 1945, proprio mentre nell’aria c’è profumo di resa dei conti, vuole mollare il comando militare della Resistenza. Il motivo a raccontarlo pare una sciocchezza eppure svela la delicatezza dei rapporti tra le diverse anime della lotta partigiana, diventate una sola. E’ andata così: il delegato del Partito d’Azione Fermo Solari – nome di battaglia Somma, imprenditore originario della Carnia – propone un ufficio operazioni, Cadorna respinge la proposta, Somma rilancia, Cadorna lo interrompe, “qui presiedo io!”, “tu non presiedi un cazzo!”. “Posso dire che fu l’unica volta che pronunciai questa parola” disse col candore degli uomini d’altri tempi il friulano Solari. “Sfuriata, pugni sul tavolo, presa di cappello, con tutto il resto” testimonia Luigi Longo, comunista, l’altro vice di Cadorna, il comandante Gallo. Cadorna non ha intenzione di andarsene per darsi alla macchia: da tempo ha in testa che se questa cosa del comando militare delle formazioni partigiane non dovrà funzionare, si ritirerà in montagna in Piemonte per combattere in qualche brigata. Per convincerlo a tornare al suo posto serviranno tutte le abilità diplomatiche di Leo Valiani, membro azionista nel Cln Alta Italia. Cadorna e Parri – rilasciato nel frattempo dai tedeschi come prova di “buona condotta” a beneficio dei negoziati separati – andranno insieme a Caserta alla fine di marzo per concordare con gli Alleati e il governo provvisorio di Roma i termini della battaglia finale al Nord. Insieme a Luigi Longo apriranno il 6 maggio la “parata della Vittoria”, uno dei tanti cortei di partigiani che attraverseranno Milano dopo la Liberazione.

Eppure l’insurrezione resta qui davanti, ha contorni chiari, ma non è ancora il suo tempo. Il pantano della Linea Gotica, la dirigenza partigiana falcidiata dagli arresti e le pressioni dei comandi militari degli Alleati. Gli americani e ancora di più gli inglesi non si fidano della parola insurrezione, così simile a rivoluzione, sostenuta nella gran parte da combattenti comunisti, socialisti, liberalsocialisti. Va bene la guerriglia partigiana che spiana la strada, ma una legittimità politica, quello no.
Già a novembre del 1944 il generale londinese Harold Alexander, comandante in capo in Italia, invia un proclama alle formazioni partigiane ordinando di “cessare le operazioni organizzate su vasta scala”: “Tenersi pronti a nuovi ordini”. Sembra quasi la liquidazione della Resistenza. “Semina il panico – sottolinea Greppi in 25 aprile 1945 – tra i combattenti falcidiati dai rastrellamenti nazifascisti e dal freddo in arrivo: obbedire significa avere un alto tasso di probabilità di essere catturati e giustiziati”. Il Cln Alta Italia risponde con un’interpretazione, per iscritto, inviata a tutte le sedi periferiche: si dice che si deve prevedere “non una contrazione, non un indebolimento della lotta partigiana, bensì la sua intensificazione e l’allargamento delle formazioni armate”. “Non possiamo dire ai patrioti che da un anno si battono contro i nazifascisti, non possiamo dire a nessuno che abbia imbracciato le armi per liberare il suolo della patria: adesso vattene a casa, noi ci disinteressiamo di te”.
Ci si metterà anche il governo di Ivanoe Bonomi, l’esecutivo nominato da Umberto di Savoia, in quel momento luogotenente del Regno. Il presidente del Consiglio invia il sottosegretario Aldobrando Medici Tornaquinci, liberale fiorentino, a Milano con la missione di far accettare il disarmo dei partigiani e la dismissione del Cln. Alla fine tornerà indietro con un documento che darà ai combattenti della Resistenza il compito di proteggere le fabbriche ma anche “attaccare i tedeschi e i fascisti, scatenando un’insurrezione antitedesca e antifascista”.
Clark ci riprova nelle ultime settimane di guerra. A fine marzo, nelle stesse ore in cui due leader militari della Resistenza (Cadorna e Parri) a Caserta stanno per concordare la linea per l’attacco finale al nazifascismo, il generale americano invia un lungo messaggio pieno di felicitazioni per i risultati ottenuti al Nord ma aggiunge: “Non intraprendere azioni in grande stile fino a che questo quartier generale non lo dirà”. I capi della guerra partigiana non solo non lo ascolteranno, ma rilanceranno con varie comunicazioni ai comandi periferici. Dopo una settimana fa il suo ingresso nei libri di Storia l’espressione “Arrendersi o perire”: si trova in un proclama del Corpo dei volontari per la libertà, “l’esercito” dei partigiani. Un’altra settimana e una direttiva del Pci, firmata da Longo, ribadisce: “L’ora dell’attacco finale è scoccata (…). Anche noi dobbiamo scatenare l’assalto definitivo. Non si tratta più solo di intensificare la guerriglia, ma di predisporre e scatenare vere e proprie azioni insurrezionali”. Poche righe più oltre ne spiega meglio il senso: “Ogni episodio di lotta sarà stimolo ad altre masse per scendere in campo; l’estendersi della lotta disperderà le forze della reazione, le demoralizzerà, dando loro la sensazione che ormai è tutto il popolo che in ogni località attacca e vuole farla finita”.
A Genova il piano di insurrezione è pronto da mesi, ma gli inglesi quando lo leggono lo bocciano come una maestra delle elementari fa con un compito in classe, con tanto di segni sugli errori, sui passaggi da modificare. Non danno l’autorizzazione a entrare in città: vogliono essere loro a dare il colpo finale ai nazifascisti. “Non avete passato per niente tante ore con noi – risponderà Amino Pizzorno, “Attilio”, un commissario ligure del Cln – Voi ci conoscete e lo sapete bene”: niente di esplicito eppure per gli inglesi il significato è lampante. Il 13 aprile, tre giorni dopo, il generale Clark insiste un’altra volta, chissà se l’ultima: “Voi siete preparati a combattere, ma il momento della vostra concertata azione non è ancora giunto (…). Non fate il giuoco del nemico agendo prima del tempo scelto per voi. Non sperperate la vostra forza. Non lasciatevi tentare ad agire prematuramente”. Il 16 Cadorna, Parri e Longo firmano una circolare inviata ai comandi regionali, a Milano, in Valsesia, nell’Ossola: “L’insurrezione nazionale dovrà essere un’azione disciplinata per assicurarne il successo e per dimostrare la forza e la capacità del movimento patriottico”. Non è più nemmeno se, ma ormai è solo questione di come. Gli italiani sono pronti a liberarsi da soli.
Fonti
25 aprile 1945, Carlo Greppi, Laterza
Storia della Resistenza, Marcello Flores e Mimmo Franzinelli, Laterza
Anche i partigiani però…, Chiara Colombini, Laterza
Due mesi con i nazisti, di Ferruccio Parri
La Resistenza in Lombardia. Lezioni tenute nella Sala dei Congressi della Provincia di Milano (1965), Achille Marazza, Labor
L'articolo Perché la Liberazione è stata il 25 aprile: l’insurrezione contro il nazifascismo “ritardata” anche dalle pressioni degli angloamericani proviene da Il Fatto Quotidiano.