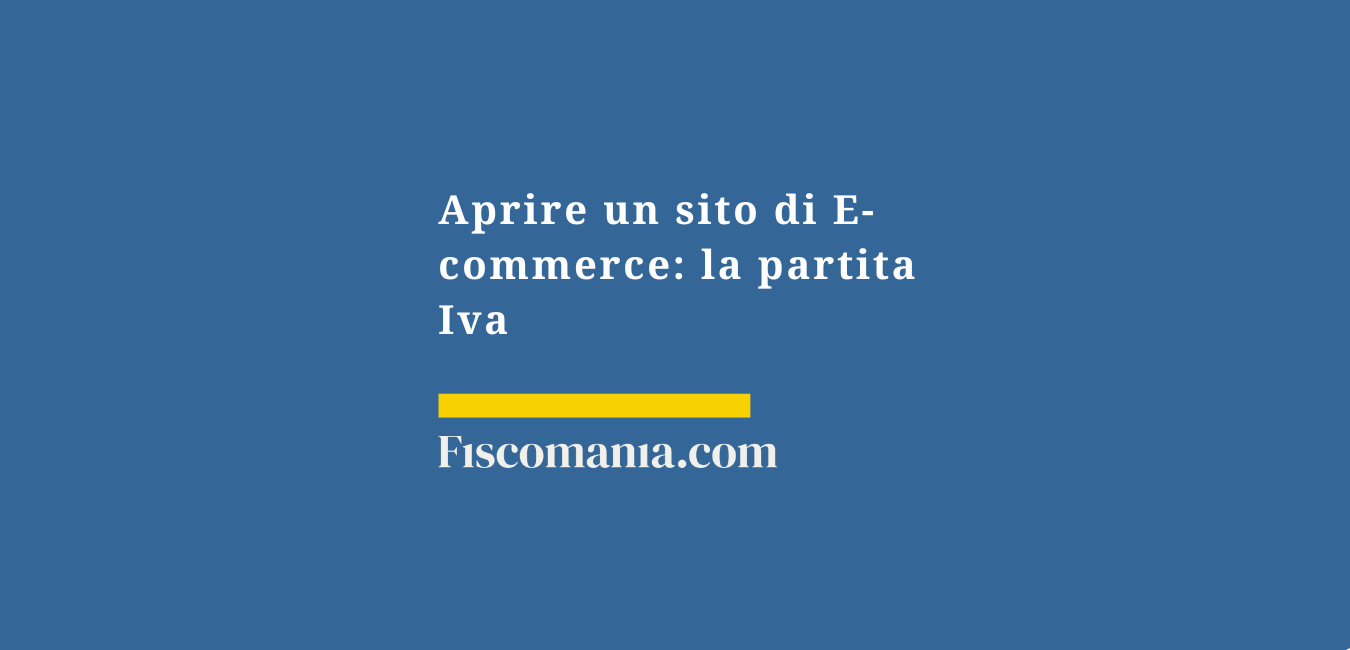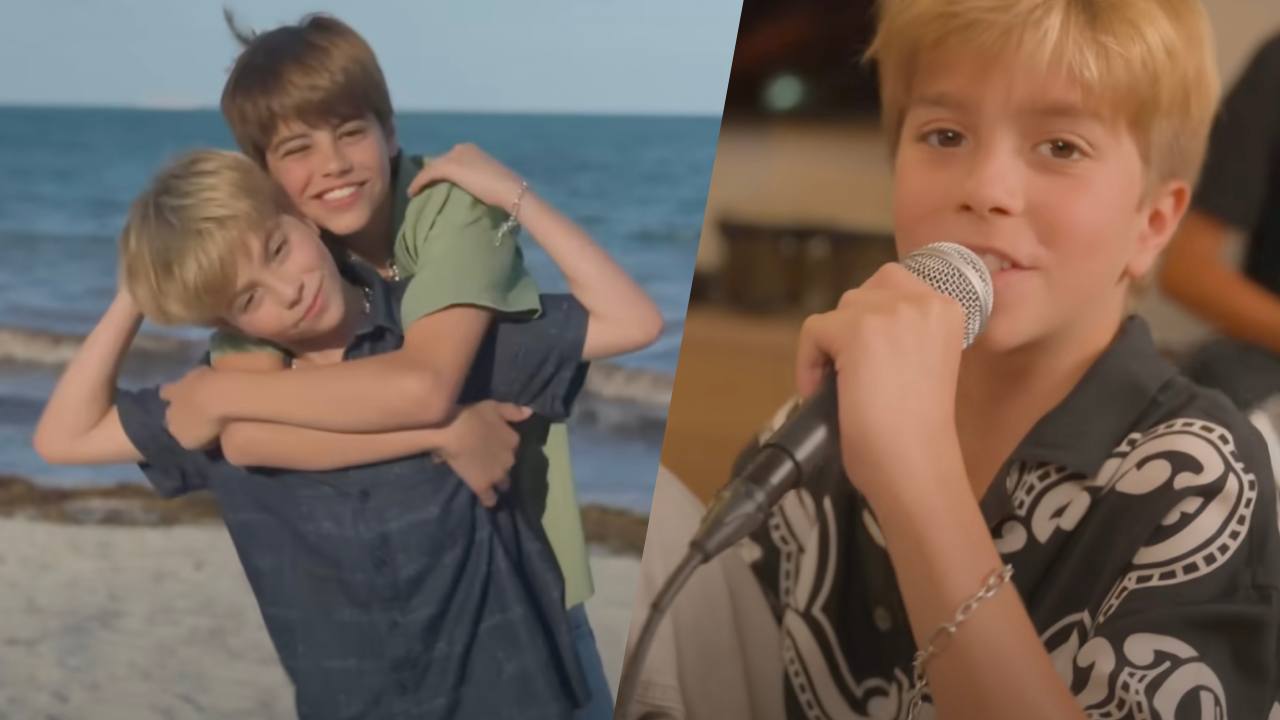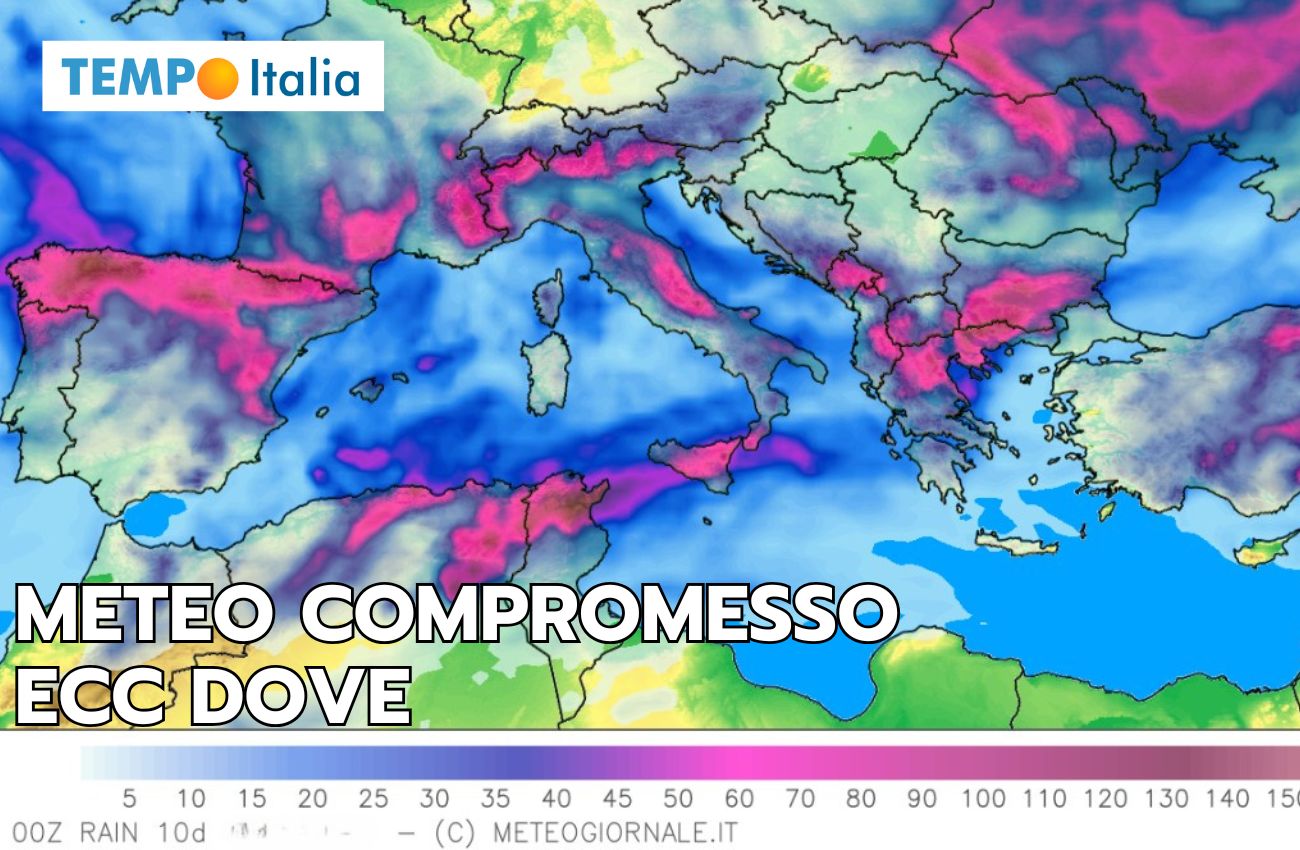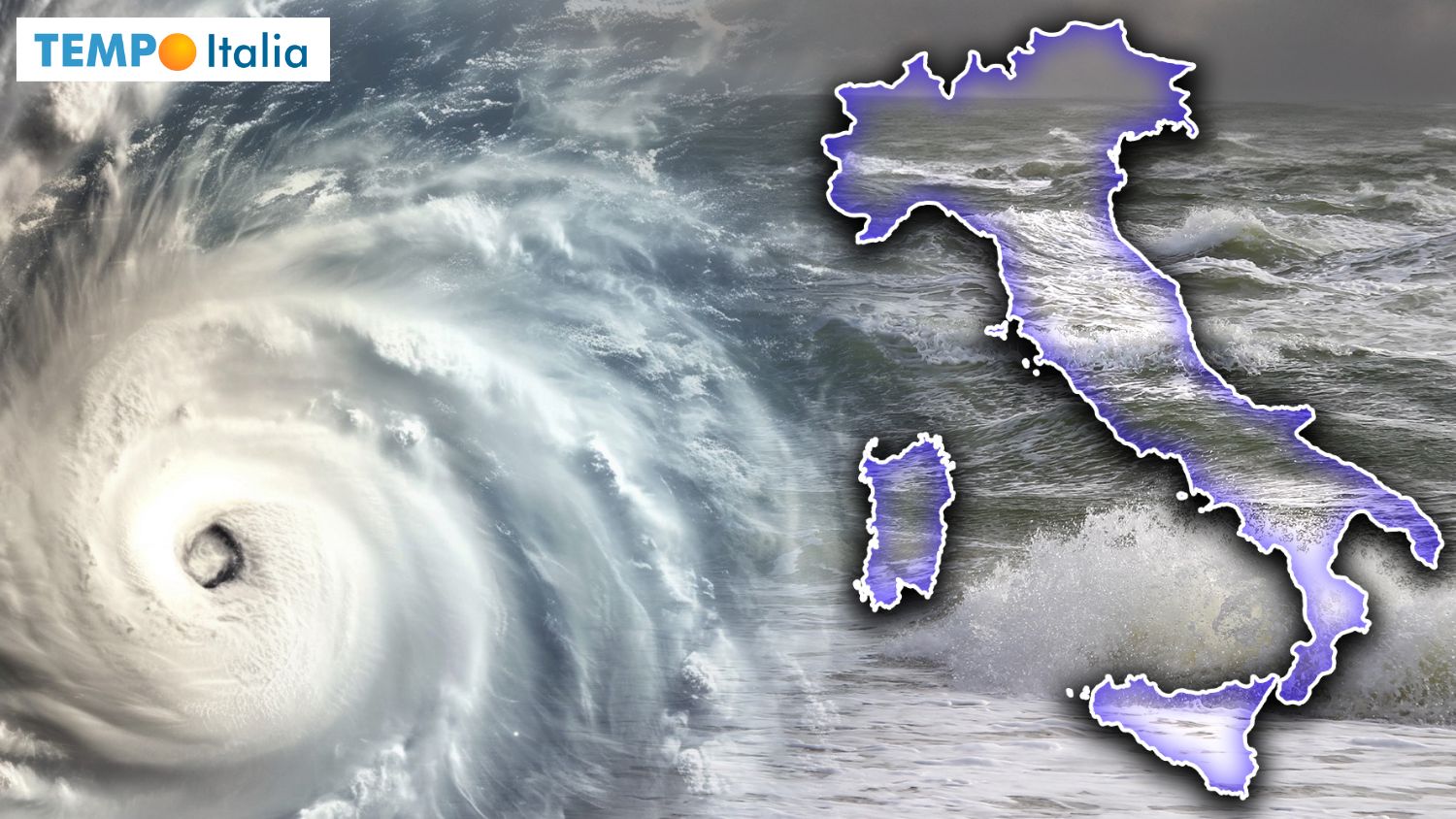Meno dazi? Allora maggiore svalutazione del dollaro
“Angeli santi dell’Onnipotente, abbiate pietà di me e salvatemi dai malvagi esattori di dazi”. Così recita una antica preghiera dell’Euchologion, il principale libro liturgico dell’ortodossia. La preghiera si riferisce alla credenza che l’anima, dopo la morte, venga accompagnata dagli angeli davanti a venti caselli daziari celesti, i telonei. In ogni teloneo c’è un demone, specializzato... Leggi tutto

“Angeli santi dell’Onnipotente, abbiate pietà di me e salvatemi dai malvagi esattori di dazi”. Così recita una antica preghiera dell’Euchologion, il principale libro liturgico dell’ortodossia. La preghiera si riferisce alla credenza che l’anima, dopo la morte, venga accompagnata dagli angeli davanti a venti caselli daziari celesti, i telonei. In ogni teloneo c’è un demone, specializzato in un tipo particolare di vizio, che chiede all’anima di esibire qualcosa di buono a compenso dei peccati commessi, che il demone ha registrato scrupolosamente. Se l’anima non riesce a convincere il demone, questo la trascina all’inferno. Se riesce, passa al casello successivo. Se li supera tutti, va in Paradiso.
La credenza nei telonei, di ascendenza mandeana, è parte della tradizione escatologica orientale e viene accettata oggi da alcune chiese ortodosse e respinta da altre, che la considerano eretica e gnostica. Per la sua natura immaginifica, ben rappresentata nella tradizione artistica bizantina, è comunque una credenza ancora oggi piuttosto diffusa, soprattutto a livello popolare.
Immaginifica, a suo modo, è anche la sistemazione teologica della teoria trumpiana dei dazi, visibile in filigrana dietro al ribollire di mosse e contromosse tattiche che si susseguono quasi quotidianamente. I telonei che deve superare un bene estero che cerca di entrare in America sono tre. Il primo è il dazio erga omnes del 10%. Il secondo è il dazio di reciprocità, che dipende dal Paese di provenienza. Il terzo è il dazio di settore, che può esserci o non esserci.
I tre tipi di dazi rispondono a tre esigenze diverse e hanno gradi di negoziabilità differenti.
Il dazio di entrata, quello erga omnes del 10%, ha la funzione di raccogliere soldi. Questi soldi, nella narrazione trumpiana, saranno pagati dagli esportatori esteri e serviranno a ridurre le imposte interne americane su famiglie e imprese. Su questo punto si è scatenata una disputa ideologica animata dagli oppositori di Trump, che sostengono che i dazi verranno pagati dai consumatori americani, non dall’estero. Dal furore della mischia, l’idea che sta emergendo su questo punto è che i dazi bassi (fino al 10 per cento) sono assorbiti in gran parte dagli esportatori, come è stato il caso dei dazi introdotti da Trump nel 2018-19. Per mantenere la loro quota di mercato, i produttori stranieri sacrificano infatti una parte dei loro margini e lasciano invariati i prezzi di vendita. Oltre un certo livello, però, i dazi vengono effettivamente scaricati sul consumatore americano e hanno quindi un sicuro, per quanto temporaneo, impatto inflazionistico.
Il secondo livello di dazi, quelli di reciprocità, non ha, tipicamente, la funzione di raccogliere soldi, ma di essere oggetto di scambio per ottenere altro. I dazi di reciprocità, come si ricorderà, furono introdotti il 2 aprile nel Liberation Day e sono diversi in funzione di quanto l’export americano copre l’import da ogni singolo paese. Qui, a differenza dai dazi di ingresso, la negoziabilità è massima. Un paese che vuole ridurre o azzerare i dazi di reciprocità può scegliere tra l’abolizione delle sue tariffe verso i prodotti americani, un riavvicinamento geopolitico agli Stati Uniti o l’acquisto su vasta scala di armi, gas, petrolio o titoli del debito pubblico americani. Può anche scegliere di rivalutare la sua moneta rispetto al dollaro o aumentare la somma che paga all’America per assicurarsi la sua protezione militare. Può offrire insomma, in una certa misura, quello che vuole, a patto che sia significativo e di valore per gli Stati Uniti.
In teoria è possibile che un paese che ha a sua volta dazi molto alti, come l’India, offra di azzerarli. In questo caso, i dazi reciproci potrebbero risultare alla fine del negoziato più bassi che all’inizio. Il mercato apprezzerebbe molto un esito di questo tipo, che però non sarebbe la regola, ma piuttosto l’eccezione. Si consideri del resto il caso di azzeramento di dazi su prodotti americani che il mercato locale comunque rifiuterebbe (auto americane, prodotti alimentari con componenti geneticamente modificate, carne clorurata). In questi casi l’America non avrebbe nessun vantaggio ad accontentarsi di un azzeramento dei dazi e chiederebbe altro.
Il terzo livello di dazi, quelli di settore, ha l’obiettivo di reindustrializzare l’America almeno nei settori selezionati (farmaceutico, semiconduttori, acciaio, alluminio). Questo è dunque il livello della politica industriale, ovvero delle scelte dall’alto dei settori da rafforzare.
Come si vede, è un quadro articolato. I mercati, finora, hanno chiaramente premiato le aperture verso dazi più contenuti e punito le minacce di dazi elevati. Bisogna però fare attenzione, prima di festeggiare eventuali accordi che prevedano dazi ragionevoli, e cercare di intuire le clausole non rese pubbliche. Meno dazi vedremo, infatti, più è probabile che ci siano accordi per rivalutare rispetto al dollaro. Saranno riallineamenti a strappi, ampi ma completati in poco tempo, come abbiamo visto tra euro e dollaro tra marzo e aprile e sul dollaro di Taiwan nei giorni scorsi. Di questi riallineamenti si parlerà poco a livello ufficiale perché si vuole conservare l’idea che i cambi sono stabiliti dai mercati e non pilotati.
Questi strappi avverranno in varie fasi distanziate anche di mesi. Il fatto che uno strappo sia già avvenuto non significa che non ce ne saranno altri. Più dell’Europa, è l’Asia a essere nelle condizioni di dovere rivalutare massicciamente con strappi successivi. Come nota Stephen Jen, ci sono 2.5 trilioni di dollari non coperti sui conti dei fondi pensione e delle assicurazioni di Singapore, Malesia, Corea, Taiwan e Cina.
Finanziarsi in dollari e acquistare e valute di questi paesi ha un costo di carry (la differenza tra i tassi bassi offerti da questi paesi e quelli più alti che offre l’America) ma le potenzialità di rivalutazione nei prossimi due anni si profilano ampie, in particolare per i paesi geopoliticamente più vicini all’America (per la Cina il discorso potrebbe essere diverso).
Saranno dietro le quinte anche gli eventuali accordi sul mantenimento dei Treasuries nelle riserve valutarie dei vari paesi e sul loro possibile aumento. Questi accordi influiranno sui tassi (e quindi sulle Borse) molto di più dei dazi sul cognac francese o sul bourbon del Kentuky di cui leggeremo continuamente nei giornali.
A cura di Alessandro Fugnoli, strategist di Kairos (rubrica Il Rosso e il Nero)