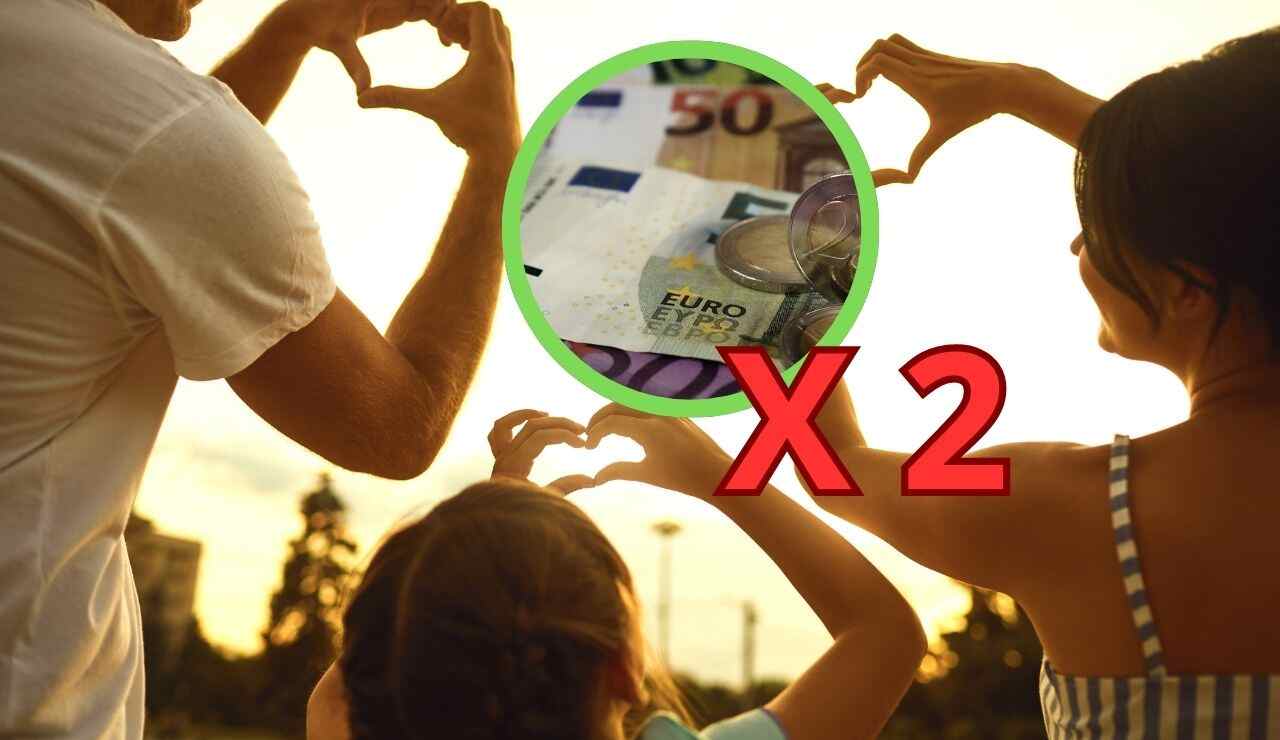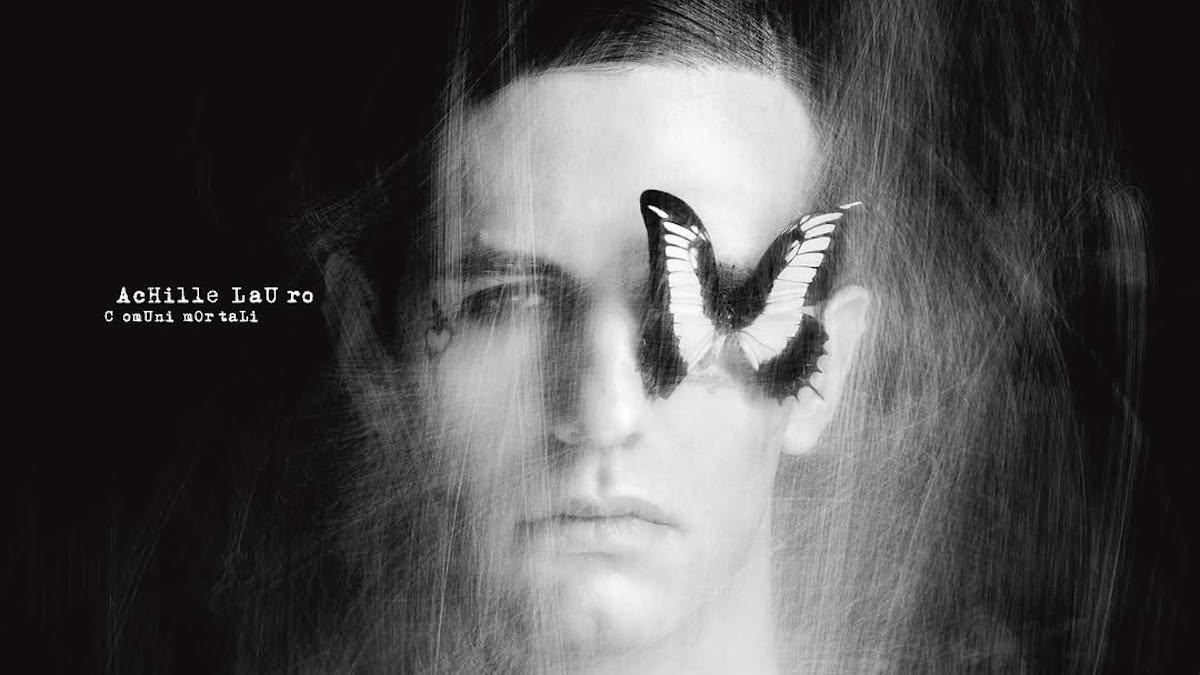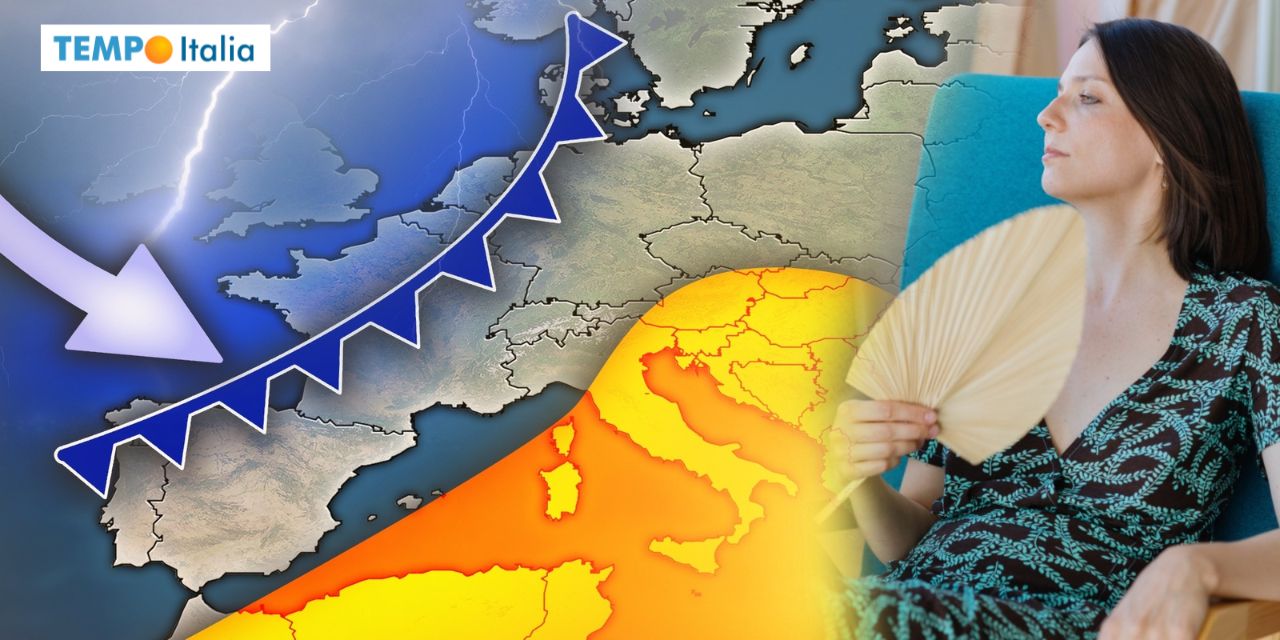Lavoro in una casa di riposo: così ogni anno vedo la Liberazione negli sguardi di chi l’ha vissuta
Lavoro in una casa di riposo. E lì, ogni anno, vedo la Liberazione riflessa negli sguardi di chi l’ha vissuta. Ci sono occhi che non ricordano cosa hanno mangiato ieri sera, eppure si riempiono di lacrime quando qualcuno nomina quel giorno. Erano bambini, spaventati e confusi, ma sapevano che l’incubo stava finendo. Che non ci […] L'articolo Lavoro in una casa di riposo: così ogni anno vedo la Liberazione negli sguardi di chi l’ha vissuta proviene da Il Fatto Quotidiano.

Lavoro in una casa di riposo. E lì, ogni anno, vedo la Liberazione riflessa negli sguardi di chi l’ha vissuta. Ci sono occhi che non ricordano cosa hanno mangiato ieri sera, eppure si riempiono di lacrime quando qualcuno nomina quel giorno.
Erano bambini, spaventati e confusi, ma sapevano che l’incubo stava finendo. Che non ci sarebbero più stati carri armati sotto le finestre, urla nella notte, fame nera. Solo la cioccolata degli americani — piovuta giù dai camion, come un miracolo. Non era quella che conosciamo oggi: era densa, quadrata, compatta, faceva parte delle razioni standardizzate K e D distribuite ai soldati, fatta per resistere al caldo, per nutrire più che per piacere. Ma per chi non aveva mai assaggiato nulla del genere, era il sapore dell’America, della libertà, del futuro. Veniva dalla Pennsylvania, dall’Ohio, dal New Jersey — fabbriche lontane, che per magia finivano tra le mani di bambini che avevano dimenticato il gusto del dolce. Cioccolata mai vista, che alcuni mangiarono a tal punto da stare male, a tal punto da concimare i campi dell’Emilia-Romagna con l’eccesso di dolcezza.
E poi c’è lei, mia nonna Antenisca. Gravida di otto mesi, gonfia come se aspettasse due gemelli, si piazzò davanti a casa, tra i partigiani e i mattoni da far saltare. I tedeschi avevano occupato l’abitazione, ma senza chiedere permesso. I partigiani volevano raderla al suolo. Lei, sola, con il pancione teso e le braccia incrociate da vera azdora, chiamò ognuno per nome, uno a uno. “Tu sei il figlio di…” — e i partigiani abbassarono le armi, spaventati da quella memoria che li inchiodava alle loro radici. La casa rimase in piedi. E mia madre nacque lì, quattro chili di speranza, nel silenzio rumoroso del dopoguerra.
Non fu l’unica ad avere la casa occupata dai tedeschi.
“Eravamo sfollati a Ca’ di Lugo. I tedeschi in ritirata occuparono la casa, le donne cucinavano e lavavano per loro. Alcuni erano poco più che ragazzi. Ci fu una disperata ‘storia d’amore’. Mi scrisse anni dopo: mandò una foto e una lettera affettuosa dalla Germania. Era diventato un uomo”.
A Medicina non arrivarono subito gli inglesi, o i neozelandesi o gli americani. Arrivarono i Gurkha. Piccoli, veloci, silenziosi, armati del loro coltello sacro: il kukri. Il 16 aprile del ‘45 attraversarono il Sillaro, liberarono il paese, si fermarono un momento sul Gaiana e poi ripresero. Li vidi una volta in piazza, in cerchio, saltellare e sfoderare quel coltello che sembrava parte del loro stesso corpo. Capii in quell’istante quanto poco sapevo della storia. Uno di loro, che intervistai, mi disse: “Sono felice di servire la Corona. In Nepal ci sono solo povertà e guerra.” A Lugo fu diverso. Arrivarono gli indiani, del battaglione Jaipur, quasi tutti Sikh. Turbante stretto, capelli mai tagliati dalla nascita. Un’anziana mi raccontò di uno di loro. “Era brutto, basso, grosso e scuro. Ma si presentò in casa con una rosa per chiedere la mia mano. Un giorno si sciolse il turbante per mostrarmi i suoi capelli. Erano lunghi, neri, bellissimi. Mi disse che per farlo aveva violato la sua religione.”
Gli indiani amavano così tanto Lugo che si dice che bruciarono le camionette pur di non andarsene. E oggi, in una fotografia, uno di loro — vecchio, elegante, vestito di bianco, col turbante candido — tiene una rosa rossa davanti al cippo che ricorda i compagni caduti. Piange. E con lui piangono i muri, gli alberi, la storia. “Quelli che ci liberarono erano stranieri, scuri. Uno era musulmano, l’altro indù. Venivano dall’India, credo, aggregati agli inglesi. Furono tra i primi ad arrivare, sfondarono da qualche parte sul Senio, vicino a San Potito. Ricordo che entrarono da via Mentana, all’alba… c’erano ancora i tedeschi appostati. Lo fecero per il loro re e anche per il re d’Inghilterra, ma soprattutto per noi.”.
A protezione di Lugo, le staffette partigiane stesero lenzuoli sulla Rocca, bianchi come la pace, perché gli aerei non vedessero il centro e non lo bombardassero. Funzionò. Bombardarono Villa San Martino.
C’è chi morì il giorno della Liberazione. “Avevo cinque anni. Mi portarono mio padre in una cassa di legno. I tedeschi lo avevano usato come scudo umano mentre scappavano. Era martoriato. Lo presi per mano e lo portai da mia madre. Non capivo tutto, ma sapevo che qualcosa era finito per sempre.”
E poi c’era Stecchino, un contadino di San Lorenzo. Quando vide i carri armati alleati attraversare i campi, si mise in mezzo alla strada e si scagliò contro di loro, urlando che non avrebbero calpestato i suoi fagioli. Aveva coltivato quei filari con le mani, con la fame, con la guerra addosso, e non voleva che la libertà gli distruggesse anche quello. Qualcuno lo ha paragonato all’uomo di Piazza Tienanmen. Ma Stecchino aveva la camicia stracciata, le mani piene di terra, e nessuno a fotografarlo. Solo chi lo ha visto lo ricorda. Ma anche quella è resistenza.
Ecco cos’è la Liberazione per me. È memoria che affiora nei solchi del tempo, è una nonna incinta che sfida le armi, è cioccolata che fa male e bene insieme, è un coltello sacro che danza, è un turbante che si scioglie per amore. E sono anche le bandiere alleate e italiane che ancora oggi, ottant’anni dopo, sventolano sugli argini dei fiumi. Fiumi che segnano da sempre, nel bene e nel male, il destino della Romagna. E che oggi raccontano, con quel gesto silenzioso e solenne, che la libertà ha avuto un prezzo — e che la memoria va coltivata come i fiori.
Questa è la Liberazione per me. Un messaggio che resiste da ottanta anni. Un bisogno che oggi, forse più di ieri, abbiamo tutti.
Nota: oltre 200.000 soldati provenienti da colonie e paesi alleati — indiani, nepalesi, marocchini, algerini, senegalesi e polacchi — combatterono per la liberazione dell’Italia durante la Seconda Guerra Mondiale. Un esercito multietnico, spesso dimenticato, che contribuì in modo decisivo alla nostra libertà.
L'articolo Lavoro in una casa di riposo: così ogni anno vedo la Liberazione negli sguardi di chi l’ha vissuta proviene da Il Fatto Quotidiano.