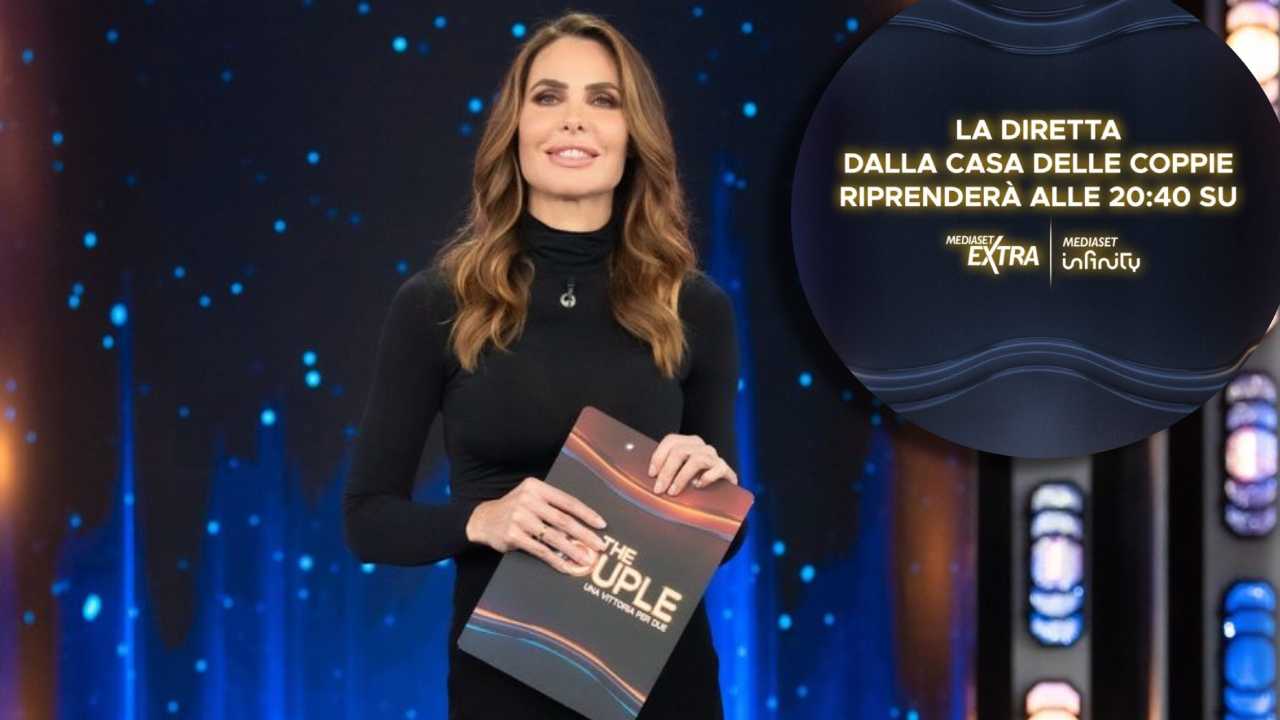In tempi difficili, “National Anthem” è un inno a un’America libera, che può essere ciò che vuole
“National Anthem”, l’esordio al lungometraggio del fotografo e regista Luke Gilford, racconta il nostro profondo bisogno di connessione umana e il significato autentico del sentirsi parte di qualcosa. Attraverso la storia di un rodeo poco convenzionale, animato da persone LGBTQ+, il film non riscrive solo i codici del grande West americano, ma affronta anche le dinamiche che sottendono il processo di fare i conti con la famiglia che si è scelto e quella d’origine. L'articolo In tempi difficili, “National Anthem” è un inno a un’America libera, che può essere ciò che vuole proviene da THE VISION.

Uno degli esercizi che trovo più utili per scrollarsi di dosso una certa pigrizia è quello di provare a pensare a descrizioni diverse di oggetti e situazioni comuni. Mi spiego meglio: quando leggiamo o scriviamo, tendiamo ad attribuire alle cose tendenzialmente sempre le stesse caratteristiche. Il tetto è spiovente, se qualcosa è blu lo è come il cielo o come il mare, le montagne svettano, la scrittura è delicata o pungente, è così via. Immaginare nuovi modi di vedere ciò che ci circonda non è solo una pratica per alimentare la fantasia ma anche per dare nuove forme a scenari che abbiamo sempre assimilato per come ci sono stati raccontati. È ancora più interessante quando a essere oggetto di questo cambiamento di prospettiva sono pilastri culturali che non abbiamo mai messo in discussione, proprio come fa National Anthem, l’esordio al lungometraggio del fotografo e regista Luke Gilford, che sarà proiettato domenica 27 aprile, alle 20.30, al Cinema Godard, nella sede milanese di Fondazione Prada, all’interno della rassegna Queerelle, curata dal Mix Festival Internazionale di Cinema LGBTQ e Cultura Queer di Milano.


Immerso nei vasti paesaggi del New Mexico, Dylan, un ragazzo ventunenne, vive in una piccola cittadina rurale e si prende cura del fratellino e della madre, che fa la parrucchiera in un posto dove la gente non si taglia così spesso i capelli da poterci campare. La sua esistenza è scandita da lavori saltuari, silenzi familiari e un senso di responsabilità che gli pesa addosso come una seconda pelle. Cresciuto in un contesto in cui la mascolinità è rigida e l’individualità è spesso repressa, Dylan cerca una via d’uscita – o almeno un momento di respiro – dalla costrizione della routine. L’occasione arriva quando accetta un impiego come manovale in un ranch apparentemente ordinario ma che si rivela essere un luogo del tutto diverso: una casa, una comunità viva e pulsante formata da cowboy e cowgirl queer che hanno trovato in quel paesaggio selvaggio lo spazio per esprimersi liberamente. Tra i personaggi che accolgono Dylan c’è Sky, un’artista trans magnetica e appassionata, che diventa la sua guida e soprattutto il suo primo legame emotivo profondo, e Pepe, che gestisce il ranch come un padre affettuoso e accogliente, offrendo stabilità e calore a chi vi arriva. Attraverso momenti di festa, competizioni di rodeo, confessioni sotto cieli stellati e piccoli atti di ribellione quotidiana, Dylan si trasforma, iniziando a vedere sé stesso sotto una nuova luce. “Uno dei grandi poteri del rodeo queer è la sua capacità di distruggere le antiche dicotomie americane che non possono contenere chi siamo veramente: liberali contro conservatori, urbani contro rurali, ‘élite costiera’ contro ‘America media’. È incredibilmente raro trovare una comunità che abbracci effettivamente entrambe le estremità dello spettro”, spiega Gilford.

Come racconto di formazione e di scoperta dell’identità queer, National Anthem evita molti dei cliché tipici del genere, non focalizzandosi su esperienze traumatiche e sul timore che accompagna la scoperta di sé, ma sceglie anzi un’altra strada, mettendo al centro il bisogno profondo di connessione umana e il significato autentico del sentirsi parte di qualcosa. L’aspetto più toccante del film è infatti la sua capacità di comprendere che non c’è nulla di sorprendente o straordinario nel vedere persone queer andare a cavallo nel deserto, camminare tra le corsie di un grande magazzino di provincia o prendersi cura di un ranch. Considerata la sua esperienza come fotografo, Gilford sa perfettamente come costruire immagini visivamente potenti, ma non è interessato a presentare il corpo queer nell’America rurale come un esperimento sociale o provocatorio, quanto è più attratto dall’idea che quei corpi possano essere spazio di desiderio, gioco ed esplorazione. In parte, probabilmente, perché è stato lui stesso a vivere quelle esperienze in quei luoghi.


Il film, infatti, prende il nome da un libro fotografico che il regista ha realizzato per documentare la sottocultura dei rodeo queer, National Anthem. America’s Queer Rodeo, per cui ha girato il Paese per oltre tre anni. Cresciuto in Colorado con suo padre nel mondo dei rodei, Gilford non si è mai sentito veramente integrato nell’ambiente, spesso considerato conservatore e omofobo, fino a quando non ha scoperto l’esistenza dell’IGRA, l’International Gay Rodeo Association, un’organizzazione di cowboy e cowgirl del Nord America aperto a tutte le espressioni di genere, identità, etnie e orientamenti sessuali. Uno spazio sicuro i cui eventi raccolgono partecipanti da ogni angolo degli States. “Per il mio primo lungometraggio, volevo partire da qualcosa di profondamente personale. I miei primi ricordi sono tutti legati ai rodei. Con il tempo, però, ho scoperto quanto questo ambiente potesse essere omofobo, misogino e razzista, e così, naturalmente, me ne sono allontanato, fino a quando non ho trovato la mia gente”, racconta Gilford. “Il senso di appartenenza che ho provato è stato come una scarica elettrica. Ho sentito il bisogno di raccontarlo, e di far sì che la storia di Dylan rispecchiasse in parte la mia – la scoperta di questa comunità, il farne parte”.

I protagonisti di National Anthem e le persone queer a cui si ispirano fanno parte di una comunità che vive in stati conservatori, e che non sente il bisogno di doversi fermare a spiegarsi o scusarsi per la propria natura. Vivono ogni giorno la loro verità e possiamo immaginare quanto sia spaventoso farlo anche nel momento storico che stiamo attraversando, soprattutto in certi contesti, dove la violenza disumanizzante è una realtà quotidiana. Eppure loro non solo continuano a essere se stessi e se stesse, ma si riappropriano di un immaginario, quello dell’archetipo del cowboy, tradizionalmente associato alla mascolinità e all’eteronormatività. Nato dall’influenza dei vaqueros spagnoli che lavoravano nei ranch del Sud-Ovest, e poi evolutosi in una figura distinta e decisamente più bianca, il cowboy è diventato un simbolo dell’Ovest americano tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, arrivando ad acquisire un forte peso nell’identità culturale americana. Eppure, negli ultimi tempi, assistiamo a una riscrittura del suo canone, in cui la pellicola di Gilford si inserisce perfettamente: dalla musica, con l’immaginario mirrorball dell’album Renaissance di Beyoncé e quello pastello dell’Eras Tour di Taylor Swift, al cinema, con l’indimenticabile completo rosa indossato da Margot Robbie in Barbie, il corto queer di Pedro Almodóvar Strange Way of Life, e alla serialità, con Yellowstone e 1923, che aprono anche a una riscrittura lontana dalla bianchezza a cui siamo stati abituati negli anni. Sky, Pepe, Carrie e gli altri personaggi di National Anthem sembrano affermare: “Posso essere un cowboy anch’io, anche se sono una persona non binaria, trans, latina, afrodiscendente o una donna”. E sembra proprio la promessa di libertà e democrazia su cui gli Stati Uniti hanno costruito la propria narrazione, la libertà di essere ciò che vogliamo essere, che siamo, e che invece si sta sempre più incrinando. Gli Usa, infatti, apparentemente fondati su ideali incrollabili di libertà, come sappiamo nascondono una storia segnata da profonde violenze e lotte incessanti per la creazione di una società autenticamente pluralista. Basta guardare al periodo di crescente ostilità nei confronti della comunità LGBTQ+: l’amministrazione Trump ha vietato dai documentati federali alcuni termini come “inclusione”, “transgender”, “persone non binarie”; ha imposto il divieto alle donne trans di gareggiare nelle competizioni femminili, divelto l’assistenza medica per l’incongruenza di genere, bandito testi necessari a un’educazione più inclusiva e progressista.


Mentre Dylan si scopre immerso in una sorta di giardino dell’Eden queer, fatto di paillettes e stivali da cowboy, dove tutti assumono piccole dosi di psilocibina e si fondono con la natura e tra loro, in un piacere senza confini, National Anthem non riscrive solo i codici del grande West americano, ma affronta anche le dinamiche che sottendono il processo di trovare la propria comunità e al contempo fare i conti con la propria famiglia d’origine. Abbiamo la famiglia che ci scegliamo, e quella biologica, fatta dai legami di sangue, e stare in equilibrio tra le due, quando si ha la possibilità di farlo, mi sembra uno degli esercizi che più rappresenta questo presente, in cui la politica ci schiaccia in una direzione mentre la società prosegue e straborda in un’altra, accettando sempre più ciò che è da sempre esistito, e cioè che le famiglie si fondano sulla cura reciproca, sull’esserci anche quando non ce n’è bisogno, non importa quanto grandi e allargate e frammentate e caotiche siano. Ed è anche un esercizio che richiede un grande sforzo, perché porta a galla un senso del dovere che spesso sfocia nel senso di colpa, come nelle parole di Dylan, che vorrebbe riuscire a mettere abbastanza soldi da parte per poter essere indipendente, per poter allontanarsi dalla sua famiglia, ma anche per potergli garantire un futuro, la stabilità che non hanno mai conosciuto. Cosa dobbiamo – se qualcosa dobbiamo – ai nostri genitori quando la famiglia che abbiamo scelto è così diversa da quella che ci è capitata?

C’è un che di estremamente umano nel modo in cui ci sentiamo sedotti, abbagliati, affranti, pieni di desiderio, gioiosi, traumatizzati, un po’ alla volta o tutto insieme, mentre cresciamo, mentre ci accorgiamo di star diventando adulti e diamo forma alla comunità di cui vorremmo far parte, di cui ci sentiamo parte, e Gilford riesce a catturarlo magnificamente. Una trasformazione che si scontra con le innegabili forze della natura, della famiglia e dell’amore, che inevitabilmente a loro volta finiscono per essere inglobate in questo passo deciso e claudicante che è vivere. È una sensazione di immensa gratitudine, quasi di sorpresa, quella che si prova nel guardarsi attorno e sapere di avere accanto persone che riconosciamo come nostre pari e che ci riconoscono come loro. Alla base, mi sembra, un elemento sostiene tutto: la consapevolezza di non doversi più nascondere, di poter essere liberi. Finalmente.
L'articolo In tempi difficili, “National Anthem” è un inno a un’America libera, che può essere ciò che vuole proviene da THE VISION.