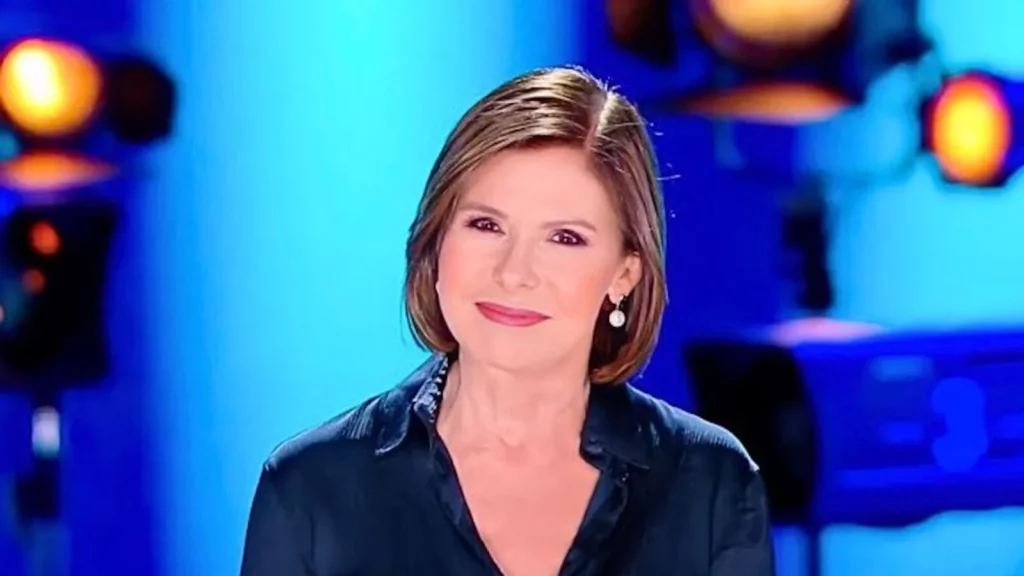Il problema dell’Europa è solo Trump o anche le politiche Ue?
I modi aggressivi e sguaiati dell'amministrazione Trump non solo sui dazi devono anche indurre gli Stati europei a porsi alcune domande su passato e presente delle politiche Ue. Il commento di Filippo Mazzotti

I modi aggressivi e sguaiati dell’amministrazione Trump non solo sui dazi devono anche indurre gli Stati europei a porsi alcune domande su passato e presente delle politiche Ue. Il commento di Filippo Mazzotti
Oltre ai danni economici e politici che sta già comportando, il rischio del modo aggressivo, confusionario e sguaiato con cui la nuova amministrazione americana di Donald Trump sta affrontando la questione dei dazi è quello di fornire alla classe dirigente europea l’alibi per non mettere in discussione il modo con cui, almeno dalla crisi finanziaria, ha scelto di “stare nel mondo”, soprattutto dal punto di vista commerciale ma non solo.
Non è un mistero come a partire da quegli anni l’area euro sia andata accumulando saldi sempre più favorevoli con l’esterno del blocco, con una progressione che è arrivata a superare i 250 miliardi di euro all’anno e che solo le condizioni oggettive legate alla crisi energetica hanno temporaneamente interrotto. E non è nemmeno un mistero come, malgrado i trionfalismi e le celebrazioni, si tratti di risultati solo in parte dovuti ad efficienza produttiva e, al contrario, largamente tributari di condizioni, in qualche modo, artificiali.
Da un lato, la sottovalutazione del cambio tedesco e la tolleranza nei confronti degli squilibri macroeconomici: fino a che la crisi energetica non l’ha fermata la Germania ha sfondato il limite del 6% previsto dalle regole europee sugli squilibri macroeconomici undici volte su undici, da quando le regole stesse esistono. Dall’altro, le politiche di compressione della domanda interna che, ben più del risanamento dei conti pubblici che ne è stato semmai rallentato, sono state il vero cardine delle politiche di austerity nel sud Europa e non solo: le country specific recommendations annuali che contenevano qualche invito al controllo del costo del lavoro si sono contate, negli anni dieci, a decine.
Lo stesso Mario Draghi ha, recentemente, parlato di “scarso sforzo per completare il mercato interno” e di “sfruttamento della domanda estera” – riconoscendo che tali sviluppi non sono stati “interamente accidentali” ed indipendenti dalla volontà dei governi – come fattori di un approccio che non è più sostenibile. Ecco, se i lunghi anni di austerity sono alla radice dell’instabilità politica interna, con il diffondersi dei cosiddetti populismi, l’idea di “sfruttare la domanda estera” non è affatto estranea alla conflittualità esterna che coinvolge sempre più l’Unione. E non è solo la spregiudicata irruenza del secondo Trump, per quanto già il primo lamentasse di vedere molte Mercedes sulla Fifth avenue e poche Chevrolet a Berlino. Al momento del voto sulla Brexit il deficit commerciale britannico verso l’area euro superava i 40 miliardi. E se la questione era assente dalla campagna “per il popolo”, essa era ben presente fra i ranghi di una classe dirigente schierata per il remain in modo meno granitico di quanto ci si potesse aspettare.
Si scorgono da qualche tempo segnali di resipiscenza, quanto strutturali e quanto legati alla catena di crisi che hanno investito il continente a partire dal 2020 si vedrà. Certo è che l’idea elitaria, che ha ispirato i vertici europei dal fatale 2008-2011, di trasformare a suon di piloti automatici un continente di quasi mezzo miliardo di persone in una specie di grande Taiwan – mettendo in secondo piano quel mercato comune per costruire il quale l’Europa è nata – ha già prodotto sufficiente instabilità politica, all’interno e all’esterno del blocco, senza condurre a progressi economici e sociali tali da giustificare il sacrificio. Speriamo che le stravaganze trumpiane non illudano nessuno che, dazi o non dazi, sia il caso di continuare così. Se in meno di dieci anni riesci a far scappare il Regno Unito, entrare in guerra commerciale con la Cina e gli Stati Uniti, senza contare la quasi guerra tout court con la Russia, forse è il caso di chiederti se, per caso, il problema non sei tu.