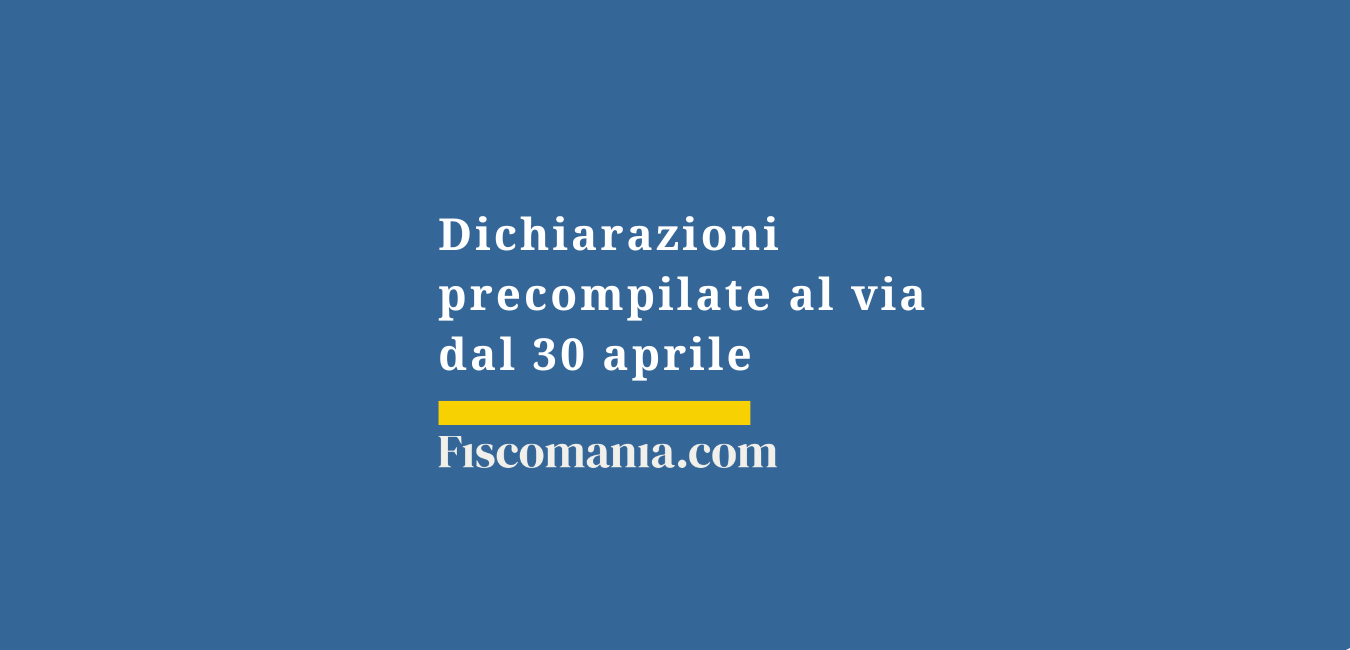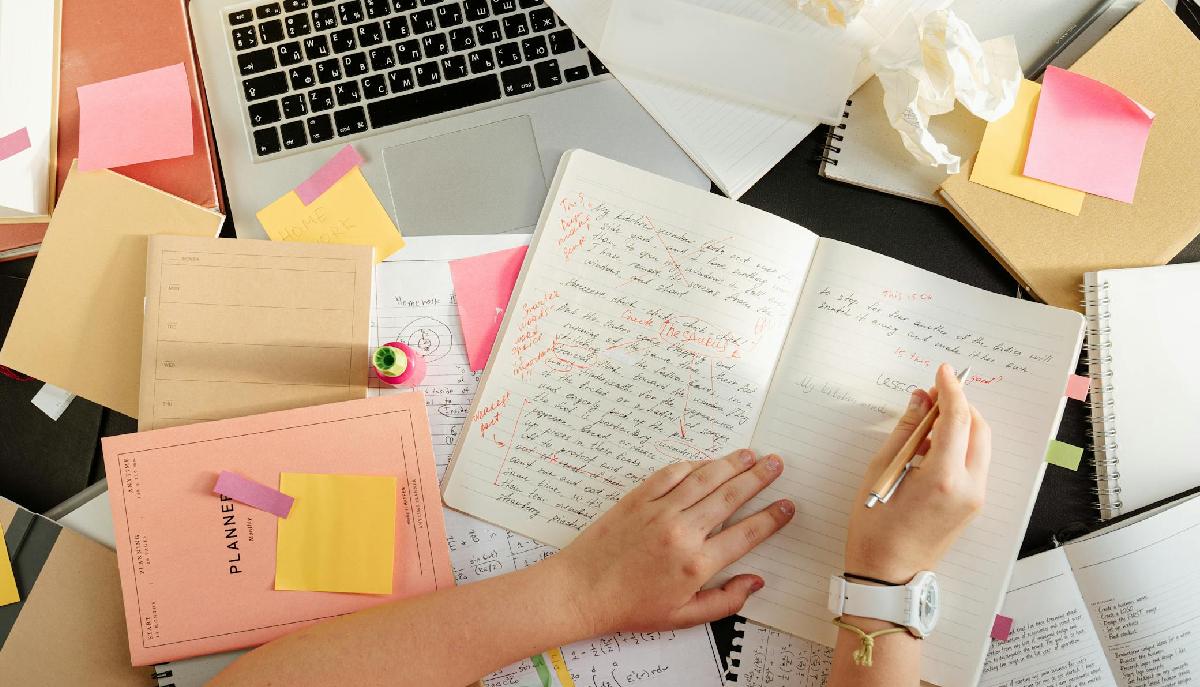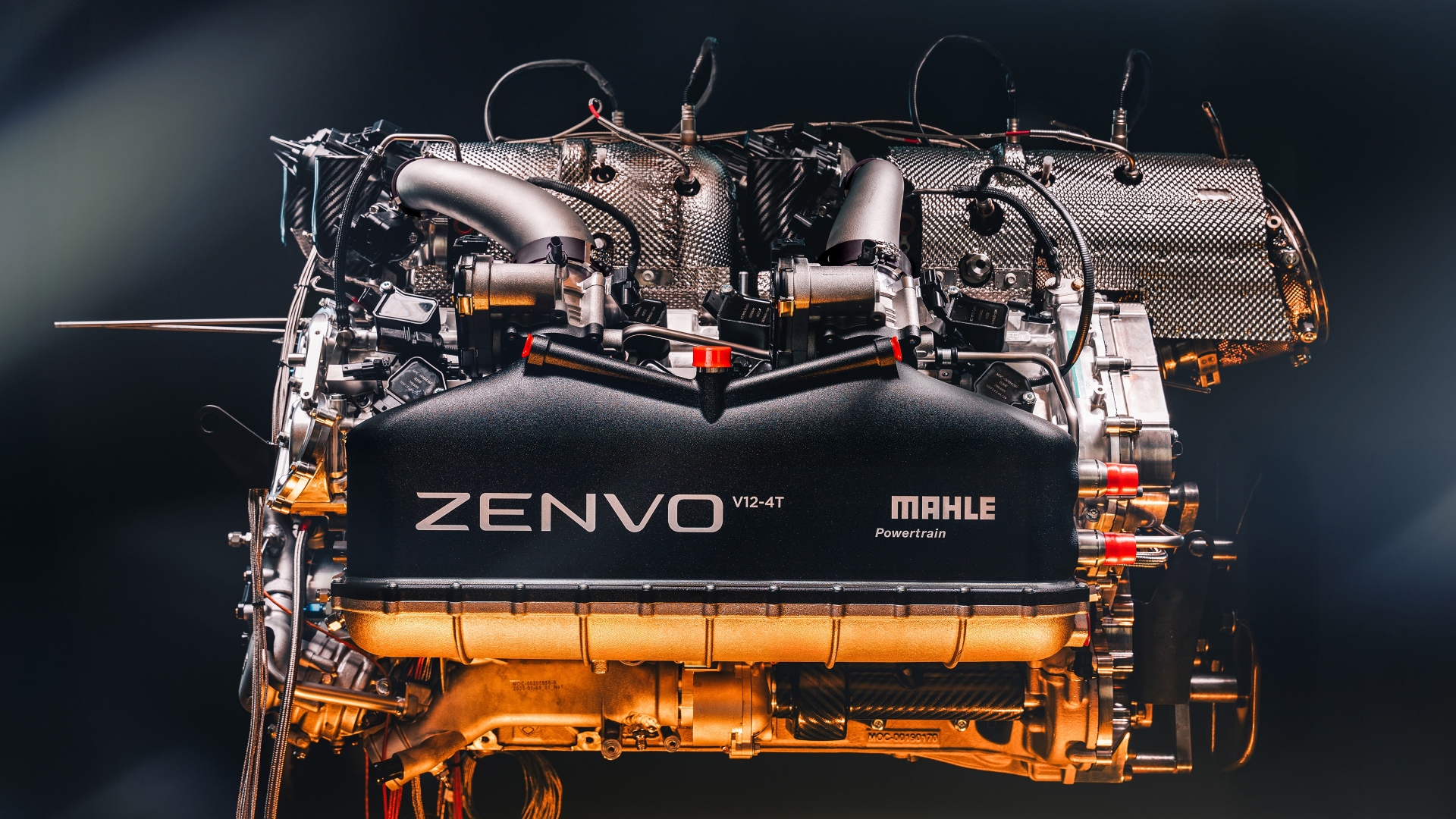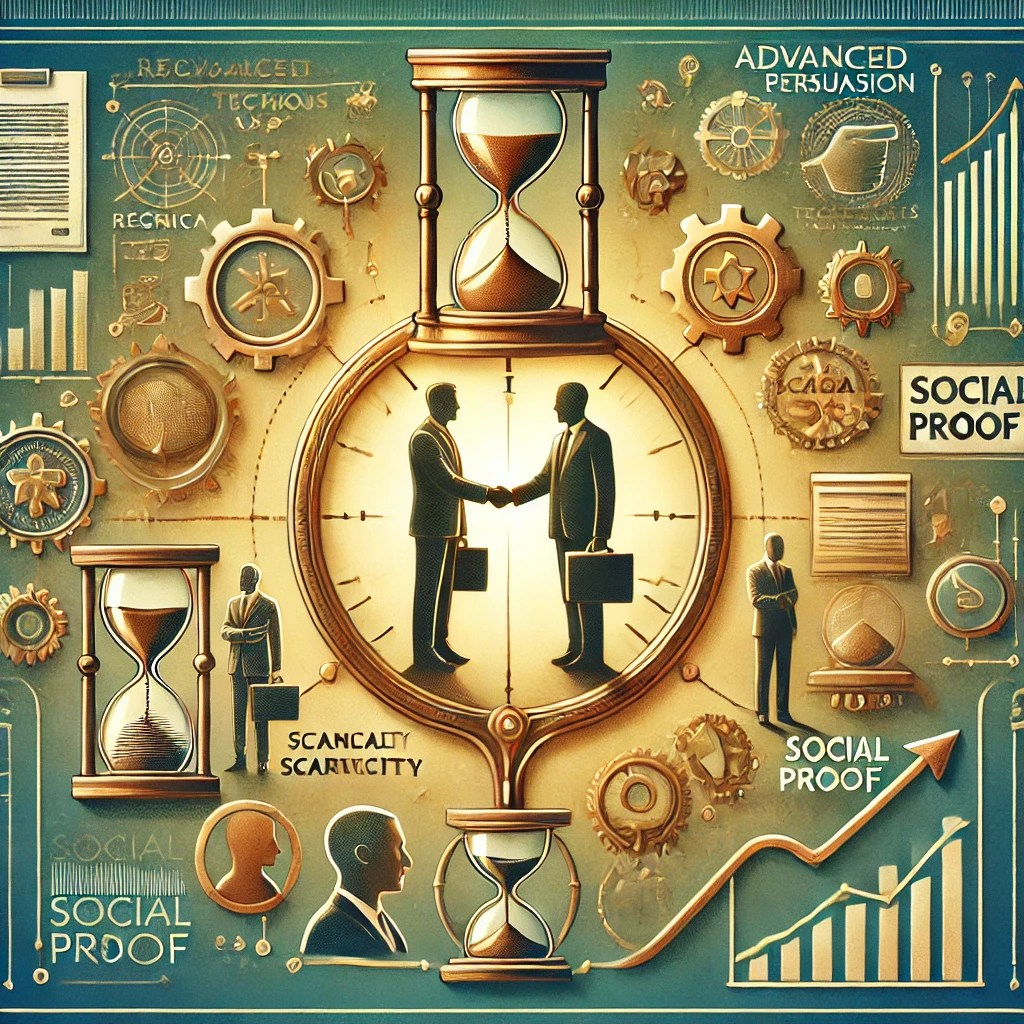Il papato di Francesco: brevi considerazioni
La morte del papa in occasione della celebrazione della festività del Lunedì dell’Angelo è simbolo autentico di speranza, la stessa profusa dall’annuncio della Resurrezione, e allo stesso modo simbolico appare […]

La morte del papa in occasione della celebrazione della festività del Lunedì dell’Angelo è simbolo autentico di speranza, la stessa profusa dall’annuncio della Resurrezione, e allo stesso modo simbolico appare il fatto che la sofferenza nella prova della malattia sia coincisa con il tempo quaresimale.
Il papato di Francesco è stato così un continuo segno del ruolo del cattolicesimo nel mondo, non troppo distante da esso in una pura trascendenza propria dell’ortodossia d’oriente, né troppo vicino ad un materialismo immanente privo di slancio spirituale che è del protestantesimo e delle sue forme politiche nel moderno.
Infatti, sin dalla scelta del nome, dal rifiuto di simboli appariscenti (senza rinunciare, tuttavia, al senso profondo delle celebrazioni nelle sue forme anche popolari), passando per il giubileo itinerante della misericordia (parola cardine del suo pontificato e senza dimenticare l’immagine potente della sua visita a Lampedusa), fino all’apertura verso le altre confessioni religiose (ognuna in grado a proprio modo di condurre verso la salvezza), Francesco è stato capace con coerenza e credibilità di portare avanti il proprio magistero su questioni molto complesse, nonostante le divergenze all’interno della curia romana.
Pertanto, ciò che rimane di Francesco sono i suoi piccoli, indelebili segni che si sono fatti sempre più sentire nei giorni della sua malattia, durante la quale non ha fatto minimante avvertire l’assenza della sua voce.
Il suo grido di pace è risuonato sempre forte fino alle parole del giorno di Pasqua di pieno sostegno alla popolazione civile di Gaza martoriata da un ignobile genocidio e di invito al disarmo, unica soluzione possibile ed auspicabile contro il delirio bellicista dell’occidente e dell’Europa del Rearm.
Infatti, sin dall’inizio del suo pontificato ci ha messo in guardia del rischio di una Terza guerra mondiale che, in realtà, già si stava combattendo a pezzi.
Francesco ha fatto notare come ci fosse, ormai, un clima di guerra latente che investiva più regioni del mondo, così che non si potesse più parlare di guerra o di pace, di conflitto armato o di tregua, ma come ci fosse, e tutt’ora c’è all’ennesima potenza, una normalizzazione di un conflitto perenne che non conosce fasi di stallo.
La voce di Francesco è risuonata più volte, soprattutto negli ultimi mesi, per denunciare le crisi umanitarie di Gaza, in Ucraina, in Yemen, in Sudan, così come la situazione delicata dei cristiani in Siria.
Posizioni tutte in controtendenza con la narrazione ufficiale del mainstream, come ad esempio sull’Ucraina, dove al pieno sostegno alle vittime civili ha saputo affiancare un realismo politico che ad altri è mancato.
O, ancora, sul genocidio in atto a Gaza, non facendo mai mancare il suo supporto anche nei giorni del ricovero.
E queste posizioni non erano per partito preso, ma al fine di garantire diritti e negoziare seriamente la pace.
Le sue posizioni, seppure forti di un ampio consenso del popolo di Dio, non hanno risposto a logiche imposte dalle élite economiche e politiche mondiali.
Un esempio lampante ce lo ha offerto sul tema della crisi ecologica e della cura del creato, affrontata nella sua seconda enciclica e prima che diventasse tema centrale dell’agenda politica globale, dove ha ben colto gli aspetti di connessione di queste con le questioni fondamentali della produzione industriale, della crisi economica e sociale.
Ovviamente anche in questo caso il monito è stato disatteso ed il tema è stato velocemente egemonizzato dalla rapace economia del capitale, in un ecologismo dell’1% che lo ha trasformato a proprio uso e consumo, scaricando i costi sui cittadini, a favore di pochi eletti che hanno aumentato introiti senza ridurre l’impatto reale sull’ecosistema.
Allo stesso modo, il tema dell’immigrazione, nel segno dell’accoglienza e della fratellanza, non era privo di considerazioni sulle logiche di sfruttamento del mercato del lavoro, seppure nell’idea che un’altra globalizzazione fosse possibile, ma non se ne può fare una colpa al pontefice, in quanto la speranza non può di certo mancare nell’animo cristiano libero, anzi ha avuto il merito di ammettere una diversa e plurale polarizzazione del mondo come oggi appare.
Allo stesso tempo anche le aperture verso la questione dei diritti delle comunità LGBT, non è stata ideologica come molti avrebbero voluto, ma ha cercato di mediare i valori tradizionali della cristianità con le crescenti rivendicazioni, non sempre legittime e condivisibili, da parte della cultura Woke.
Pertanto, il pensiero di papa Francesco, la cui formazione affonda le radici nel populismo teologico di Juan Carlos Scannone, non può essere rinchiuso in gabbie politiche rigide e limitanti e che, soprattutto, non tengono conto della complessità del suo ruolo e del modo nel quale ha esercitato il proprio potere spirituale e temporale.
Ora, tocca al nuovo pontefice far sì che la voce di pace e fratellanza continui a risuonare, e non potrà che essere così.
Infatti, poiché la morte, per il cristianesimo, non coincide con la fine, perché chi crede in Cristo non morrà in eterno, essendo Lui la Risurrezione e la vita.
Così, la Chiesa va oltre gli uomini che la popolano e chi temporaneamente la rappresenta, potendo lo spirito di pace e di fratellanza di questo pontificato profondere in futuro e potendo la Chiesa rimanere un argine contro il dilagare della furia cieca della guerra che imperversa anche alle nostre latitudini.