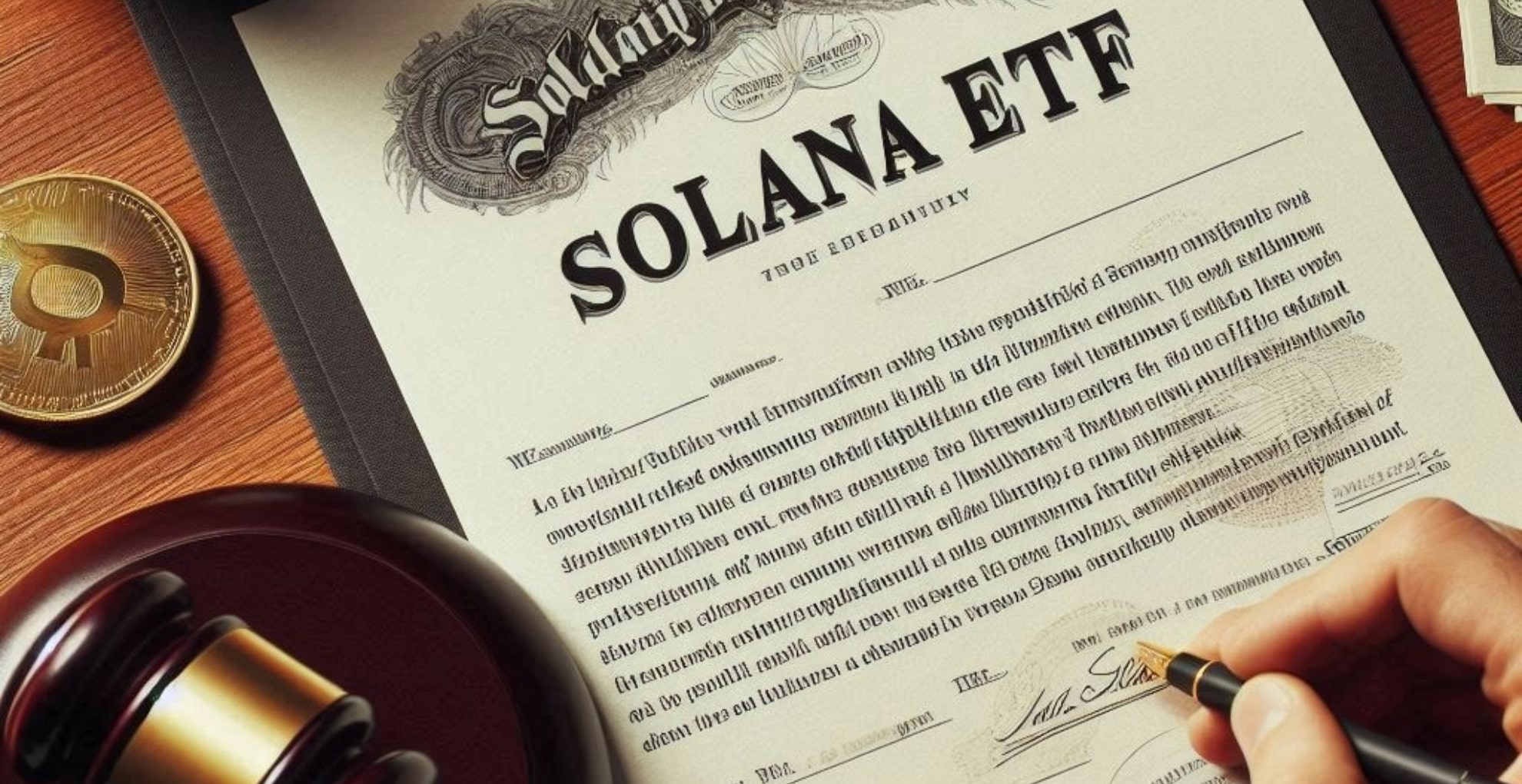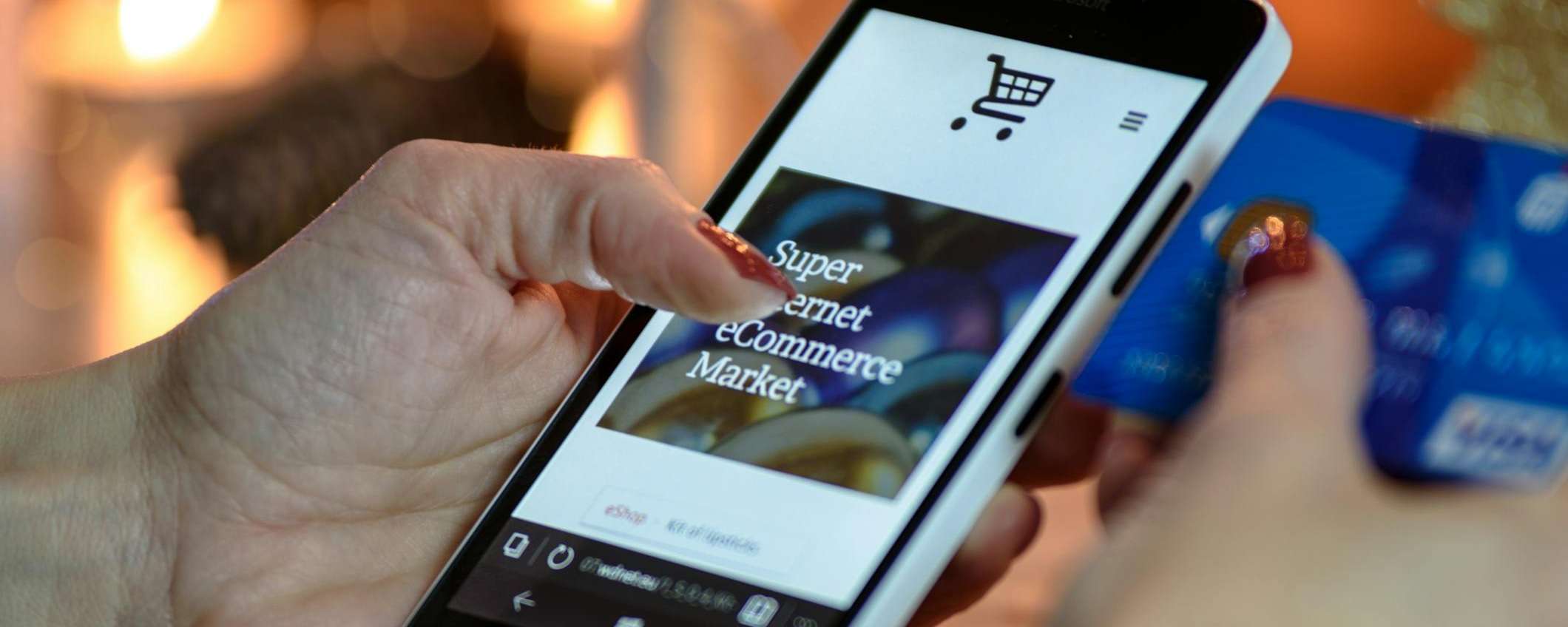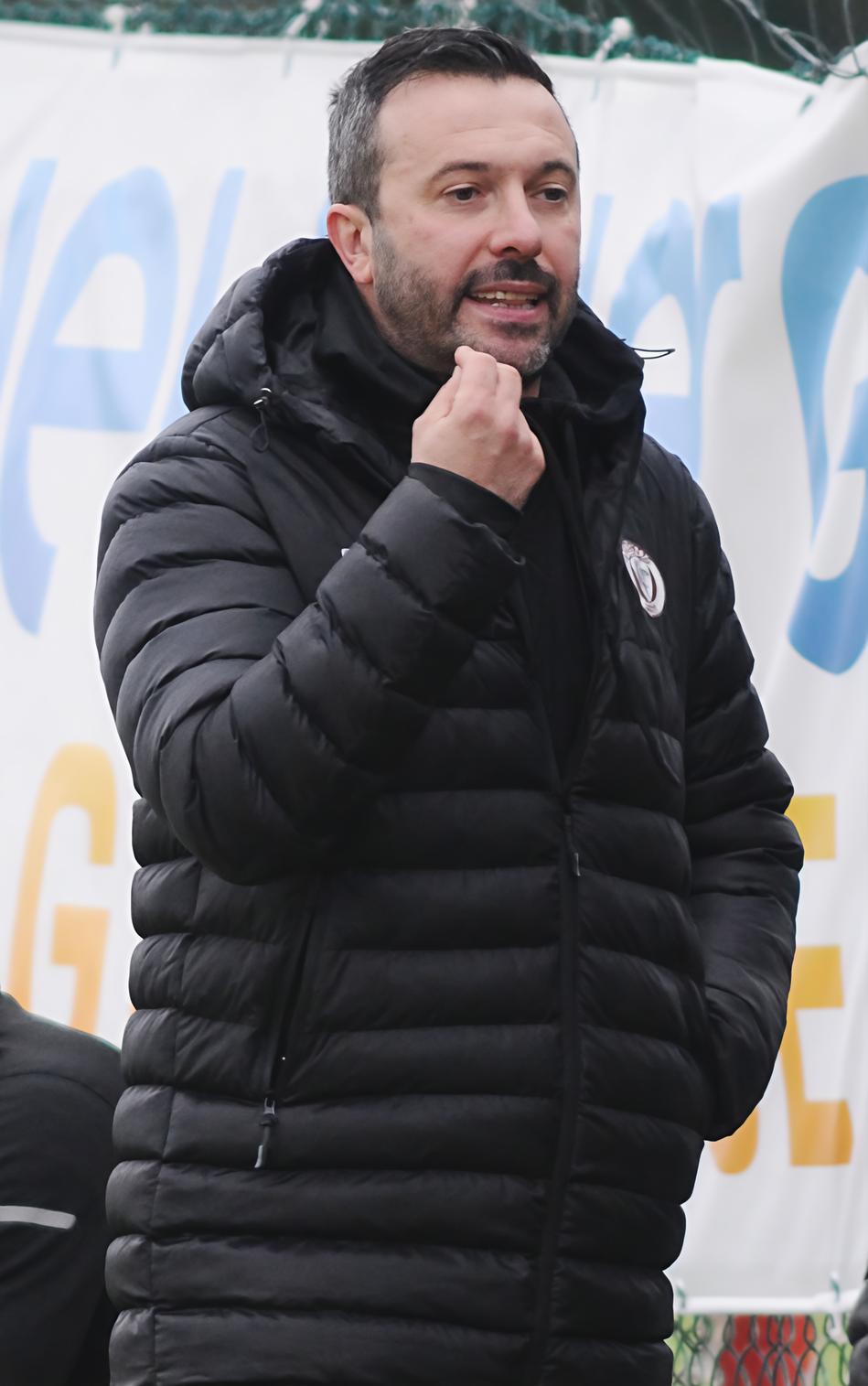I programmi per un’Europa che non c’è
Consigli non richiesti alle autorità europee e agli organizzatori di manifestazioni. L'intervento di Enzo Mattina, già dirigente sindacale della Uil, ex parlamentare ed ex europarlamentare del Psi, ora manager e imprenditore

Consigli non richiesti alle autorità europee e agli organizzatori di manifestazioni. L’intervento di Enzo Mattina, già dirigente sindacale della Uil, ex parlamentare ed ex europarlamentare del Psi, ora manager e imprenditore
Nonostante lo sforzo compiuto dalla stampa di destra di minimizzare il senso della presenza di quelle 50.000 persone di tutte le età in Piazza del Popolo a Roma sabato 15 marzo, in un pomeriggio piovigginoso, è incontestabile che le stesse si siano ritrovate non certo per l’impegno di organizzazioni politiche o sindacali, bensì per la consapevolezza diffusa che il soggetto storico, politico e socioeconomico dell’Unione Europea, forte dell’idealità che lo anima dal manifesto di Ventotene in avanti, pur con tutti i limiti della sua lenta esecuzione, rappresenti l’unico argine credibile alla riemersione delle remote, micidiali e sempre latenti malattie nazionalistiche; eccitate oggi dal neoisolazionismo degli Stati Uniti, dall’aggressività della Russia, dall’espansionismo cinese nei mercati della componentistica industriale e fortemente orientato a favorire la “crescita economica senza sapere” delle aree del globo più arretrate, soprattutto nel Continente africano, dalle ambizioni egemoniche del capitalismo digitale.
L’appello accorato di un giornalista, Michele Serra, ha richiamato l’attenzione, cui ha fatto seguito una risposta popolare di tutto rispetto, che testimonia una sensibilità politica di sicuro più ricca di quella espressa dalla premier e dal suo vice leghista, che brillano di scarse lettere quanto di scarse letture, in specie quando si avventurano nell’esegesi di testi storici.
Ora è d’obbligo pensare al seguito.
Si possono organizzare altre iniziative simili a quella di Roma, ma avranno senso solo se si definirà una piattaforma con obiettivi chiari ed esigibili e intorno ad essa si attiverà una mobilitazione democratica in tempi ravvicinati e ricorrenti, che coinvolga, nell’arco temporale da oggi alle elezioni del 2029, milioni di persone dislocate in quasi 90.000 unità amministrative locali (87.128, a dire i numeri esatti, di cui 54 con popolazione oltre 500.000 abitanti) distribuite nei 27 paesi dell’Unione Europea.
Questa dimensione territoriale ha una rappresentanza politica comune nei 720 parlamentari europei, che, in dipendenza delle loro funzioni, hanno assiduità di frequentazioni tra di loro, aldilà delle rispettive collocazioni politiche, e dovrebbero avere rapporti costanti con i loro elettori e le loro elettrici di sicuro non solo a carattere informativo, bensì su proposte e obiettivi da perseguire.
Non dovrebbe essere difficile questa valorizzazione della funzione elettiva, che non porterà a breve alla conquista della titolarità del potere legislativo, ma renderà visibile e socialmente rilevante il Parlamento europeo, promuovendolo a legittimo titolare di una dialettica costruttiva e non solo di un’interlocuzione con gli organismi politici e gestionali dell’U.E.
In quanto rappresentanti dei popoli nazionali potrebbero benissimo proporsi come gli ideatori e gli organizzatori di mobilitazioni popolari su temi specifici da portare al vaglio di Commissione e Consiglio, utilizzando lo strumento di democrazia delle Iniziative dei Cittadini Europei (ICE), istituto introdotto dal trattato di Lisbona del 2009 (TUE, art. 11, par. 4, e TFUE, art. 24, co. 1, e regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011).
In base a questa normativa, i cittadini dell’Unione, in numero di un milione e con cittadinanza in almeno sette stati membri, “possono prendere l’iniziativa d’invitare la Commissione europea, nell’ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell’Unione ai fini dell’attuazione dei Trattati”.
È una forma di proposta di legge d’iniziativa popolare, che, per il numero di elettrici, elettori e Stati che coinvolge, potrebbe fare uscire le scelte normative dai paludati rituali dei palazzi di Bruxelles, dirottandole verso un confronto diretto tra Istituzioni europee e società civile.
L’ICE consentirebbe di far maturare una sensibilizzazione di massa sul tema epocale dell’integrazione europea, tanto più che nel già citato Reg. N. 211/2011, art. 6 è previsto il ricorso agli strumenti informatici, vale a dire i social, che, nella fattispecie, diverrebbero vettori di democrazia partecipativa a disposizione dei cittadini.
La quantità di tematiche da affrontare è debordante, ma conviene, nella prima esperienza pratica, focalizzare l’attenzione su almeno quattro che sono di sicuro prioritarie: un paio, con natura squisitamente politica, le altre, con natura socio-economica.
La prima dovrebbe riguardare la fissazione dell’assoluta intangibilità dei principî della democrazia liberale, che di sicuro sono la libertà di pensiero, associazione, genere, religione, razza e il principio della separazione dei poteri. Quali che siano le giustificazioni di volta in volta esibite, è un dato di fatto che molti dei governi dei paesi del centro Europa, già parte dell’area di influenza sovietica, manifestano senza remore e talvolta anche con atti palesemente costrittivi la propensione a violare quei principî, esponendosi soltanto a qualche blando richiamo, quando, invece, dovrebbero subire pesanti sanzioni, fino all’estromissione dall’UE.
La seconda dovrebbe avere come oggetto la difesa europea da alimentare con la ricerca sugli strumenti operativi, la qualificazione degli addetti, l’adozione di apparati gerarchici di comando e diplomatici sovraordinati a quelli nazionali; un’assunzione di responsabilità ben più strutturata e finalizzata dell’ambiguo Rearm Europe e della nuova versione intitolata SAFE (Security Action For Europe).
La terza dovrebbe affrontare in via definitiva il fenomeno delle forme di truffaldina competitività fiscale presenti di sicuro in Olanda, Lussemburgo, Irlanda, Cipro, Malta e in molti Paesi dell’Europa centrale.
La quarta si dovrebbe concentrare sull’adozione dello statuto dei lavoratori europei che, in considerazione dell’estrema mutevolezza dell’organizzazione del lavoro: a) fissi i criteri della flexsecurity, integrando fasi di lavoro, di apprendimento e di sostegno sociale secondo regole uniformi, b) affidi alla contrattazione sindacale il disegno delle scale retributive, riducendone significativamente i gradini, c) definisca per i lavori ad alta discontinuità e a bassa professionalità nei servizi e in agricoltura un salario minimo fissato nelle scale retributive negoziate di settore, accompagnandolo con l’accesso favorito nei percorsi formativi finalizzati alla crescita delle competenze, d) garantisca la formazione approfondita, ricorrente e retribuita in materia di sicurezza sul lavoro, e) vieti ogni uso improprio dei controlli digitali, f) garantisca forme di cogestione sulle scelte organizzative, tecnologiche e finanziarie di maggior rilievo, influenti sulle condizioni di vita di lavoratrici e lavoratori.
Nel 1989 il 18 giugno, nella medesima data per il rinnovo del Parlamento, si sperimentò in Italia il primo e unico referendum di indirizzo, che affidò ai neoeletti il mandato costituente dell’Europa unita, con l’88,03% dei sì su una platea elettorale, mai più registrata da allora, di 80,86% degli aventi diritto al voto.
Quell’appuntamento fu un lascito dell’eredità morale di Altiero Spinelli; considerato che la sua dipartita era avvenuta nel 1986, si potrebbe pensare che si sia trattato di una sorta di omaggio alla memoria; non fu, però, vissuto come una pura ritualità, tant’è in forza di quel pronunciamento democratico, nella terza e quarta legislatura del P.E., si realizzò l’archiviazione della CEE e si costruì il passaggio all’Unione Europea, che è ancora lontana dal traguardo federalista, ma è di sicuro sulla linea dell’avvicinamento.
Ora tocca ai cittadini europei di appropriarsi di un progetto immaginato da pochi, sostenuto da molti all’indomani di lutti e miserie, posto oggi in stallo da gruppi dirigenti privi di visione e di coraggio.
Se si verificasse la mobilitazione di un numero rilevante di parlamentari europei in uno sforzo di coinvolgimento dei loro elettori e delle loro elettrici nelle scelte compiute di volta in volta dalla sede che è la massima espressione della volontà democratica del Vecchio Continente, di sicuro l’autorevolezza delle decisioni della UE se ne gioverebbe, rafforzando in tal modo la sua influenza nella dimensione internazionale.