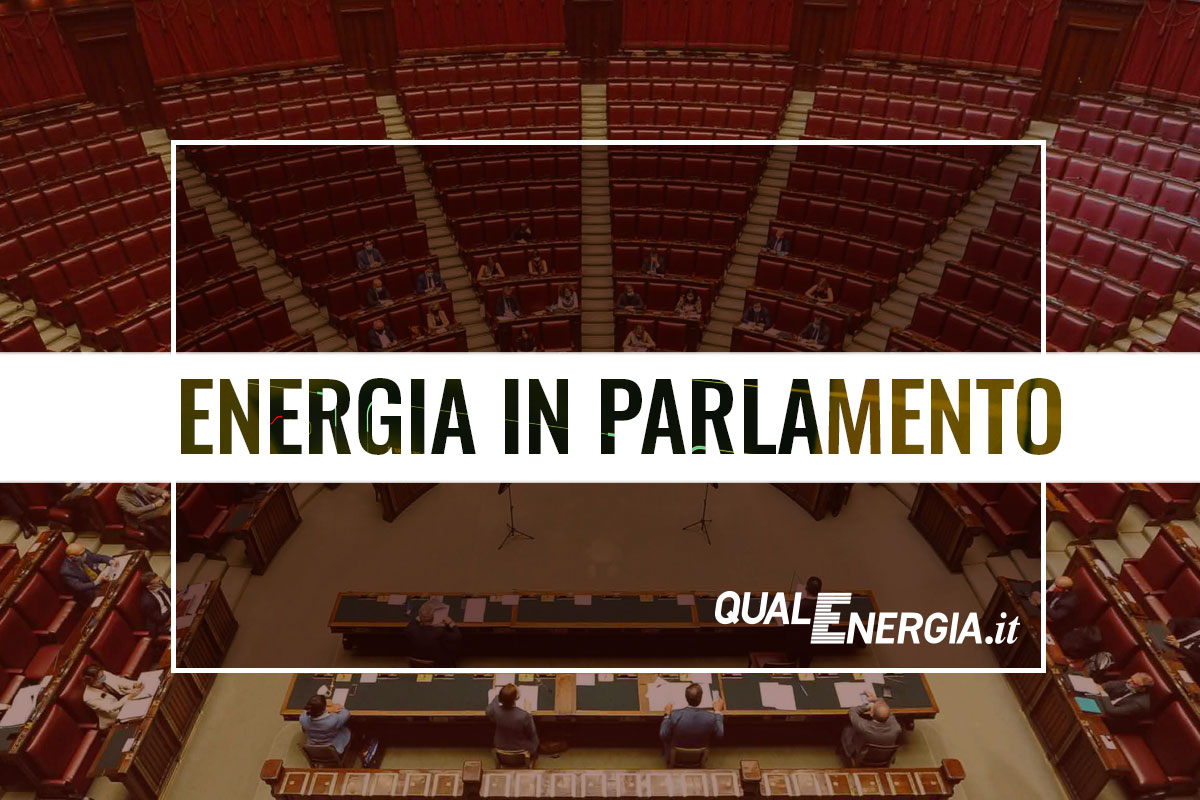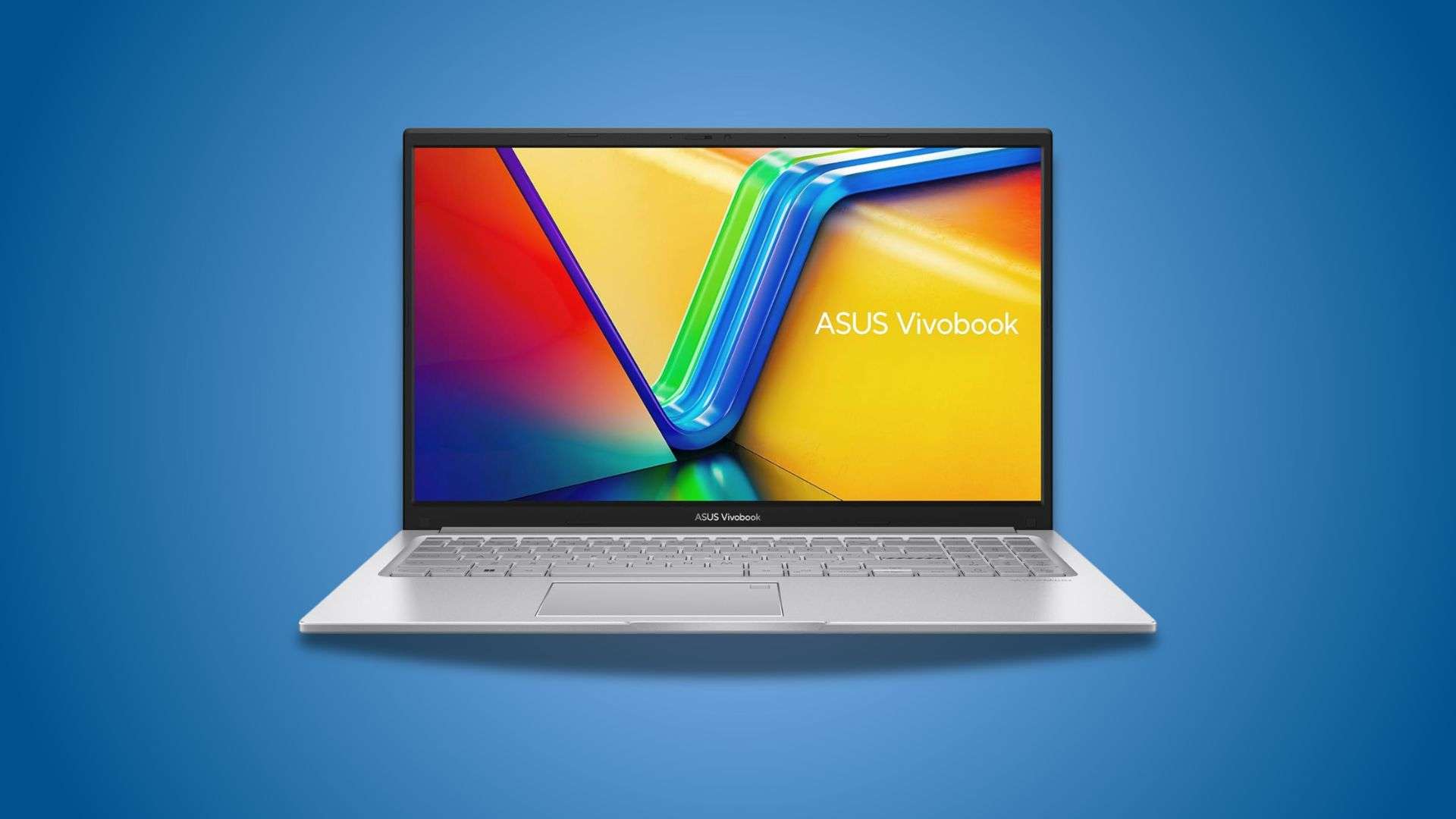Dentro la resistenza armata palestinese: le storie dei “cattivi” che i media non raccontano
Tulkarem, Cisgiordania occupata. Siamo davanti alla sede della Croce Rossa, dove ogni settimana si radunano famigliari dei detenuti palestinesi e solidali che gridano per la liberazione dei propri cari, mostrandone le gigantografie stampate su cartelli che tengono in mano. Sorrido a una donna che ho già visto alle scorse proteste, velo nero, abito tutto nero, […] The post Dentro la resistenza armata palestinese: le storie dei “cattivi” che i media non raccontano appeared first on L'INDIPENDENTE.

Tulkarem, Cisgiordania occupata. Siamo davanti alla sede della Croce Rossa, dove ogni settimana si radunano famigliari dei detenuti palestinesi e solidali che gridano per la liberazione dei propri cari, mostrandone le gigantografie stampate su cartelli che tengono in mano. Sorrido a una donna che ho già visto alle scorse proteste, velo nero, abito tutto nero, sembra vestita a lutto. Anche lei mi riconosce. Espressione triste sul viso, tiene in mano le immagini di un ragazzo giovane, quattro fotografie unite che raffigurano momenti di vita: appoggiato alla portiera della macchina, vestito a festa, con maglietta e cappellino in una giornata normale. Terminata la protesta, la donna, con il marito al suo fianco, si avvicina e ci invita a prendere un caffè a casa sua. L’uomo parla un po’ di inglese, lei no. Lui si chiama Ahmad, alla protesta reggeva una foto dello stesso ragazzo, ma in posa diversa. Amni, la donna, ci apre la porta di casa. Ci togliamo le scarpe ed entriamo.
Tutto il muro del piccolo salotto che ci accoglie è ricoperto di foto di ragazzi, molti con le armi al fianco o in pugno. È impressionante. Sono quasi tutti morti, scoprirò poco dopo. Torna Ahmad, chiudiamo la porta. Solo allora mi accorgo di una gigantografia verticale che mostra un giovane sorridente in maglietta a maniche corte, una mano in tasca e l’altra che stringe un fucile M-16. Ibrahim, il loro figlio, è ovunque nella stanza.
Ci sediamo, Amni rimette la foto che aveva alla protesta nel solo buco vuoto rimasto nel muro colmo di immagini. Si siede con noi, dopo averci offerto i succhi appena comprati, barrette di cioccolato e wafer.
Ibrahim è in carcere da quasi due anni. Non hanno sue notizie, non sanno niente. È condannato a 15 anni di prigione. Aveva 20 anni quando l’hanno arrestato.
Gli israeliani avrebbero provato a ucciderlo. «In realtà lo volevano morto», assicurano. È tutto vero, c’è il video. I militari israeliani si filmano spesso mentre compiono le operazioni, per poi pubblicare i video su Facebook. Ce lo fanno vedere. Il raid è di giorno, forse all’alba. Ma c’è luce. «Ecco è qui», indica Ahmad. Intanto ci spiega, nel video non si vede tutto. La porta l’hanno fatta esplodere, poi sono entrati in casa e hanno aperto il fuoco. Volevano uccidere tutti. Ibrahim è saltato dalla finestra del salotto. Gli altri sono morti. Samir e Hamza erano due dei migliori amici di suo figlio. Ci mostra una foto appesa al muro. Quattro ragazzi ridono abbracciati, nemmeno un pelo di barba sul mento. Sono ragazzini. «Loro due sono stati uccisi quel giorno. Lui» indica un terzo «è diventato martire circa un mese dopo». Ibrahim, è stato fortunato. Il video continua. Si vede un ragazzo, faccia al muro, le mani dietro la testa in segno di resa, maglietta bianca pulita e pantaloni neri. È circondato da militari. La telecamera inquadra altrove, si sentono degli spari, qualcuno grida di dolore. «È lui. Gli hanno sparato alla schiena, alle gambe. Volevano ucciderlo ma non è morto».

Cinque proiettili. Poi si vede un ragazzo portato via in barella, sporco di sangue e conciato male. Subito dopo, ci mostra un’immagine di lui all’ospedale.
La madre sparisce un attimo e torna con dei vestiti tra le mani: una maglietta bianca sporca di sangue e dei pantaloni completamente stracciati. Ci fa vedere i buchi dei proiettili nei pantaloni, il sangue sulla maglietta che nel video era chiaramente bianca, la mezza impronta di una scarpa. «L’hanno anche calpestato dopo» dice.
Non si sa se può camminare, Ibrahim. La mamma l’aveva visto a un’udienza qualche giorno dopo l’arresto e perdeva ancora sangue. Non camminava, lo trascinavano a forza. «Non l’hanno curato. L’hanno mandato in prigione pochi giorni dopo, non l’hanno fatto stare in ospedale. Ora da quello che sappiamo qualche passo lo fa, ma non sappiamo se abbia ripreso davvero a camminare», dice Amni, tradotta da Ahmad. La preoccupazione per le condizioni del figlio è palpabile: le galere israeliane, soprattutto dal 7 di ottobre in poi, sono diventate uno strumento scientifico di tortura per le migliaia di persone detenute. Lo ha dettagliato ampiamente, in un rapporto pubblicato ad agosto 2024, l’organizzazione umanitaria israeliana B’Tselem, parlando di forme istituzionalizzate di abusi, torture, gravissimi atti di violenza arbitraria e aggressioni sessuali per umiliare i detenuti palestinesi. Tutti i detenuti politici palestinesi liberati in questi mesi in occasione degli scambi di ostaggi con Hamas sono arrivati in condizioni di salute deplorevoli, magrissimi, spesso non in grado di camminare, con cicatrici e segni di violenze sul corpo. Chiunque esca di prigione ha perso decine di chili a causa dell’assenza di cibo e delle malattie lasciate volontariamente diffondere tra le celle sovraffollate. Per ora sono 63 i palestinesi morti – solo quelli dichiarati – nelle prigioni d’Israele dal 7 di ottobre a oggi. Uccisi dalle torture o dall’assenza di cure.

Nella stanza c’è un’altra presenza importante, di cui ci iniziano a parlare. Ahmad porta un quadro dipinto a mano e lo appoggia alla poltrona. «Questo è Jihad, era come se fosse nostro figlio». Il quadro l’ha dipinto lui. Ahmad è un pittore eccezionale. Lavorava dipingendo pareti «nel 48». Quarantotto è un numero che si impara presto a collocare geograficamente nei territori occupati: è il modo in cui spesso i palestinesi chiamano quello che nel resto del mondo chiamiamo Stato di Israele. Lo identificano con l’anno del secolo scorso in cui i coloni ebrei proclamarono la nascita dello Stato e cacciarono centinaia di migliaia di arabi, in quella operazione di pulizia etnica che i palestinesi chiamano «Nakba»: catastrofe.
Da un anno e nove mesi, Ahmad non guadagna un centesimo: nei territori occupati quasi nessuno ha i soldi per comprare i suoi lavori, e «nel 48» non ci può più andare, Israele non gli ha più concesso il permesso d’ingresso. Padre di un combattente arrestato e zio di un martire membro delle Brigate di Tulkarem, probabilmente il permesso di lavoro non lo vedrà mai più. Una delle varie forme di vendetta di Tel Aviv verso le famiglie dei membri della resistenza: togliere – oltre a figli e nipoti – anche le possibilità di sostentamento economico.
La faccia di quel ragazzo, capelli rasati, fascia bianca sulla fronte, mi pare familiare. In effetti, per le strade di Tulkarem l’ho già vista, diverse volte. «Jihad Shehadeh è cresciuto qui. Per vari anni è stato con noi. Suo padre è stato in carcere per 15 anni». Ci mostrano le foto di due bambini che ridono a crepapelle. Jihad e Ibrahim erano come fratelli. Poi le foto di Jihad con Amni, poi Jihad con tutta la famiglia. Il legame tra loro era fortissimo, lo scoprirò meglio la sera, quando tra narghilè, tè e caffè le sorelle di Ibrahim e un altro cugino di Jihad mi faranno vedere video su video e mi racconteranno di quel ragazzo morto ammazzato da Israele nel novembre scorso.
Jihad l’hanno ucciso in un’imboscata in pieno giorno, nel campo profughi di Tulkarem. Mi fanno vedere il video di quando è stato ammazzato. Mi pare incredibile che ci siano video di ogni momento, anche dell’ultimo istante, dove la vita fugge via. Il filmato deve averlo fatto qualcuno che stava alla finestra lì sopra: si vede un furgone, targa palestinese, parcheggiato male di lato sulla strada. Dietro, nascosti, sei militari israeliani, i fucili puntati verso la strada. Una macchina bianca si avvicina da lontano. I militari iniziano a sparare. La macchina che viene ripetutamente colpita e sbanda. Un ragazzino lì sulla strada per terra che non si alza. Sarà uno dei feriti, un bambino di 14 anni che camminava verso casa. I quattro giovani uomini in macchina, invece, sono tutti morti.

Secondo i giornali, Jihad Maharaj Shehadeh era al comando dei gruppi di risposta rapida delle brigate di Al-Aqsa, uno dei gruppi della resistenza armata palestinese, nelle Brigate di Tulkarem. Un’altra delle persone uccise era anch’essa parte delle Brigate della città, mentre le altre due vittime non erano identificate nella resistenza. Per Israele, e per il mondo occidentale, sono nient’altro che quattro terroristi uccisi in un’operazione militare. Per la gente palestinese sono martiri, figli del popolo che hanno rinunciato alla propria vita in nome della lotta per l’indipendenza della Palestina.
Era il 6 novembre 2023. Il padre, Mehraj Shehadeh, in un’intervista ad Al Jazeera racconta una vera e propria esecuzione. Al figlio hanno sparato 68 colpi. «La sua testa era vuota. Io e il dottore l’abbiamo dovuta riempire per poterlo riconoscere. Non c’erano nemmeno gli occhi». Aggiunge Shehadeh: «Quando queste nuove generazioni cresceranno vedendo la violenza dell’occupazione – le bombe, le demolizioni, i genocidi, la morte dei loro parenti – sceglieranno a loro volta di resistere».
Non si annienta la resistenza con la violenza e con la repressione, almeno, non in Palestina. È del tutto evidente, parlando con loro. L’idea che la volontà di combattere l’occupazione israeliana con le armi sia prerogativa di gruppi terroristici è una menzogna che ci raccontiamo in Occidente, dove i palestinesi vengono divisi in due categorie: i buoni, che sono solo vittime, e i cattivi, che sono terroristi. La realtà è che la rabbia, il sentimento di rivolta e la voglia di lottare per la liberazione non fanno che crescere.
È quello che è successo anche a Ibrahim e Jihad. Bambini cresciuti respirando l’oppressione e la violenza dell’occupazione, che da giovani hanno scelto di non accettarla e di combatterla. Anche con le armi, opponendosi con la violenza dell’oppresso a quella dell’oppressore.
«Il padre di Jihad, Mehraj Shehadeh, è stato arrestato quando Jihad aveva due anni», mi racconta Nura, la cugina. «È stato condannato a 15 anni di carcere per il suo impegno nelle Brigate dei Martiri di Al-Aqsa durante la seconda Intifada». La storia della sua famiglia la narrano gli occhi orgogliosi della madre di Jihad. L’ho incontrata qualche volta, con due bimbi piccoli al seguito. Una volta proprio a casa di Ahmad e Amni. Al campo profughi di Tulkarem era in corso un raid, una delle tante incursioni con cui l’esercito israeliano sta cercando di rendere invivibili i campi profughi del nord della Cisgiordania, distruggendo le infrastrutture per forzare la gente ad andarsene. La famiglia era rimasta bloccata fuori. Si sono rifugiati a casa della sorella di Mehraj, Amni.
Jihad era il primo figlio, i fratellini piccoli avranno sei o sette anni. 18 anni di distanza tra Jihad e il secondo fratellino: poco più degli anni in cui il padre è stato rinchiuso in galera.
«Jihad provava sempre a visitare il padre in prigione. Prima con la madre, poi quando gli israeliani – ulteriore tortura per suo padre – hanno impedito alla madre le visite, con mia madre, sua zia Amni» continua Nura. «Gli israeliani cercavano sempre di fargli problemi, di disturbarlo, anche se era solo un bambino. Tornava sempre nervoso dalle visite in carcere». Quando il padre è stato rilasciato aveva 17 anni. «Ha lasciato gli studi, anche se era bravo a scuola. Ha iniziato a fare molti lavori. Era una persona tranquilla, preferiva ascoltare che parlare, entrava nel 48 illegalmente per lavorare e portare soldi a casa».
«Tra i 20 e i 24 anni è stato arrestato tre volte per vari mesi. E a 24 anni è diventato martire. Quando Amir Abu Khadiji, quello che considerano uno dei capi ideologici della lotta armata a Tulkarem, un suo amico e amico di Ibrahim, è stato ucciso, Jihad ha scelto di seguire le sue orme nella Brigata di Tulkarem. Amir l’hanno ucciso subito, per uccidere l’idea della resistenza. Jihad e altri hanno continuato la formazione del gruppo. Un’idea non si può uccidere».
Poco dopo Ibrahim è stato arrestato, e i suoi amici uccisi. Indica alcuni ragazzi che sorridono dalle foto alla parete. Ci elenca i nomi, le storie: «lui l’hanno ammazzato con un drone, a questi invece hanno sparato i soldati». Tra quegli amici uccisi c’era anche Samir, il promesso sposo di una delle sorelle di Ibrahim. Che non ha nemmeno vent’anni, ma ha già perso il compagno con cui avrebbe voluto sposarsi, il cugino, e ha il fratello in carcere. «Noi non sapevamo che Ibrahim fosse parte della resistenza. L’abbiamo scoperto quando l’hanno arrestato», continua Nura. Dopo quell’attacco Jihad ha scelto di non nascondere più la sua identità. Poi è stato arrestato dalla dall’’Autorità Palestinese per tre mesi. Quando è uscito, si è impegnato ancora di più nella costruzione della resistenza a Tulkarem.
Dopo il 7 ottobre, per quello che stava succedendo a Gaza, per gli attacchi ai campi profughi della Cisgiordania, per delle azioni repressive in particolare verso delle donne ad Al-Aqsa Mosque a Gerusalemme, il gruppo è diventato più effettivo. Ha iniziato a fare operazioni, a fare azioni armate contro le colonie israeliane, ai posti di blocco militari, a rispondere al fuoco durante gli assedi israeliani al campo rifugiati.

«Jihad dormiva per strada nell’ultimo periodo», continua Nura. «Aveva paura che i militari avrebbero potuto uccidere anche i suoi familiari in caso di una irruzione per eliminarlo in casa». Mi fa vedere delle foto. Jihad che dorme con una coperta per strada, o in macchina. «A volte, prima, dormiva a casa mia. Poi ha deciso di non farlo più. Aveva paura per me e per le mie bambine». Era un obiettivo. Lo sapeva. Nonostante tutto non è riuscito a evitare che nella sua esecuzione ammazzassero altre persone. «Era una brava persona, un giusto», dice con orgoglio. «I bambini lo amavano, lo seguivano sempre. Mi aiutava anche a mantenere mia figlia, dopo che mio marito se ne era andato».
Ci salutiamo, e le sue ultime parole, sull’uscio, sono una preghiera a raccontare questa storia in Italia: «Era un eroe, Jihad. È diventato martire per liberare la sua terra, la Palestina. Non dimenticarti di lui. Racconta la sua storia. È la storia di un partigiano».
The post Dentro la resistenza armata palestinese: le storie dei “cattivi” che i media non raccontano appeared first on L'INDIPENDENTE.