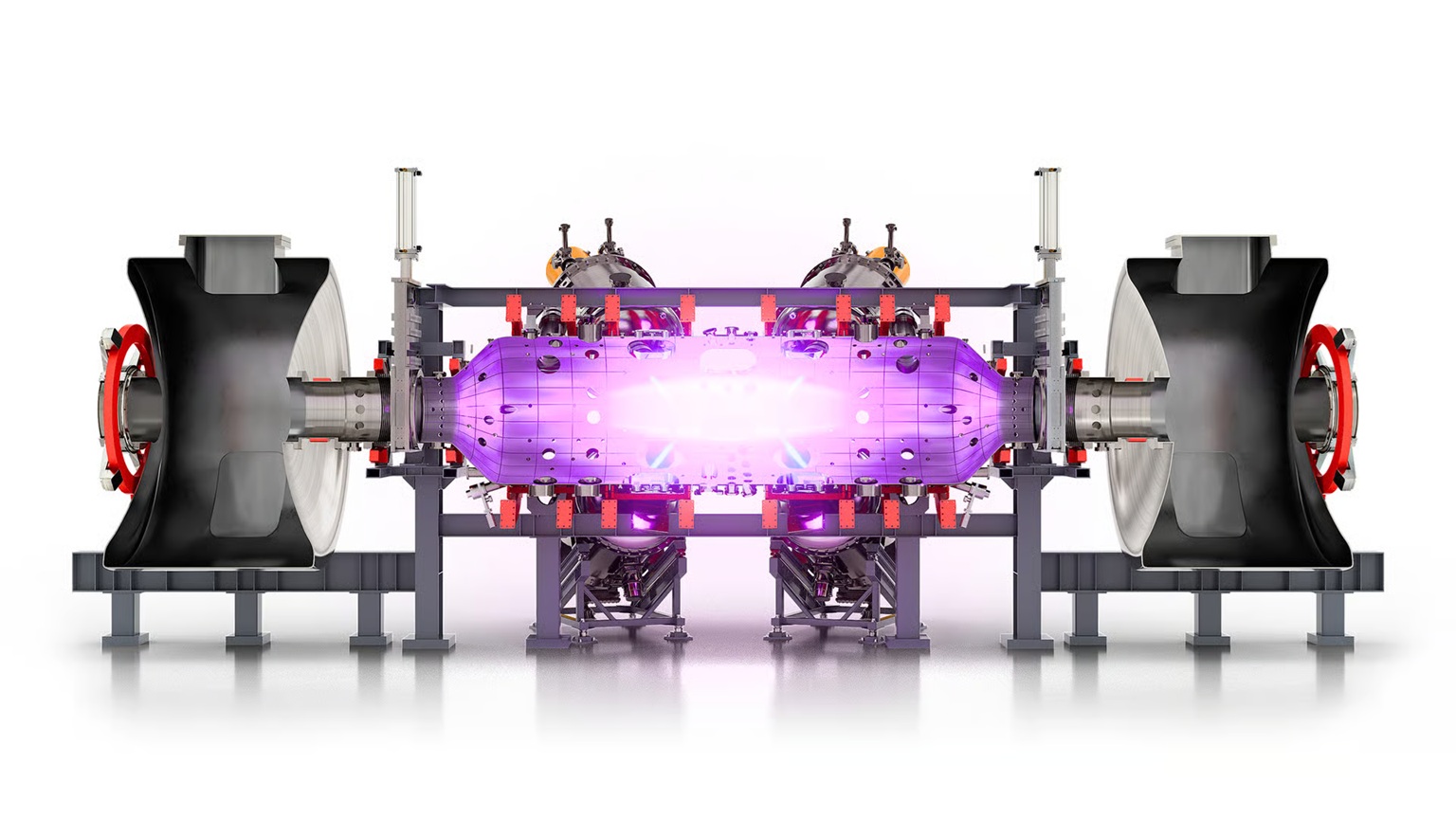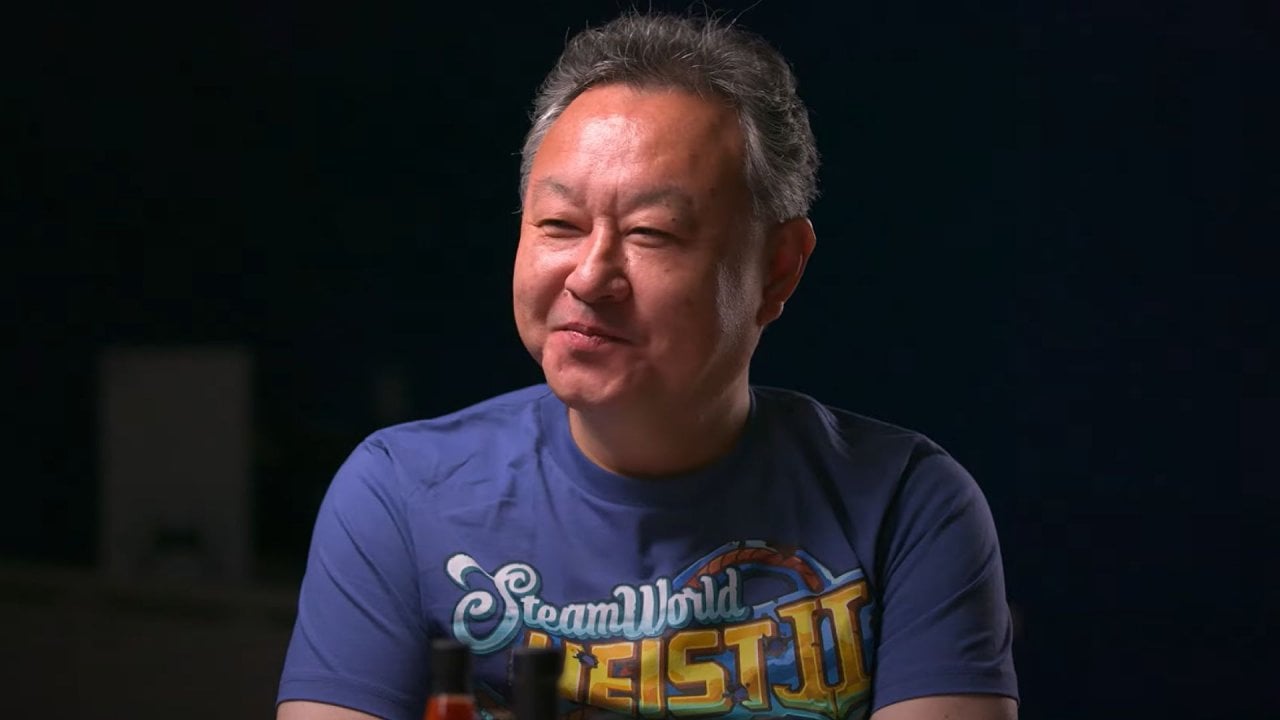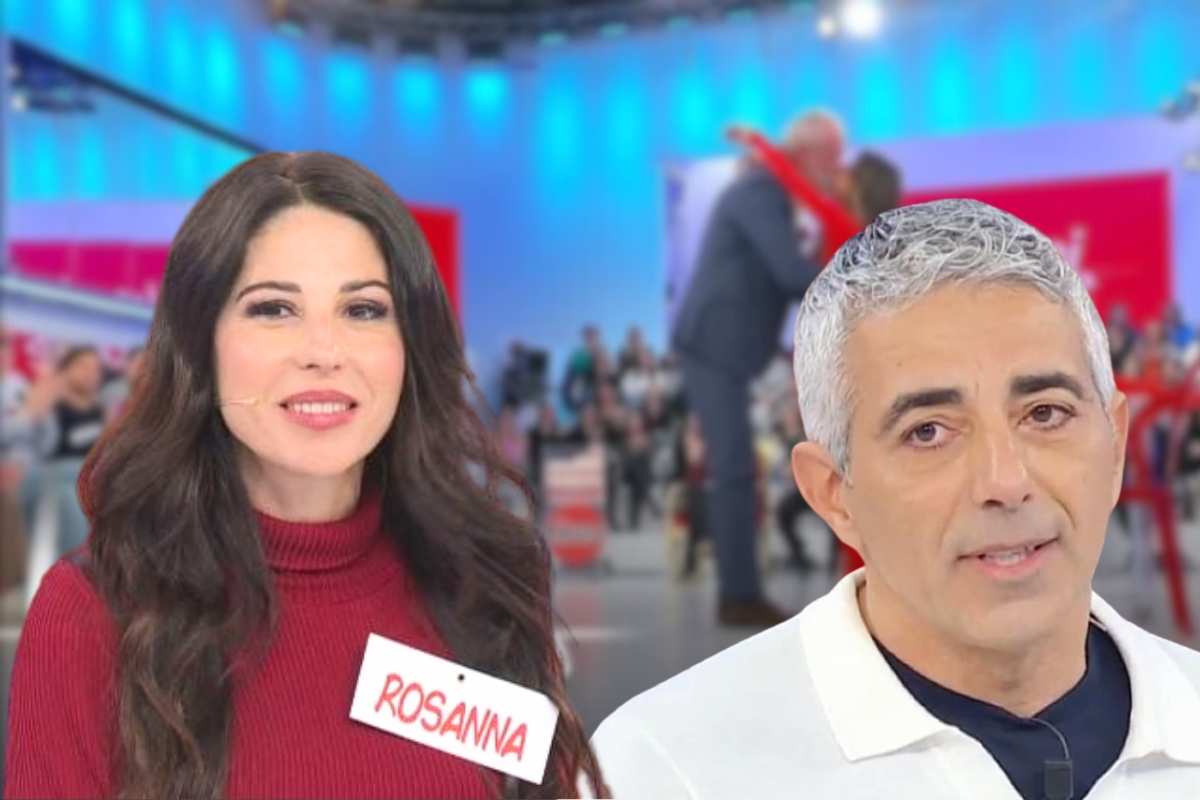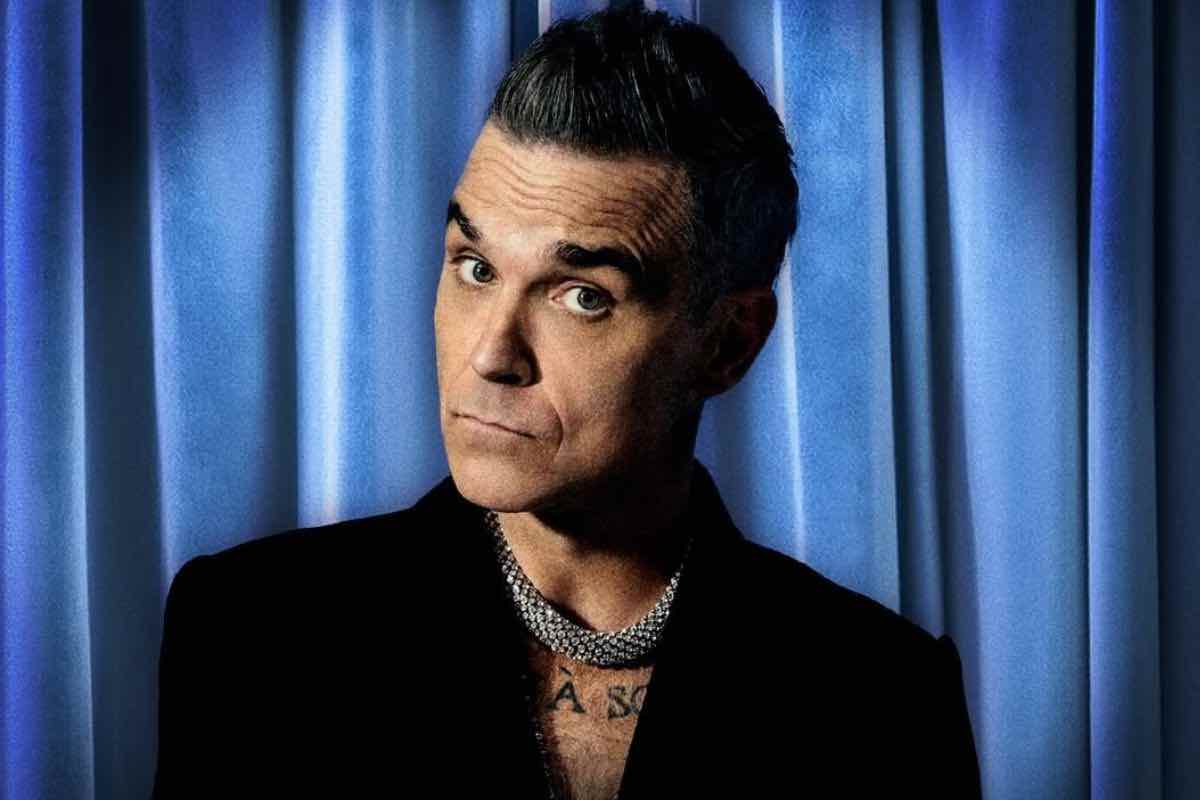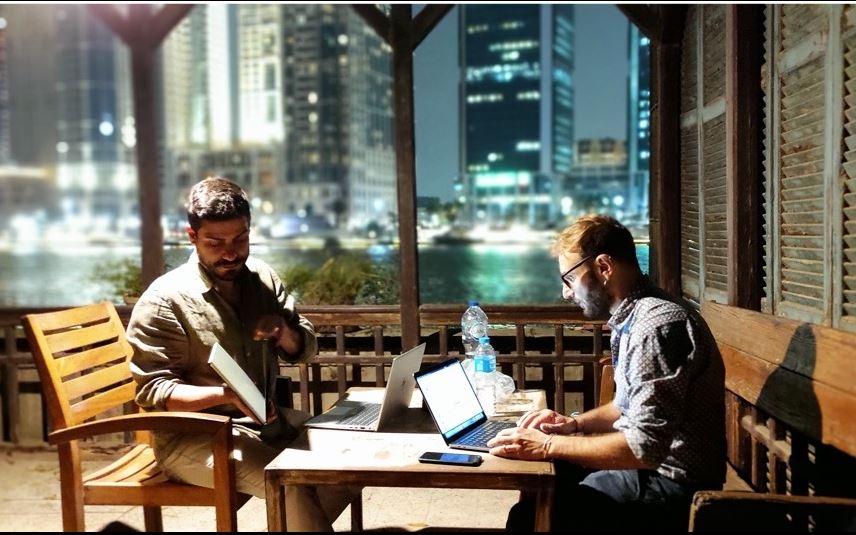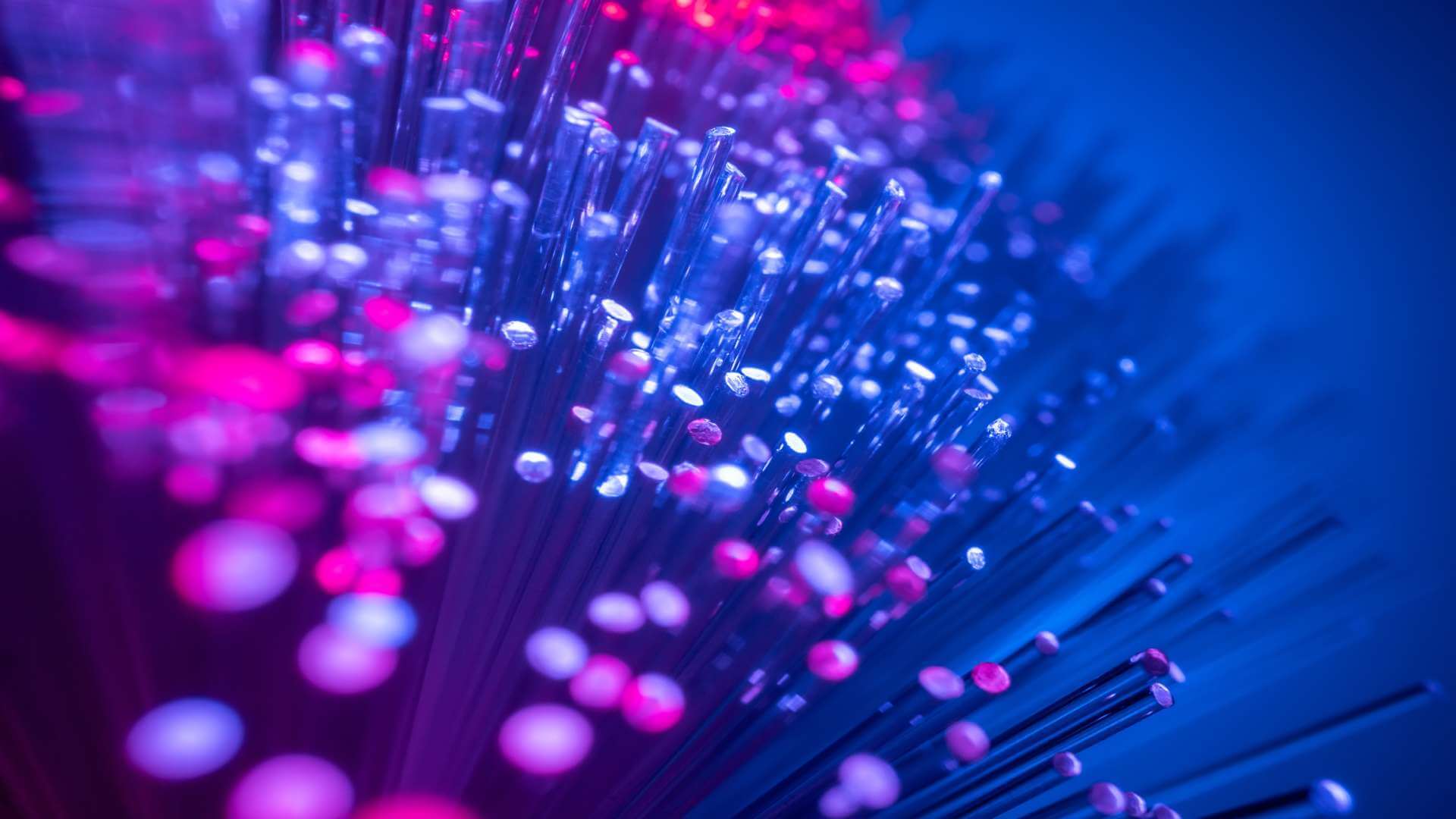Scusate cattolici (di destra e sinistra), permettete un dubbio su papa Prevost?
Questo nuovo papa piace a tutti. Segno che c’è qualcosa che non torna. Intendiamoci: per un cattolico di qualsiasi orientamento si tratta di una buona notizia, perché il pontefice dovrebbe […]

Questo nuovo papa piace a tutti. Segno che c’è qualcosa che non torna. Intendiamoci: per un cattolico di qualsiasi orientamento si tratta di una buona notizia, perché il pontefice dovrebbe incarnare l’unità della Chiesa. Con quell’emblematico “la pace sia con voi”, Robert Francis Prevost è parso invitare anzitutto alla pacificazione interna di un “corpo mistico” il quale, tuttavia, è notoriamente diviso al suo interno. Papa Francesco, con le mine che ha disseminato su vari fronti, lascia un’eredità dinamica, in divenire, ma di sicuro non unitaria. Prevost (che proprio un prevosto, cioè una seconda fila, non è, essendo stato fino a ieri l’addetto di Curia alle nomine dei vescov) ha esordito consapevole del problema, in stile andreottiano: da un lato, si è affacciato al balcone con i paramenti rossi per rassicurare i fedeli orfani di Ratzinger, dall’altro ha marcato la continuità con Bergoglio scegliendo, come primo aggettivo della “sua” Chiesa, un oltremodo significativo “sinodale” (sinonimo, alla grossa, di “democratico”) che forse rappresenta potenzialmente la novità più dirompente, a livello istituzionale. Così come, d’altro canto, lui di nascita statunitense e con gli occhi puntati addosso per i risvolti geopolitici, ha ripetuto ossessivamente la parola “pace”, aggiungendovi “disarmata e disarmante” (scelta lessicale, questa, non scontatissima), ma d’altra parte, da buon ex priore dell’ordine di Agostino d’Ippona, ha fatto vibrare il non preavalebunt (“il male non prevarrà”), che non può non essere gradito agli orecchi di chi lamenta una Santa Madre troppo poco attenta all’eterno, all’anima e alla lotta contro pape Satàn.
Ovviamente, anche il nuovo pontefice, come tutti, andrà giudicato da ciò che farà, non solo da ciò che dice. Ma è la ola che lo ha accolto a sirene trasversali, a farci venire qualche dubbio. I motivi che inducono i bergogliani, cattolici laici e pure atei, a trarne una buona impressione, sono infatti gli stessi che suscitano una sensazione di sollievo negli anti-bergogliani, tradizionalisti, fondamentalisti, conservatori (e anche qualche “ateo devoto”). In particolare uno: il nome prescelto, Leone XIV. Da destra a sinistra, se ci si perdona l’uso di queste categorie improprie, è tutto un giubilo per aver opzionato un richiamo dalle molteplici valenze: praticamente, ognuno può vederci quel che più è di suo gusto. C’è il Leone che ha fermato Attila e salvato Roma, il Leone che ha incoronato Carlo Magno, il Leone promotore della regola cluniacense, il Leone che dovette contrastare Lutero. E c’è, soprattutto, quel Leone XIII di fine Ottocento ricordato come fondatore della dottrina sociale della Chiesa per aver firmato l’enciclica Rerum Novarum. Un documento che, guarda caso, fa fare i salti di gioia a sinistra come a destra. Chissà come mai.
Per saperlo, basta rinfrescare un po’ la memoria scolastica. Gioacchino Pecci, nato nel 1810 in una famiglia della piccola nobiltà della provincia di Frosinone, era un uomo ambizioso, che fece presto carriera nella gerarchia ecclesiastica e ascese al soglio pontificio nel 1878, conscio di dover riequilibrare una nave che sotto Pio IX, il papa del Sillabo e del divieto agli italiani di partecipare alle elezioni parlamentari (non expedit), si era sbilanciata troppo in odio antimoderno. Il pontificato di Pecci fu quindi “politico” in un senso ben preciso: capì che il cattolicesimo non poteva del tutto estraniarsi dal presente, e pur ribadendo il non expedit, gettò le basi di un interventismo cattolico nella società concepito come una dépendance del papato. Sorse così l’Opera dei Congressi, che riuniva tutte le proliferanti realtà associative orbitanti attorno alla Chiesa, beninteso secondo un’idea della fede “come dottrina immutabile, stabilita una volta per tutte, che trova nel pontefice il proprio dottore e quasi il proprio oracolo” (Giovanni Miccoli, Fra mito della cristianità e secolarizzazione, Marietti 1820, 1985). E prese corpo, attraverso l’Obolo di San Pietro, una Chiesa come grande potenza finanziaria. L’obbiettivo perseguito da Leone XIII era non più vagheggiare un impossibile ritorno al potere temporale, ma clericalizzare dal basso il tessuto sociale, attraverso una vera e propria azione di egemonia. Non per nulla fu sotto di lui che fece il suo ingresso nella storia d’Italia l’Azione Cattolica, a quel tempo una sorta di “quinta colonna” papale nel Regno sabaudo. E coerentemente, fu sempre lui a lanciare una campagna di diffusione di giornali e periodici in ogni angolo della penisola, con l’Osservatore Romano come organo ufficiale d’oltretevere. E fu ancora lui, infine, a dare il via libera all’alleanza con i liberali più conservatori per la conquista delle amministrazioni comunali.
Ma verso la fine del secolo, un pericolo più insidioso rischiava di sottrarre i corpi, più che le anime, del gregge del buon Pastore: il socialismo. Non tanto nei contesti operai urbani, allora molto ridotti. Più che altro nelle campagne, tra le masse contadine. Appena eletto, Leone rispose all’allarme con un’enciclica, la Quod apostolici muneris (1878), che era un concentrato di puro reazionarismo: il “diritto di proprietà e di dominio” doveva essere mantenuto “intatto e inviolabile”, i poveri andavano tenuti “in grande onore” e aiutati purché non prendessero “in uggia il lavoro”, mentre i ricchi sarebbero stati “con eterni supplizi puniti” se non fossero venuti “in aiuto dell’indigenza”. Niente di nuovo: carità e niente di più. Qualcosa in più, invece, lo portò la famosa Rerum Novarum. Prima di tutto, va sottolineato l’anno della sua pubblicazione: 1891. Lo stesso della fondazione del Partito Socialista Italiano. In sostanza, che cosa si sosteneva in questo testo, passato agli annali come grande svolta sociale della Chiesa? Che il datore di lavoro doveva riconoscere al lavoratore la “giusta mercede”, un compenso equo, a patto che il lavoratore fosse “frugale e ben costumato”. Per il resto, ribadiva la difesa della sacra proprietà privata, condannava la lotta di classe e si poneva in antitesi rispetto a qualsiasi ipotesi di superare il capitalismo in una direzione, per dirla in termini moderni, statalista. In soldoni: in cambio di una manodopera che avrebbe dovuto restare docile e rispettosa dell’ordine costituito, il capitalista era pregato di non darsi al bieco sfruttamento. Tutto qui.
Ora, è vero che l’enciclica diede la stura al movimentismo cattolico in campo sindacale e bancario (si pensi a Giuseppe Toniolo, alle leghe bianche e alle prime casse rurali e cooperative, ispirate alla teoria di un corporativismo “terza via” fra individualismo liberale e collettivismo socialista). Ma l’impianto concettuale ed etico era di un paternalismo codino che non si capisce come possa essere visto ancor oggi come modello. Leone XII, che impose il ritorno al tomismo medievale come filosofia obbligatoria per tutti i credenti, mise all’Indice il cosiddetto “modernismo”, che altro non era che la volontà, da parte delle giovani generazioni, di studiare le scritture secondo metodi, appunto, moderni (meno significativa è la sua avversione per la massoneria, che era già da un pezzo, e rimane tuttora, considerata incompatibile con il credo cattolico). Si caratterizzò molto modernamente, invece, nel porre per la prima volta all’ordine del giorno il tema della pace, dopo secoli di papi-re, se non guerrafondai. E questo perché interpretò la sua funzione come punto di riferimento morale, sociale e quindi, per esteso, politico sul mondo intero. E per forza: non aveva più uno Stato pontificio da governare. Fu, in sintesi, un innovatore per necessità. Per senso politico. Secondo Giovanni Spadolini, papa Pecci affermò la figura del Vicario di Cristo “come arbitro della vita internazionale e sociale, difensore della pace, moderatore dei governi, ispiratore dei popoli, guida di tutte le masse dei fedeli oltre le barriere degli Stati e i confini delle nazionalità, in vista di una regalità più augusta e solenne di quella distrutta dalle truppe italiane” (Il papato socialista, Longanesi, 1982).
Della fin troppo celebrata Rerum Novarum, lo storico capo del partito socialista, Filippo Turati, disse che gli faceva immaginare “il papa trascinarsi ginocchioni dietro la borghesia”. Chiaro: oggi noi possiamo guardare a quel passaggio storico nella prospettiva di una Chiesa che nel Novecento ha fatto molti passi in avanti, quanto a “dottrina sociale”. Ma è un fatto che il “sociale” resta, sul piano dei fatti che è l’unico che ci interessa, la ruota di scorta della “dottrina”. Perfino il populista sudamericano Bergoglio, nell’apprezzabile Laudato Si’, a un certo punto pure lui “prega” la classe dirigente di convertirsi e diventare cristianamente brava e buona. E non ce lo vediamo Leone XIV sopravanzarlo, lanciandosi in battaglie d’avanguardia all’insegna di un anti-liberismo (verbale) ancora più spinto. Ecco perché Prevost, in questo suo incipit, ha generato tutta questa simpatia generale: perché non dà ragioni di antipatia. Un po’ come, nella lente deformata di una lettura superficiale, il Leone ottocentesco, mente sociale ma cuore autoritario, santino che può tornar comodo sia a una “destra” classista che a una “sinistra”, se possibile, ancora più ipocritamente classista. Alla destra, il Leone attuale sembra un restauratore, alla sinistra un continuatore. Ma di che, in entrambi i casi? Di una strutturale, insuperabile, consustanziale inefficacia della Chiesa di Roma ad agire contro il mondo. Contro questo mondo. Logico: dovendo stare in equilibrio a metà, “nel mondo ma non del mondo” come diceva Quello, il suo carattere essenziale non può che essere l’ambiguità.