Ritiro carnet assegni e sottoscrizione dei titoli in assenza di concessione di delega: richiesta di risarcimento e prova del danno.
Nota ABF, Collegio di Bologna, 9 gennaio 2025,n. 211.

Nota ABF, Collegio di Bologna, 9 gennaio 2025,n. 211.
“L’essere è oscuro se privo di apparenza; l’apparenza è inconsistente se è priva di essere.”
(Gorgia)
Un Maestro del diritto come Francesco Galgano ricorda nella sua opera “Titoli di credito” che «I titoli di credito sono materia di alta precisione concettuale; sollecitano l’impiego di una tecnica giuridica quanto mai affinata; evocano, se ci si vuole avvalere di una metafora, l’immagine della meccanica di precisione. […] È facile comprendere come una così ardua materia – «enigmistica del diritto» l’aveva definita Carnelutti – possa aver dato luogo a forti divergenze di opinioni e come la teoria del titolo di credito abbia potuto raggiungere un grado di complessità che non ha pari in altri settori della letteratura giuridica»[1]. L’incorporazione, la letteralità, l’autonomia e l’astrattezza rappresentano altrettanti requisiti fondamentali dei titoli di credito e ne garantiscono la sicura circolazione e la certezza nel prenditore di essere titolare di un credito, per l’appunto, incorporato in un documento e per così come quel credito vi è letteralmente descritto (a prescindere da vicende sottostanti). Ma, per assolvere siffatta loro essenziale funzione di certa circolazione dei crediti, tali titoli devono soggiacere a precise e puntuali regole formali definite dal legislatore. Tra l’atro, e certo non secondariamente, chi si obbliga all’adempimento dell’obbligazione recata dal titolo, deve sottoscrivere il documento e deve essere legittimato ad apporre tale firma (cfr. art. 1 n. 8 Regio Decreto 5 dicembre 1933, n. 1669 cosiddetta Legge Cambiaria e art. 1 n. 6 Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 cosiddetta Legge sugli Assegni).
Quanto sopra premesso, appare agevole constatare che – nel caso portato all’attenzione del Collegio di Bologna dell’Arbitro Bancario finanziario – la quaestio iuris inerente alla validità di assegni sottoscritti da soggetto non legittimato alla traenza del titolo (in quanto sprovvisto di delega formalmente concessa), trovi non difficile soluzione. Quegli assegni non valgono quali assegni (cfr. art. 2, primo comma, della già citata Legge sugli Assegni). Ma il punto nodale della questione sta nelle conseguenze che il Collegio felsineo trae da tale, pur indubitabile, premessa. Se quegli assegni, nonostante tale vizio formale, sono stati addebitati sul conto trassato, quali conseguenze ne derivano nel caso di specie?
Rappresentiamo il fatto riportandoci alla ricostruzione operatane dal medesimo Collegio arbitrale. “Con ricorso dd. 25.06.2024 la società ricorrente rappresenta di operare sia personalmente che quale titolare della propria ditta presso una filiale toscana dell’intermediario. Rappresenta, altresì, che per ragioni organizzative ha depositato atto di delega per le operazioni di sportello in favore di una terza signora, autorizzando quest’ultima ad effettuare soltanto versamenti. Tuttavia, la delegata chiedeva ed otteneva dall’intermediario resistente il carnet di assegni relativi al conto corrente della delegante. La ricorrente lamenta, altresì, che la delegata avrebbe emesso, pur non essendone autorizzata, molti assegni che riportano la firma della stessa delegata. I predetti assegni sarebbero stati emessi nel periodo compreso fra il 27.01.2018 e il 10.12.2019, per un totale – salvo errori – di € 227.370,94. La ricorrente chiede che siano dichiarate illegittime tutte le operazioni effettuate dalla delegata senza espressa autorizzazione e, conseguentemente, chiede la condanna dell’intermediario alla restituzione della somma di € 227.370,94”.
L’esame della delega concessa, versata in atti, conferma che essa non legittima il soggetto in questione – oltre l’effettuazione di versamenti – a richiedere il rilascio di carnet assegni e tantomeno a trarre i medesimi. Sul punto inequivoca appare la disposizione dell’art. 14 R.D. 1736/1933 il quale statuisce. “Chi appone la firma sull’assegno bancario quale rappresentante di una persona per la quale non ha il potere di agire, è obbligato per effetto dell’assegno bancario come se l’avesse firmato in proprio, e, se ha pagato, ha gli stessi diritti che avrebbe avuto il preteso rappresentato. La stessa disposizione si applica al rappresentante che abbia ecceduto i suoi poteri”. In altri termini, argomenta l’ABF, in tema di emissione di assegni da parte del delegato, condizioni per la legittima assunzione di una obbligazione cartolare in nome del correntista, a norma dell’art. 14 del R.D. n. 1736 del 1933, sono necessari “in primo luogo l’esistenza di una delega o di un potere derivante dalla legge ed inoltre, in considerazione del principio di letteralità del titolo di credito, per il quale solo ciò che in esso è scritto determina la sussistenza di qualsiasi diritto fondato sul titolo stesso, la presenza della firma e dell’indicazione della veste giuridica di delegato del titolare del conto corrente, senza dover necessariamente utilizzare terminologie tecniche ma semplicemente rendendo evidente ai terzi la spendita del nome altrui sul titolo”. In forza di tali premesse, appare obbligata la conclusione cui il Collegio arbitrale perviene: “[…] nel caso di specie, l’intermediario non ha diligentemente adempiuto ai propri obblighi in quanto, non solo ha rilasciato in più di un’occasione il carnet degli assegni del correntista ad un soggetto privo di delega, ma anche perché non ha diligentemente verificato la regolarità degli assegni emessi da un soggetto non autorizzato sul conto corrente della ricorrente”.
Dobbiamo, però, ora chiederci quali siano le conseguenze che discendono da una siffatta premessa. L’intermediario resistente, pur nulla contestando né sul rilascio dei carnet ovvero sull’emissione di assegni da parte della delegata, si è limitato a rappresentare che tali operazioni rientravano nell’attività della cliente. Dal canto suo, la ricorrente non contesta che le predette operazioni bancarie siano estranee alla propria attività. E qui sta il punto della questione. Perché, citando Gorgia, è – sì – vero che l’essere è oscuro se privo di apparenza (e l’apparenza nel caso di specie sta nel palese vizio dei titoli illegittimamente ritirati e tratti), ma è altrettanto vero che l’apparenza è inconsistente se priva di essere (e l’essere, nel caso decidendo, è da ravvisarsi nel danno che sia derivato alla ricorrente dall’illegittimità della condotta tenuta). Se volessimo stare alla sola forma, dovremmo trarne radicali conseguenze. Ed esse, a ben vedere, sono state tratte dal Collegio giudicante nella misura in cui ha riconosciuto l’illegittimità della condotta dell’intermediario nel pagamento dei titoli. Ma la forma non può e non deve essere sacrificata alla constatazione dei dati emersi dalle argomentazioni delle parti. I titoli, per quanto illegittimamente tratti, si sono concretizzati in operazioni rientranti nell’attività della cliente ricorrente. Né tale circostanza è stata contestata dalla ricorrente medesima. Torna alla mente l’insegnamento paolino della Seconda Lettera ai Corinzi: “Littera enim occidit, spiritus autem vivificat”. Può una condotta, pur illegittima, tradursi in un risarcimento del danno ove il danno concretamente non vi sia stato ovvero non ne sia stata data la prova in giudizio? Il Collegio pare non avere dubbi al riguardo: “Ferma l’illegittimità del comportamento dell’intermediario per le ragioni sopra espresse, non può però essere accolta la domanda di risarcimento formulata dalla ricorrente, la quale non ha mosso alcuna contestazione rispetto ai pagamenti che sono stati effettuati dalla delegata che comunque sono risultati a beneficio dell’attività economica della ricorrente. Pertanto, nessun danno è stato effettivamente patito dalla ricorrente o, comunque, quest’ultima non ne ha fornito prova”.[2][3]
___________________________________________________________________________________
[1] Francesco Galgano, Titoli di credito, Libro quarto: obbligazioni Artt. 1992-2027. Titoli di credito, Zanichelli 2010.
[2] Cfr, ex mutis, ABF Collegio di Roma, Decisione n. 17073 del 19 luglio 2021: “Con riguardo al merito della richiesta di risarcimento del danno viene in rilievo la regola generale dettata dall’art. 2697, co. 1, c.c., secondo cui grava sul ricorrente l’onere di fornire la prova dell’esistenza e della consistenza del danno del quale domanda il risarcimento. Nel caso di specie, il ricorrente pur lamentando dei danni non offre la prova dello specifico pregiudizio subìto; la sua richiesta, dunque, non può trovare accoglimento. Come precisato dalla stessa Suprema Corte “non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento danni, difettando non solo la prova dell’intervenuto pregiudizio e il nesso di causalità tra la condotta illegittima e il danno subito, ma anche l’ammontare dei pretesi danni subiti. Va, in proposito, ricordato il principio generale in base al quale spetta alla parte danneggiata l’onere di fornire la prova del pregiudizio in concreto subìto ai fini della determinazione quantitativa e della liquidazione del danno” (cfr. ex multis, Cass., 25 marzo 2009, n. 7211). Né tantomeno, in mancanza della relativa prova, è possibile procedere alla valutazione equitativa del danno giacché, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “la liquidazione equitativa del danno, ai sensi dell’art. 1226 c.c., presuppone che il pregiudizio economico del quale la parte reclama il risarcimento, sia certo nella sua esistenza ontologica, mentre se tale certezza non sussiste, il giudice non può procedere alla quantificazione del danno in via equitativa, non sottraendosi tale ipotesi all’applicazione del principio dell’onere della prova quale regola del giudizio, secondo il quale se l’attore non ha fornito la prova del suo diritto in giudizio la sua domanda deve essere rigettata” (così, Cass., 5 aprile 2003, n. 5375, Cass., 13 novembre 2019, n. 29330)”.
[3] Cfr., e sia pure con riguardo ad altra fattispecie, Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 25/03/2009, n. 7211. “In tema di risarcimento del danno da illegittimo protesto di assegno bancario, la semplice illegittimità del protesto (ove accertata), pur costituendo un indizio in ordine alla esistenza di un danno alla reputazione, da valutare nelle sue diverse articolazioni, non è di per sé sufficiente per la liquidazione del danno, essendo necessarie la gravità della lesione e la non futilità del danno, da provarsi anche mediante presunzioni semplici, fermo restando tuttavia l’onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi l’esistenza e l’entità del pregiudizio. (In applicazione del suddetto principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la generica domanda di risarcimento in cui si accennava a spese in sede penale e per azioni tendenti a limitare il danno, senza provarle, e senza provare altri pregiudizi patrimoniali riconducibili all’attività professionale svolta)”.


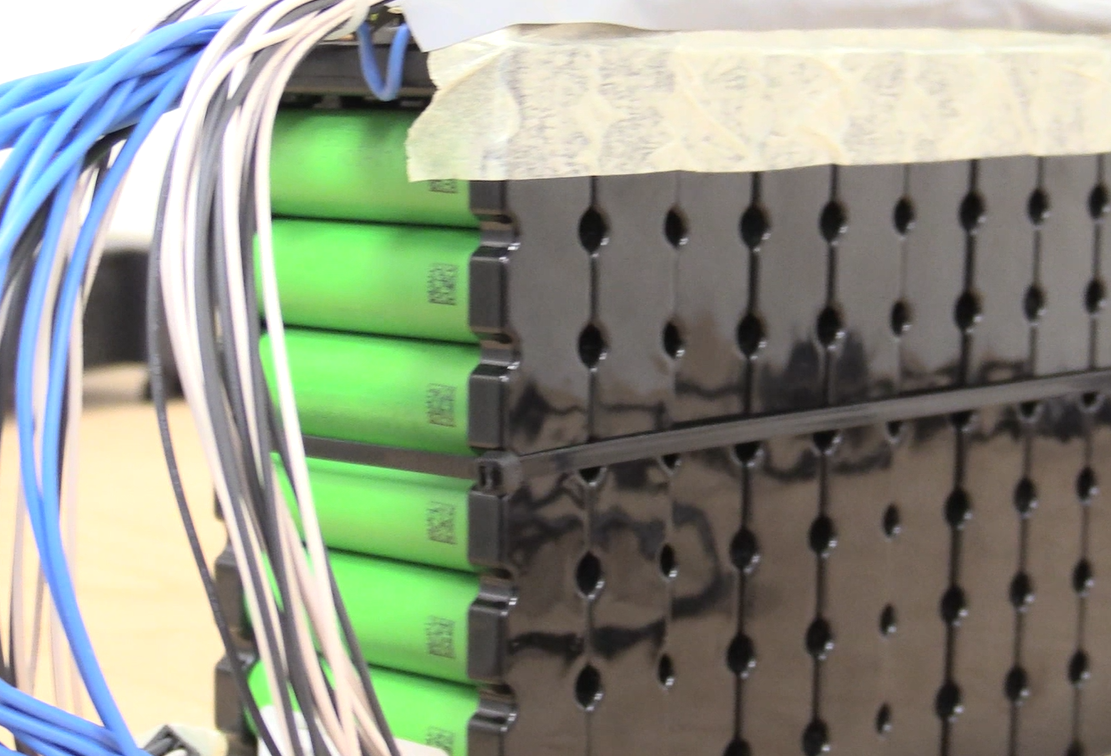











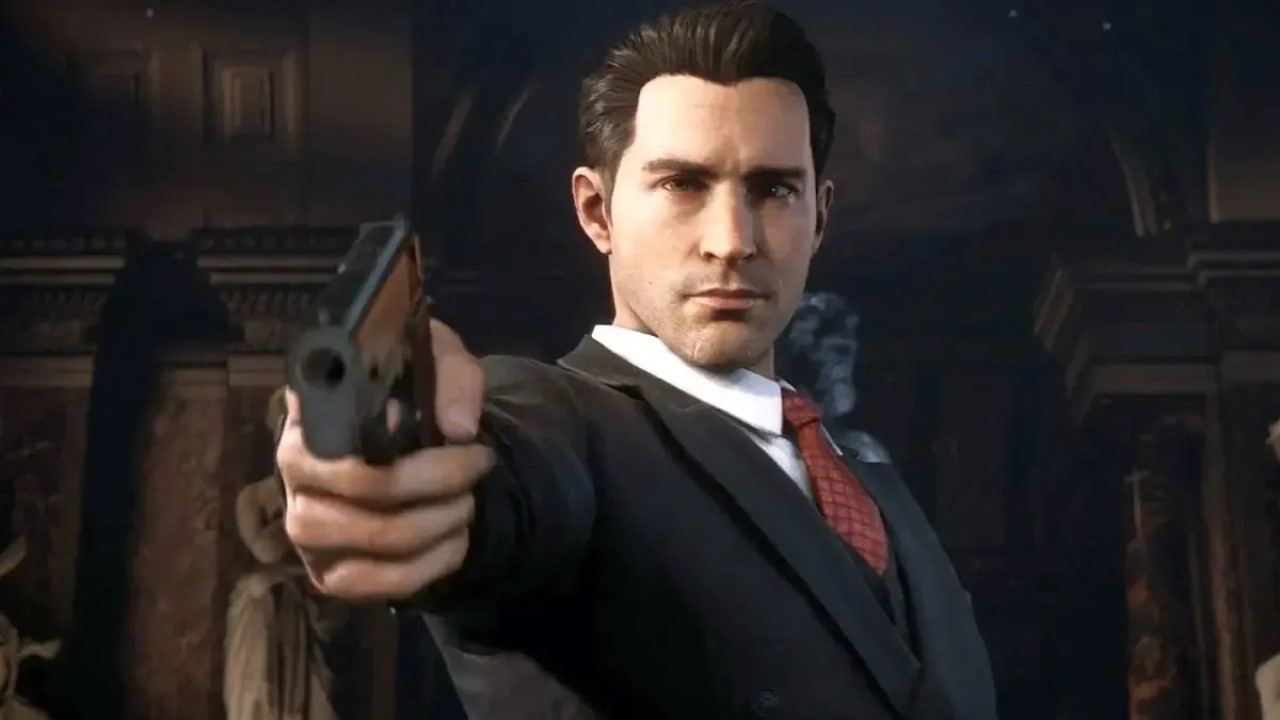

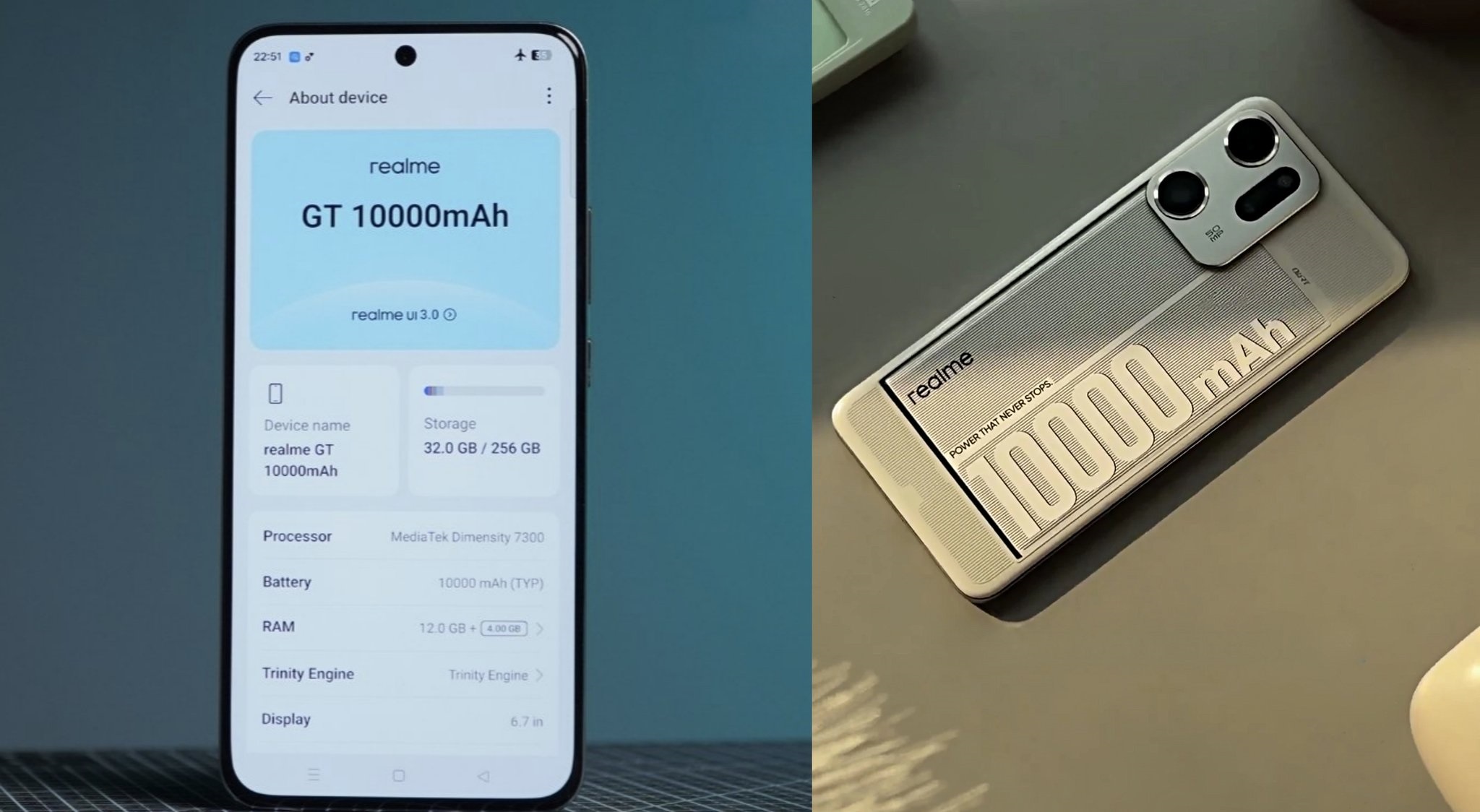



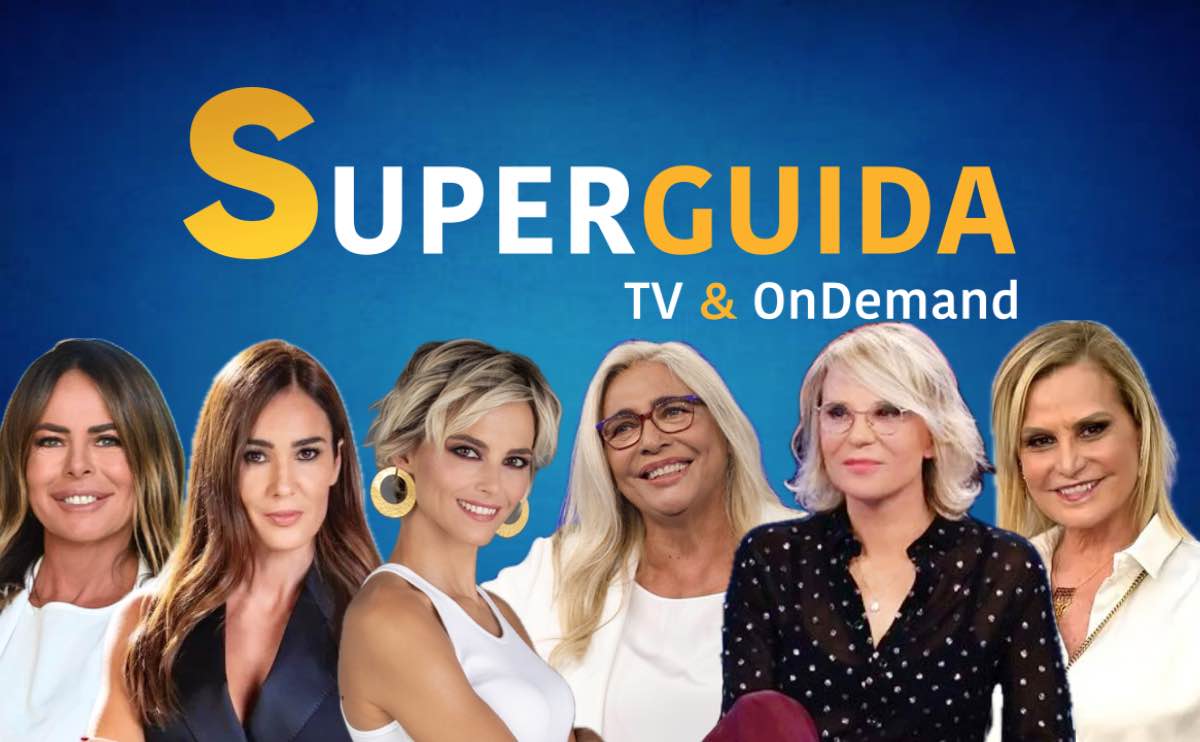



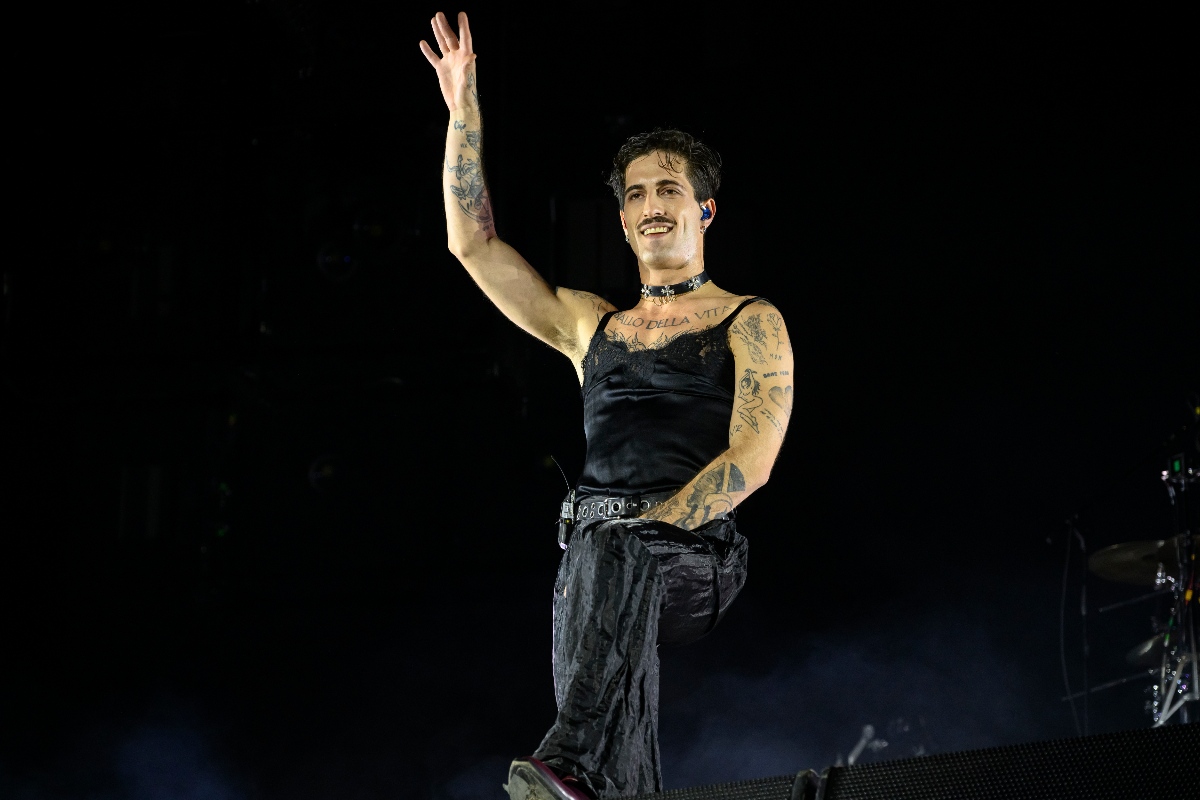











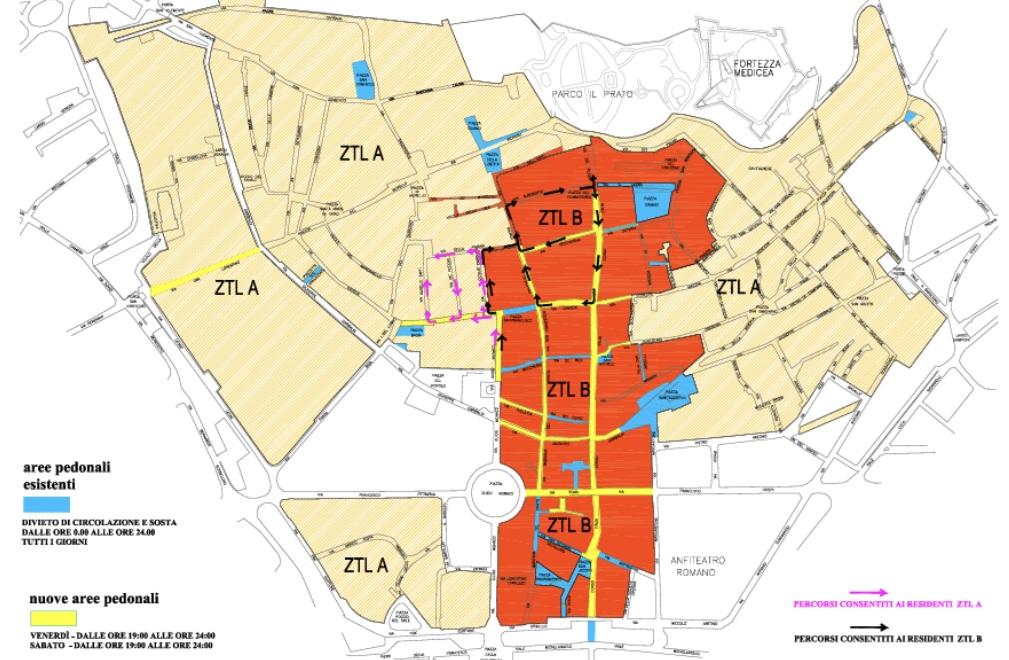














 Iscriviti alla nostra newsletter settimanale
Iscriviti alla nostra newsletter settimanale


