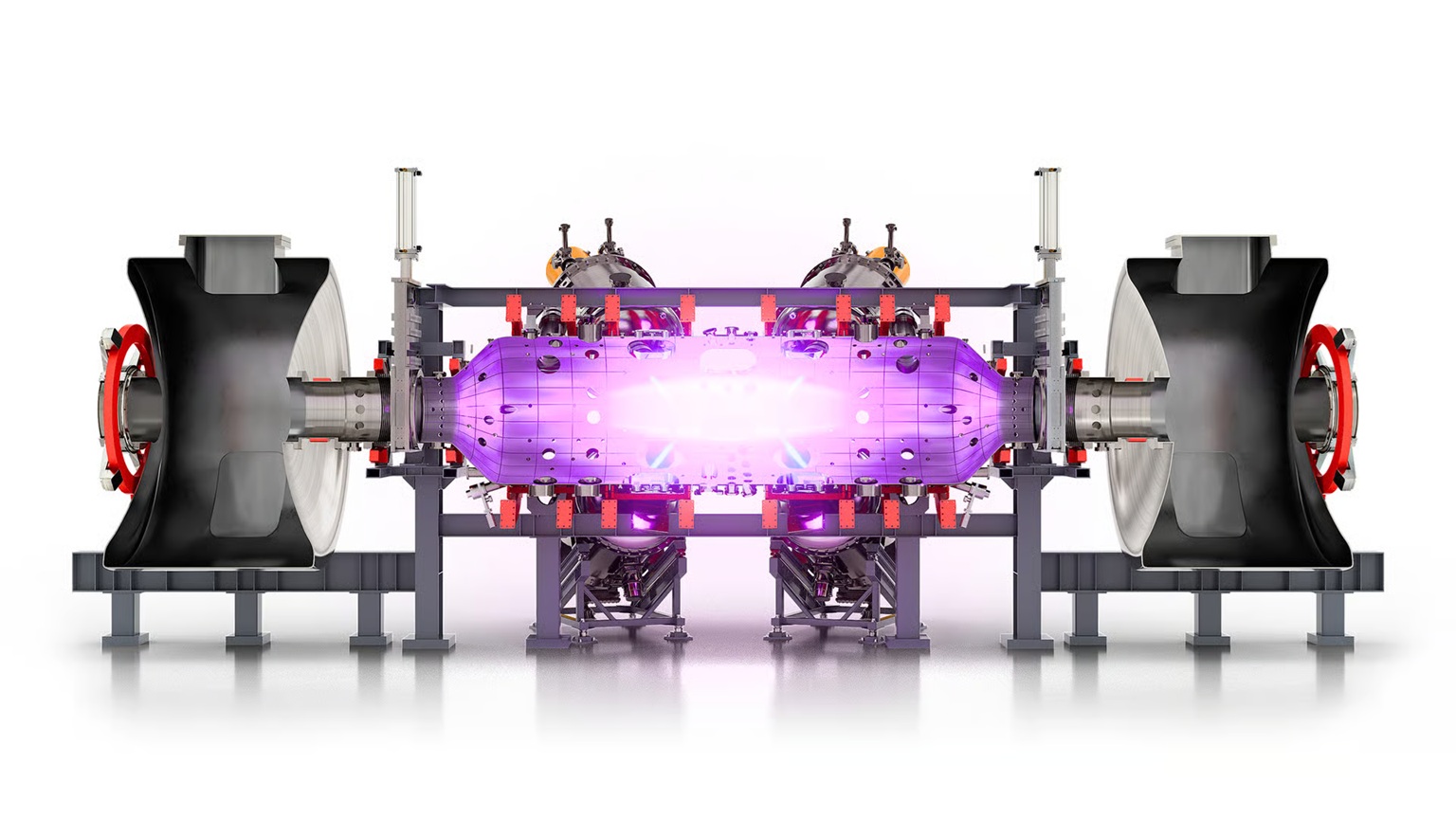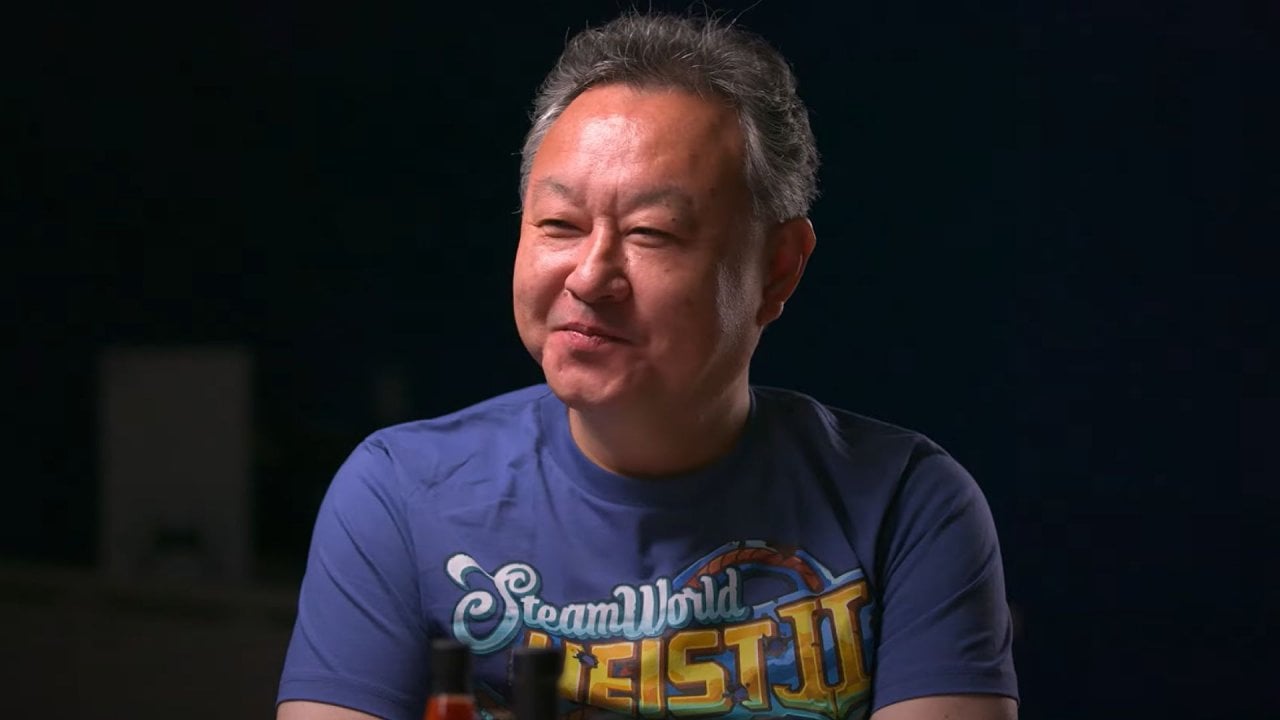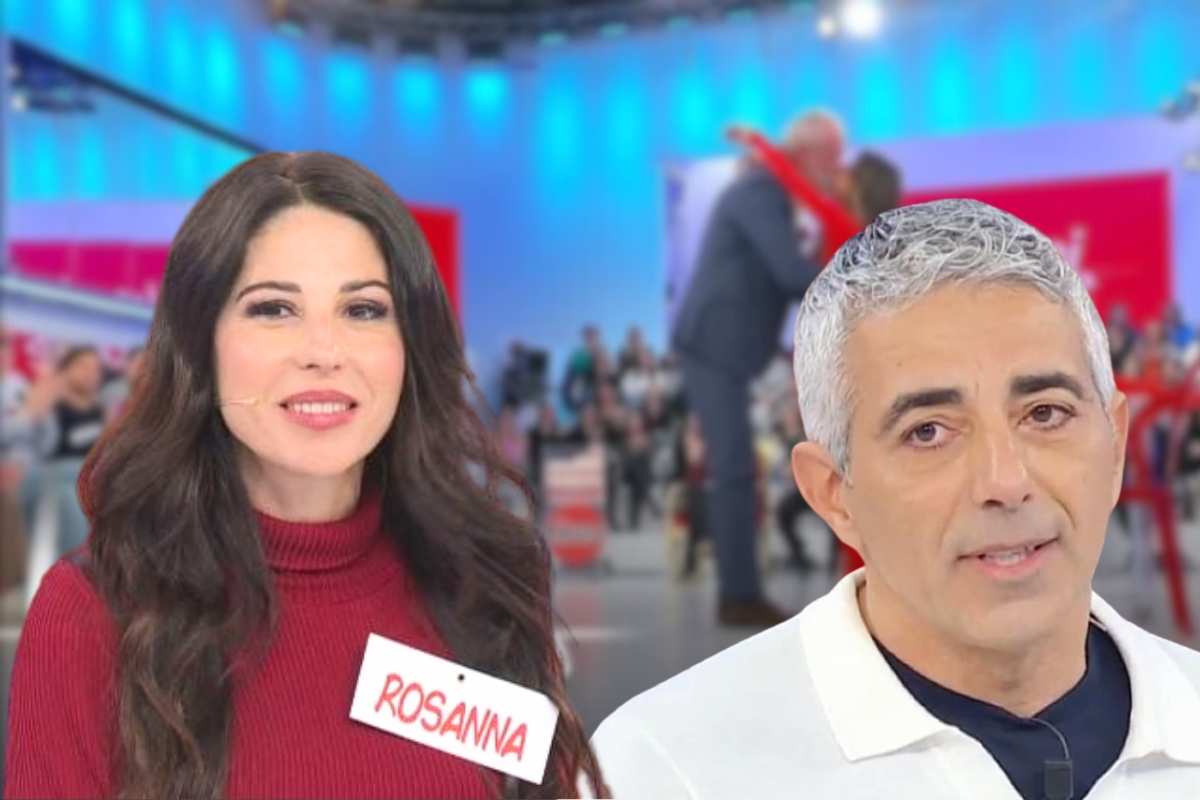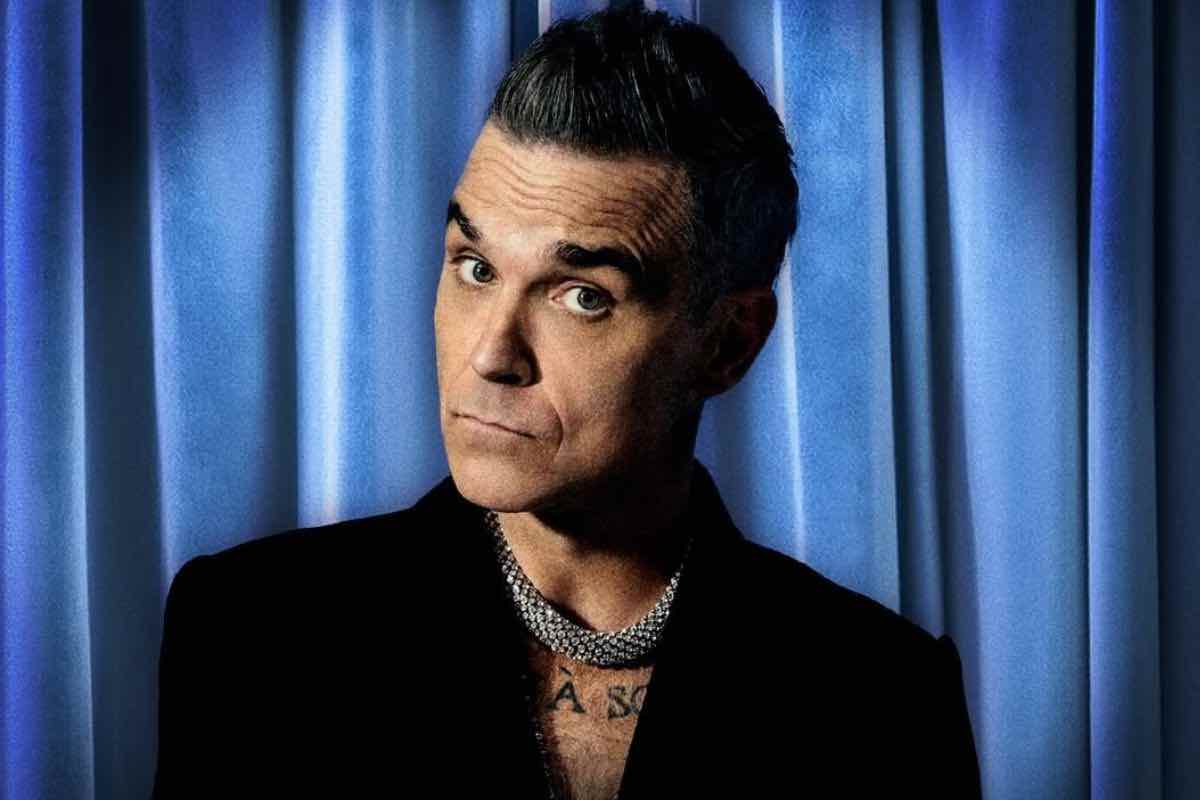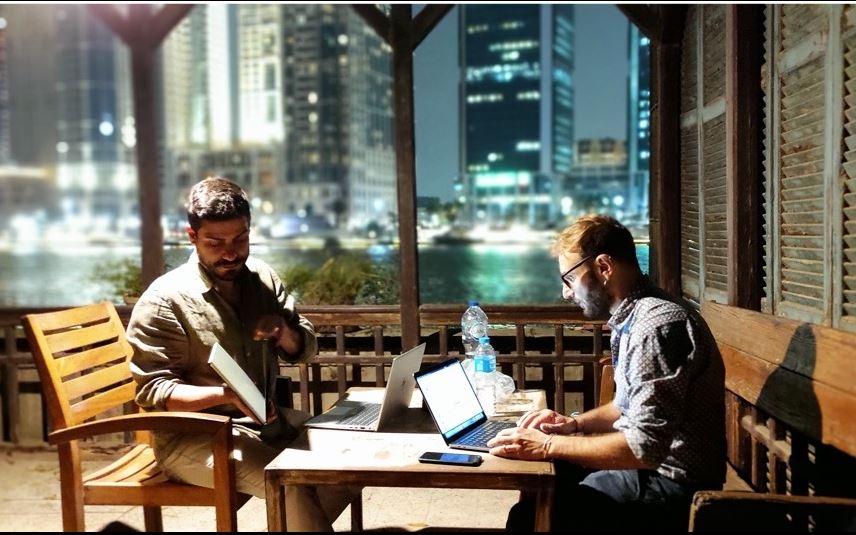Potenze di Pace: una geopolitica nonviolenta e il ruolo dell’Italia
Nel mio articolo precedente avevo riportato la prima parte del mio intervento alla Scuola di Pace di Fano lo scorso 8 marzo (Italia potenza di Pace: per una geopolitica nonviolenta […]

Nel mio articolo precedente avevo riportato la prima parte del mio intervento alla Scuola di Pace di Fano lo scorso 8 marzo (Italia potenza di Pace: per una geopolitica nonviolenta [Video], 2025). Qui di seguito, invece, riporterò la seconda parte del mio intervento, introducendo anche un argomento che dovrà essere attenzionato e approfondito maggiormente nel prossimo futuro: il ruolo che l’Italia potrebbe svolgere all’interno di questa cornice geopolitica nonviolenta.
Pace: responsabilità e cura delle relazioni
L’articolo precedente terminava con la seguente domanda: ma la guerra è veramente la nostra unica opzione?
Rifacendomi ad un libriccino di Lorenzo Biagi (2024), nell’articolo precedente avevo parlato di come nel tempo avessimo limitato il significato della parola ‘potere’ al suo significato di ‘dominio sull’altro’. La guerra e, dunque, in determinate circostanze considerare la guerra come unica opzione è in parte il risultato di questo aver ridotto il significato del termine ‘potere’. Invece, appunto, analizzando la radice della parola, sembrerebbe che all’inizio questa avesse un significato più ampio e che ciò includesse anche la presa ed esercizio di responsabilità ed anche il prendersi cura di qualcuno o qualcosa. Una cosa simile credo sia avvenuta con la parola ‘pace’, che nel tempo abbiamo un po’ frainteso (e.g., Mancini, 2025).
Infatti, normalmente quando si parla di pace, la si fa corrispondere alla firma di un accordo, alla firma di un trattato, ad una stretta di mano, cioè a degli eventi ben precisi che hanno un inizio e una fine. Invece, secondo me, la stretta di mano, la firma di un accordo o di un trattato, sono solo dei passaggi, ovvero, fanno parte della pace, ma non sono la pace, la quale, invece, è un processo continuo, da rinnovare tutti i giorni. Se la pace corrispondesse esclusivamente ad un evento ben preciso e limitato nel tempo, sarebbe difficile da spiegare perché, ad esempio, il Sudafrica sia ancora oggi tra i Paesi più violenti al mondo. Come ben sappiamo, nel periodo immediatamente dopo la fine dell’Apartheid e quindi della guerra civile, venne istituita la Commissione per la Verità e la Riconciliazione (Truth and Reconciliation Commission, TRC), presa da esempio e imitata in tante altre occasioni: per esempio, in Rwanda dopo la guerra civile che aveva portato al genocidio dei Tutsi; ma anche in un caso molto più vicino a noi e cioè il processo di riconciliazione tra il 2009 e il 2015 tra un gruppo di ex estremisti di sinistra ed un gruppo di vittime della violenza degli Anni di Piombo (Bertagna, Ceretti and Mazzucato, 2015a, 2015b). La TRC aveva raggiunto dei risultati molto positivi per la riconciliazione tra le comunità sudafricane, mettendo delle basi importanti per una rinascita più pacificata e riconciliata dell’intera società sudafricana. Tuttavia, ad oggi, dopo trent’anni anni dalla fine dell’Apartheid, nella società sudafricana permangono violenza e forti diseguaglianze. Perché?
Riflettendoci sopra, sono arrivata alla conclusione che la pace non può essere limitata alla firma di un accordo o ad una stretta di mano perché ha a che fare con i rapporti tra gli individui e, per esteso, ha a che fare con i rapporti tra i popoli. Come nelle amicizie, se la relazione tra due o più persone non viene coltivata, non viene nutrita, quella relazione col tempo si perde e può anche succedere che, con il tempo, si inasprisca. Costruire e mantenere la pace sono processi continui, che non hanno una data di scadenza, proprio come la cura e l’esercizio di responsabilità perché, infatti, né la cura né l’esercizio di responsabilità sono realmente limitate nel tempo. Possono evolversi, come tutte le cose umane, perché le entità di cui ci si prende cura e di cui si è responsabili cambiano e/o si evolvono a loro volta, ma non sono dei processi che hanno effettivamente una fine. Sì, è vero, la malattia è limitata nel tempo, però la cura non indica semplicemente curare il malato; prendersi cura, esercitare responsabilità implica un impegno costante, di tutti i giorni e anche di rinnovamento, nel senso che le azioni che poniamo in essere quotidianamente nel prenderci cura e nell’esercitare responsabilità non sono mai esattamente uguali a quelle del giorno prima perché dipendono dalle circostanze, dall’eventualità di cambiamenti, non necessariamente negativi ma che ci richiedono una modifica nel modo di prenderci cura dell’altro e di esercitare responsabilità. E così è per la pace.
Ognuno di questi processi implica necessariamente la relazione ed il dialogo con l’altro perché senza di esso non c’è né cura né esercizio di responsabilità e tanto meno c’è la pace. Senza il dialogo, si crea invece una rottura di quei legami che possono anche portare alla violenza nelle sue diverse forme: nel dominio dell’altro dal punto di vista psicologico, ma anche fisico, sia a livello individuale, che a livello collettivo, che a livello delle relazioni tra gli Stati. La guerra è sostanzialmente la rottura dei legami tra gli individui – per esempio, pensiamo alle guerre civili – ed anche la rottura dei legami tra popoli – ad esempio, pensiamo all’attuale guerra russo-ucraina. La pace invece sottintende e implica l’esistenza di un legame basato dal riconoscersi gli uni gli altri in relazioni tra pari e non di dominio. Le relazioni di dominio sono relazioni non basate sul riconoscersi come pari dal punto di vista umano; non sono relazioni basate sulla cura e l’esercizio di responsabilità. Piuttosto, sono relazioni che mirano a stabilire chi è più importante e chi è meno importante; chi è superiore e chi è inferiore. Sono basate, quindi, sullo ‘schiacciare’ in qualche modo l’altro affinché quest’ultimo faccia quello che noi pensiamo di volere che faccia (aver evidenziato in corsivo la parola ‘pensiamo’ non è un caso, ma anche questo è un argomento molto interessante che vorrebbe un suo sviluppo a sé stante) (e.g., Burton, 1979; Rosenberg, 2015).
Questo atteggiamento incrina le relazioni, le incomincia a indebolire fino a che non vengono spezzate e quando le relazioni vengono spezzate, ecco che abbiamo creato l’ambiente adatto per far scoppiare le guerre e per non farle finire. Al massimo, possono essere “congelate” (‘frozen conflicts’), come si dice nelle relazioni internazionali e come si è detto per tanto tempo del conflitto nel Caucaso del Sud o del conflitto tra le due Coree, ma porre fine alle guerre è tutta un’altra storia.
Pace: il ruolo dell’Italia
In questo contesto, che c’entra l’Italia e quale potrebbe essere il suo ruolo nella costruzione di un sistema internazionale fondato sulla pace e non più sulla guerra?
Qui voglio focalizzarmi più sulla mia esperienza personale di italiana che vive all’estero da più di dieci anni, invece che su un discorso strettamente basato su studi e discorsi accademici. Da Italiani sappiamo benissimo che la nostra cultura, a prescindere dalla regione di provenienza, è fortemente basata sulla relazione con gli altri, sul senso di comunità e sulla famiglia, che è, checché ne possiamo dire, il nucleo iniziale dove sperimentiamo e coltiviamo le relazioni. Tant’è vero che, ciò che sperimentiamo e impariamo nell’ambiente familiare in cui siamo nati e cresciuti, sia nel bene che nel male, lo riproduciamo inevitabilmente al di fuori e quindi all’interno della società in cui viviamo e in cui ci relazioniamo.
All’estero, gli italiani siamo famosi proprio per queste caratteristiche, per questa socialità, che significa anche aiutarci tra di noi, prenderci cura gli uni degli altri e quindi esercitare anche un certo grado di responsabilità. Ora, noi abbiamo molto perso queste caratteristiche per tutta una serie di motivi, tra cui quella per cui, sentendoci inferiori agli altri Paesi, pensiamo che proprio questi nostri aspetti siano aspetti da ‘deboli’ – la faccio semplice – oppure che non siano importanti o che non valgano davvero qualcosa. Tuttavia, questo modo di pensare è sempre conseguenza di quel modo di intendere la parola ‘potere’. E cioè una persona – o uno Stato, se vogliamo ampliare – viene considerato importante e rilevante solo in base al dominio che è in grado di esercitare e, dunque, al male che si può fare.
Anche se ce le siamo un po’ dimenticate queste caratteristiche o cerchiamo di nasconderle, ce le portiamo dentro di noi e inevitabilmente le mostriamo, soprattutto quando ci troviamo in contesti in cui ci rapportiamo con persone – e, per esteso, con popoli – che invece hanno caratteristiche diverse e perciò modi di fare diversi. Inoltre, sono proprio queste caratteristiche, questa ricerca non sempre esplicita della relazione con l’altro, che ci permettono di andare d’accordo sostanzialmente con tutti e di entrare in dialogo con tutti. Questo l’ho potuto appurare personalmente nei miei adesso dodici anni di esperienza all’estero in cui mi sono rapportata e continuo a rapportarmi con persone provenienti letteralmente da tutto il mondo. Finora, tutti coloro che ho conosciuto hanno sempre sottolineato come avessero in simpatia noi italiani per la nostra tendenza ad essere amichevoli con tutti; alcuni, come per esempio degli albanesi o dei ciprioti con cui mi è capitato di parlare, avevano messo in risalto alcune somiglianze culturali tra noi e loro che ci rendevano molto simili; altri addirittura, e questo è per esempio il caso di un gruppo di armeni che ho conosciuto alcuni mesi fa, considerano noi italiani loro fratelli, sempre sulla base di quegli elementi culturali che vertono attorno alla famiglia e alla comunità e che noi tendiamo a considerare molto poco. Questo naturalmente non significa che noi italiani non abbiamo i nostri difetti e che gli altri popoli non abbiano i loro pregi, anzi, tutt’altro. Quello che intendo sottolineare è che, dal punto di vista di una possibile geopolitica nonviolenta e della costruzione di un sistema internazionale di vera pace – la pace basata sul dialogo e la relazione tra pari – tra i diversi popoli che lo abitano, noi italiani dobbiamo prendere consapevolezza del fatto che abbiamo davvero una grande potenzialità, che dovremmo ri-scoprire e da cui dovremmo ri-partire.
Conclusione
Per prendere (nuovamente) consapevolezza di noi stessi, abbiamo bisogno di almeno due cose. Prima di tutto, dobbiamo necessariamente prendere consapevolezza di noi stessi e di chi siamo, sia a livello individuale che a livello collettivo. Quindi, dobbiamo smetterla, diciamo così, di cercare sempre di copiare gli altri Paesi, gli altri popoli che pensiamo erroneamente essere migliori di noi (anche perché le copie sono sempre peggiori degli originali). Dobbiamo riconoscere le cose che non vanno, risolvendo quelli che sono i nostri problemi interni, le nostre ferite, di nuovo sia a livello individuale sia collettivo, ma risolverli affrontandoli non scappando.
In secondo luogo, da un punto di vista collettivo è necessario superare le divisioni da guerra civile che ci caratterizzano, da sempre. Alcune settimane fa leggevo una recente intervista allo scrittore Giuseppe Culicchia che diceva proprio questo e cioè che gli Italiani siamo sempre in guerra civile. Lui menzionava le guerre civili del Novecento: quella dei primi anni ’20; quella tra il ’43 e il ’45, dopo l’armistizio con gli Alleati; e poi i famosissimi anni ’70. Ma pensiamo ai Guelfi (a loro volta divisi in Guelfi Bianchi e Guelfi Neri!) e ai Ghibellini e a tutte le svariate rivalità di tipo bellico tra le varie città stato, che oggi le ritroviamo in parte, anche in maniera divertente, nella rivalità tra alcune province o tra città o anche tra città all’interno delle province. In maniera un po’ ambigua ed anche contraddittoria, visto che culturalmente diamo molto valore alla comunità, queste divisioni ci hanno da sempre contraddistinto e sembra anche che le ricerchiamo continuamente, che cerchiamo di riprodurle. Infatti, come sappiamo benissimo, tutto diventa una buona scusa per identificare qualcuno come il nemico di turno, da combattere possibilmente fino al suo annichilimento.
Dunque, se vogliamo veramente dare una svolta alla nostra società, alla nostra vita, prendendone le redini invece che esserne trainati, dovremmo veramente superare queste divisioni da guerra civile, prima di tutto dentro noi stessi, per poter davvero tessere relazioni, legami e quindi poter prevenire lo scoppio di conflitti armati che non portano alla pace in nessun modo, ma solo distruzione, ponendo i semi per un’altra distruzione – perché, al contrario di quello che ci siamo detti fin dai tempi dell’antica Roma e probabilmente anche prima, armandosi sempre di più non si arriva a costruire la pace. Su questo basterebbe rileggersi la cosiddetta trappola di Tucidide o il dilemma di sicurezza di Jarvis e capiremmo benissimo perché non è attraverso l’aumento degli armamenti che la pace si può coltivare e garantire.
Perciò non più “si vis pax, para bellum”, ma piuttosto “si vis pax, para te/para nos” perché siamo noi prima di tutto a dover essere preparati e pronti a costruire la pace, ed evidentemente non lo siamo ancora.
Bibliografia
Bertagna, G., Ceretti, A. and Mazzucato, C. (2015a) Il libro dell’incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto. Guido Bertagna, Adolfo Ceretti and Claudia Mazzucato. Milan: ilSaggiatore.
Bertagna, G., Ceretti, A. and Mazzucato, C. (2015b) Il libro dell’incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto. Materiali, documenti, testimonianze, studi. Guido Bertagna, Adolfo Ceretti and Claudia Mazzucato. Milan: ilSaggiatore.
Biagi, L. (2024) Servizio contro potere. La novità di Gesù. Edizioni Messaggero Padova. Padova: Messaggero di Sant’Antonio Editrice.
Burton, J. (1979) Deviance, Terrorism & War. The Process of Solving Unsolved Social and Political Problems. Martin Robertson.
Grillo, G. and L’Indispensabile (2025) ‘Potenze di pace: una geopolitical nonviolenta’, la Fionda, 10 April. Available at: https://www.lafionda.org/2025/04/10/potenze-di-pace-una-geopolitica-nonviolenta/.
Italia potenza di Pace: per una geopolitica nonviolenta [Video] (2025). Fano, Italy (Scuola di Pace Carlo Urbani 2025). Available at: https://www.youtube.com/watch?v=G7YkNDTjV6U&t=5s.
Mancini, R. (2025) ‘Fanno un DESERTO e lo chiamano PACE! Se vuoi la PACE prepari la GUERRA?’ Available at: https://www.youtube.com/watch?v=ex4KBcyAPa4&t=14s.
Rosenberg, M.B. (2015) Nonviolent Communication: A Language of Life. 3rd edn. Encinitas, CA: PuddleDancer Press.