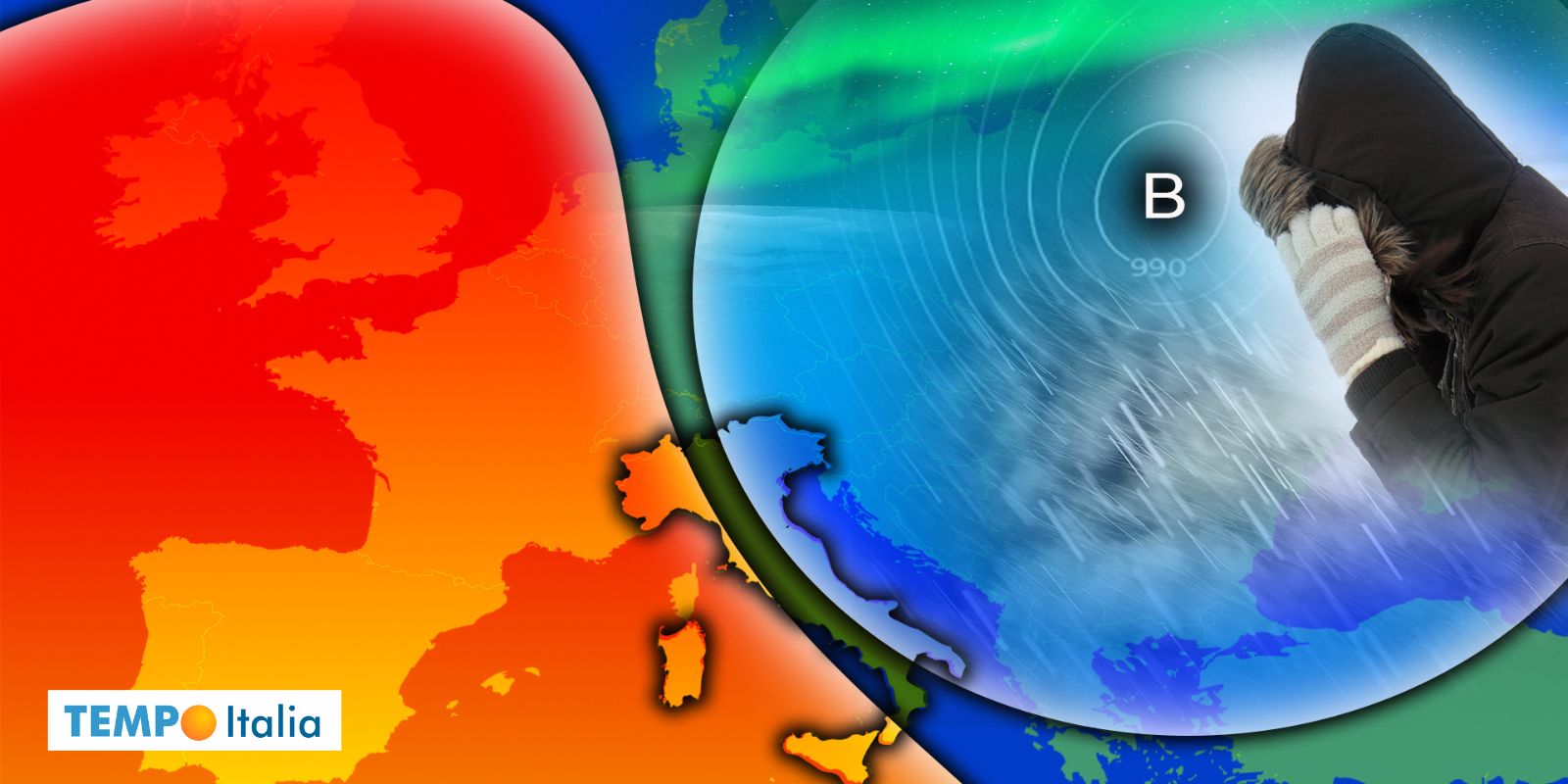Nell’epoca di Google Maps stiamo perdendo l’arte di smarrirci (di S. Mentana)
Possiamo solo immaginare quale fosse la sensazione di un viandante che, secoli fa, si imbatteva in una delle più grandi città del suo tempo, scoprendo senza guide turistiche né tanto meno app i massimi monumenti che avevano reso quel luogo famoso in tutto il mondo. Oggi, tuttavia, nel mondo iper-connesso e iper-tecnologico, dove app e […]

Possiamo solo immaginare quale fosse la sensazione di un viandante che, secoli fa, si imbatteva in una delle più grandi città del suo tempo, scoprendo senza guide turistiche né tanto meno app i massimi monumenti che avevano reso quel luogo famoso in tutto il mondo. Oggi, tuttavia, nel mondo iper-connesso e iper-tecnologico, dove app e manuali ci offrono in pochi istanti informazioni precise su come fare una certa cosa, muoverci nello spazio è qualcosa che abbiamo in gran parte delegato alle macchine: sono sempre meno, infatti, le persone che non si affidano ai Google Maps e ai TomTom di turno per conoscere la strada più rapida da un luogo all’altro. Risparmiamo probabilmente tempo, otteniamo senz’altro informazioni precise, ma in nome del controllo assoluto del percorso rinunciamo totalmente a perderci e, con esso, a scoprire cose nuove.
Per un paradosso linguistico, perdersi può essere un ottimo modo per trovare. Vagare senza una meta, sbagliare strada, può mostrarci le cose da un punto di vista diverso. Lo smarrirsi ha ispirato scrittori e filosofi, le passeggiate urbane di Walter Benjamin per Berlino lo facevano perdere tra le strade di una città come tra le pagine di un testo, facendogli così collegare la figura del flaneur, mutuata da Baudelaire, ai mutamenti sociali dell’inizio del Ventesimo secolo. Guy Debord, padre del situazionismo, fece delle sue “derive”, come chiamava le passeggiate senza meta, un’opera d’arte nonché uno studio psico-geografico, invitando chi voleva imitarlo a non seguire una meta, ma improvvisare di volta in volta in base all’ambiente circostante. Né Benjamin né Debord sapevano che un giorno sarebbero arrivati i TomTom e Google Maps, ma inconsapevolmente stavano offrendo una forma di disobbedienza ai percorsi preimpostati in nome di una continua e quasi fanciullesca scoperta.
Non è un caso che le città che offrono maggiori spunti ai flaneurs sono proprio le città complesse. Perdersi e scoprire continuamente può essere particolarmente stupefacente in città come Roma, con le sue dimensioni immense, i suoi vicoli irregolari, i suoi edifici che raccontano millenni di storia fatta di complessità e stratificazioni, può succedere a Venezia per la sua unicità, ma si può andare ben oltre esempi così noti. Si potrebbe parlare di città come Sofia, o Salonicco, le cui strade parlano popoli e dominazioni diversi, di incontri e scontri di culture che negli anni si sono tradotti in un’espressione irregolare ma affascinante in grado di lasciare stupefatti i viandanti che si perdono nei loro meandri. Non è altrettanto casuale che le città pianificate, realizzate in nome di una regolarità delle strade cadenzate di isolati e angoli retti, non offrano le stesse possibilità di stupefazione. La regolarità eccessiva, nella sua ferma volontà di non uscire dagli schemi, non sempre riesce a offrire stimoli a chi la percorre e, anzi, rischia di trasformarsi in alienazione.
E quindi ben venga la tecnologia, ben venga una strada più rapida possibile per raggiungere una meta soprattutto se si ha fretta, ma non abdichiamo alla nostra voglia di scoprire, che fa parte dell’uomo da millenni. Perdersi e vagare senza meta possono essere ancora oggi uno stimolo, e in un mondo sempre più ottimizzato, una deviazione può rappresentare un’azione creativa.