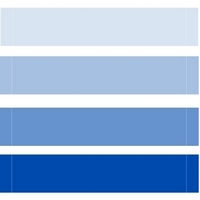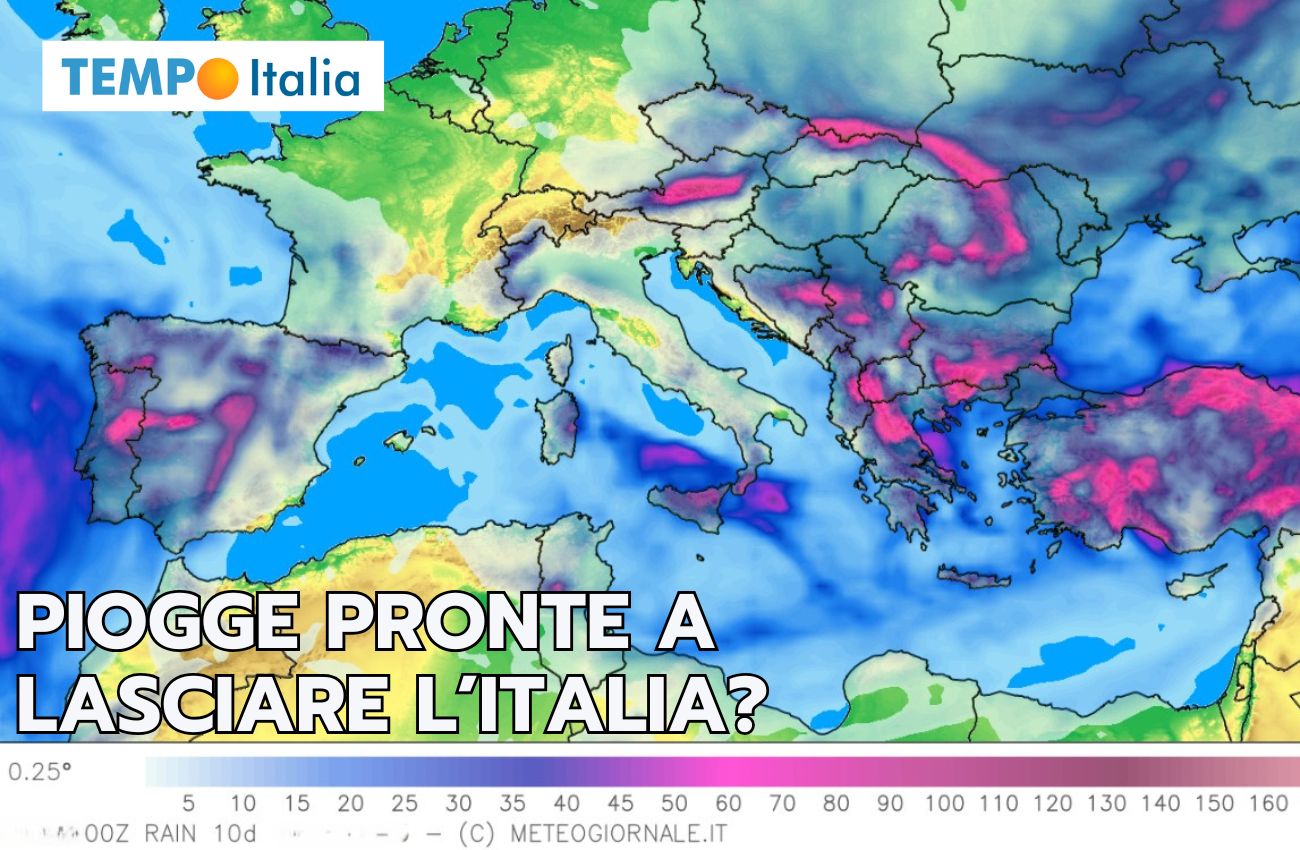Ma alla meccanica non ci si pensa?
Il 50% dell’export viene dalla metalmeccanica. «Ma per il governo la manifattura non è in cima alla lista di priorità del Paese» dice con amarezza Federico Visentin, presidente di Federmeccanica L'articolo Ma alla meccanica non ci si pensa? proviene da Economy Magazine.

Made in Italy significa soprattutto fashion e food. È quel che pensano gli italiani, come confermato da un recente sondaggio di Federmeccanica. Si sbagliano, il 50% dell’export viene proprio dalla metalmeccanica, un settore chiave della nostra economia che sta soffrendo: mentre l’export in generale flette dello 0,7%, il suo dato è peggiore, – 3,7%. «Ma i fatti dicono che per il governo la manifattura non è in cima alla lista di priorità del Paese, evidentemente ce ne sono altre» dice «con amarezza» in questa intervista a Economy Federico Visentin, presidente di Federmeccanica.
Come lei ricorda spesso, la metalmeccanica è protagonista nell’export italiano. Anche considerate le difficoltà a livello geopolitico, state ricevendo dal governo un sostegno corrispondente?
Faccio una premessa: non siamo soliti lamentarci. Come ho detto all’assemblea di Federmeccanica lo scorso settembre a Napoli, dobbiamo per primi lavorare noi per superare questa fase difficile: la mia relazione era tutta incentrata su questo. Ma una congiuntura così negativa non la vedevamo da tempo, e in questi casi è dovere dei governi intervenire senza se e senza ma. Il fatto che questo non stia avvenendo con la forza e l’efficacia necessarie ci porta a chiederci se ci sia oppure no nel governo la consapevolezza forte che l’industria manifatturiera in Italia è il valore che fa il Pil dell’economia. Si dice che la coperta è corta, ma sappiamo che se si vuole intervenire lo si fa: per esempio le spese militari sono state aumentate, se c’è un valore a cui non si può rinunciare, allora le cose si fanno.
Si riferisce al taglio del fondo automotive?
Non solo a quello. Anche qui, una premessa: tagliare quel fondo non significa fare un dispetto a Stellantis. Quando parliamo di auto in Italia dovremmo ricordarci sempre, e anche il Governo dovrebbe farlo, che non parliamo più tanto della ex Fiat, quanto di tutta la componentistica, che non è solamente metalmeccanica ed è legata alla fornitura di tutti i grandi produttori di auto. Infatti nel momento in cui la Germania frena noi lo sentiamo immediatamente, perché l’auto è una quota importante del Pil tedesco e genera grandi volumi. Ma la maggior parte delle aziende italiane di componentistica non lavora solo per l’automotive, è attiva anche in altri settori. Quindi il taglio del fondo automotive non colpisce tanto Stellantis quanto tutta la componentistica, cioè l’industria manifatturiera italiana. Il fondo varato da Draghi prevedeva un miliardo l’anno per 7 anni: aveva proprio il valore della continuità negli anni, così come è stato con il piano Industria 4.0, per dare alle imprese la possibilità di programmare. È quel che non accade con il piano Transizione 5.0, bisogna fare tutto entro il 2025, quindi la pianificazione è impossibile.
Ma è un taglio alla domanda o all’offerta?
Nell’interlocuzione con il governo era chiaro che solo una quota limitata del fondo automotive, e solo nella fase iniziale, doveva essere destinata agli incentivi alla domanda. Non possiamo riuscire a finanziare una transizione importante continuando a drogarla con gli incentivi, che ad ammissione dello stesso governo non hanno ottenuto l’effetto che si aspettava: alla fine ne abbiamo destinato la maggior parte a Tesla, e questo non ha certo aiutato la componentistica italiana. Quando c’è stato il taglio hanno detto che riguardava gli incentivi alla domanda, ma non è così: erano risorse importantissime per rafforzare la struttura manifatturiera. Ora il ministro ci dice che in qualche maniera riuscirà a recuperare 800 milioni, ma solo per il 2025, e in realtà la dotazione è di 200 milioni. Dove tirerà fuori il resto non è dato sapere. C’è molta amarezza.
E il piano Transizione 5.0?
È un’altra spina che ci ha fatto un po’ male a fine anno, perché c’era una buona aspettativa sulla semplificazione che era stata invocata a gran voce da Confindustria, e invece non è uscita con la forza dovuta. Secondo le prescrizioni dell’Ue, che ha messo a disposizione il fondo con il Pnrr, per ottenere il contributo deve essere dimostrato il risparmio energetico, il che è condivisibile, per creare un circolo virtuoso: meno consumi, quindi meno costi, meno impatto ambientale e così via. Ma per garantire questa evidenza si sono inventati delle complessità incredibili: come fai a comparare i consumi a distanza di 10 anni, un lasso di tempo durante il quale un’azienda si trasforma completamente? Siamo nella solita indeterminatezza che scatena una marea di faq, lasciando lo spazio all’Agenzia delle Entrate per andare a fare le pulci alle aziende dopo 4-5anni, magari per dire: questo modo di interpretare l’efficientamento non è corretto. È quello a cui assistiamo tutti gli anni, l’intervento ex post dell’Agenzia delle Entrate che fa la sua interpretazione delle leggi: anche questo è un fattore di inibizione. Gli impianti sono da mettere in funzione entro la fine dell’anno, e non si riesce ad ottenere una proroga a livello europeo. Il risultato è che su 6,3 miliardi di euro stanziati le prenotazioni sono attorno ai 300 milioni, meno del 5 per cento. E dire che l’incentivo è importante, copre fino al 45% dell’investimento, come la 4.0 in origine, che invece è stata abbassata al 20% con uno stanziamento di soli 1,2 miliardi, il che genererà un fenomeno click day.
Un’altra misura è quella dell’Ires premiale…
Non è uscita bene nemmeno quella, pur essendo un’altra iniziativa evocata da Confindustria. Il governo ha detto che i contributi non dovevano essere a pioggia ma con delle condizionalità, com’è giusto che sia. Per avere la riduzione del 4% dell’Ires si devono accantonare in un’apposita riserva almeno l’80% degli utili, e fin qui tutto ok; reinvestirne almeno il 30% per l’acquisto di beni strumentali ad elevato contenuto innovativo, ancora ok; ma non si deve aver fatto nemmeno un’ora di cassa integrazione nel 2024 e 2025: com’è possibile con questa congiuntura? È un modo come un altro per dire: abbiamo poche risorse, e devono andare da un’altra parte. Se si mettono questi vincoli, insomma, vuol dire che l’Ires premiale in realtà non la si vuole dare.
Secondo la vostra indagine congiunturale, sul 33% delle imprese che intende aumentare gli investimenti nel 2025 solo il 4% vuole dedicarli all’internazionalizzazione: perché?
Perché al di là del sostegno insufficiente che ricevono, la tensione geopolitica sta generando nei nostri imprenditori un grande senso incertezza che si assomma alle difficoltà dei mercati. Normalmente in un periodo di congiuntura negativa come questo gli imprenditori sanno che è il momento giusto per investire; non nella capacità produttiva perché c’è un calo dei volumi, ma nel miglioramento dei propri processi a tutto campo: efficientamento, automazione, digitalizzazione, formazione, anche internazionalizzazione. Questo non sta succedendo perché è venuta meno la fiducia sul proprio posizionamento: gli imprenditori si chiedono se il proprio business abbia senso, cercano di individuare le dinamiche globali ma faticano a capire dove andare. Oltre alle incertezze sui dazi pesa quella sul conflitto russo-ucraino. Si stanno strutturando le agenzie per la ricostruzione, ma non si vede il modo di uscirne. Quando Trump ha affermato che appena si sarebbe insediato il conflitto sarebbe terminato ha generato la speranza che il 2025 possa essere l’anno della sua chiusura. Ma ora ci si chiede: quale sarebbe il prezzo da pagare? E se fosse l’incremento della spesa militare dal 2 al 5%, quando già garantire il 2% sta facendo tagliare al governo tanti altri fondi a partire da quello per l’automotive perché la coperta è corta? Non riusciamo a fare i conti, il che continua a generare incertezza: ecco perché non ci si muove più.
L'articolo Ma alla meccanica non ci si pensa? proviene da Economy Magazine.