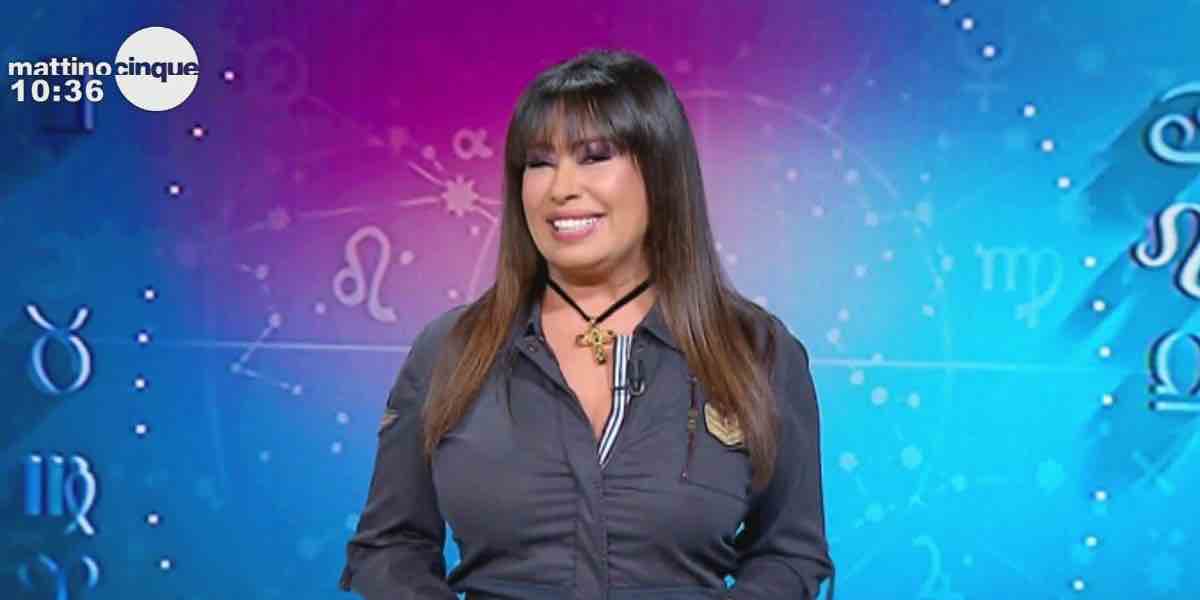L’Occidente contro sé stesso: appunti sulla russofobia europea
All’indomani dell’invasione russa dell’Ucraina nel febbraio 2022, l’Europa ha reagito come era giusto che fosse: con fermezza, condannando l’aggressione, sostenendo il diritto internazionale e offrendo aiuto a un paese vittima […]

All’indomani dell’invasione russa dell’Ucraina nel febbraio 2022, l’Europa ha reagito come era giusto che fosse: con fermezza, condannando l’aggressione, sostenendo il diritto internazionale e offrendo aiuto a un paese vittima di un atto di forza brutale. Difendere l’integrità territoriale, denunciare i crimini di guerra, proteggere i civili: tutto questo era – ed è – non solo legittimo, ma doveroso per chi si proclama custode dei valori democratici.
Tuttavia, è proprio in quel solco di legittimità che qualcosa si è storto. La condanna di un governo si è presto trasformata in sospetto verso un popolo, in una condanna culturale ed esistenziale di tutto ciò che è russo: lingua, letteratura, arte, persino le persone. Il rifiuto di una politica è diventato rigetto di una cultura. Il dissenso verso un regime ha degenerato in una fobia identitaria. Non è più (solo) Putin il nemico, ma l’essere russo tout court. È il vecchio vizio europeo: iniziare in nome dei diritti, e finire col dare la caccia alle identità.
Nel clima infuocato dei primi mesi di guerra, si sono moltiplicati gli episodi che testimoniano una transizione silenziosa ma profonda: da una posizione etica e politica a una posizione antropologica. Concerti di Čajkovskij cancellati, seminari su Dostoevskij sospesi, cori di denuncia verso musicisti, attori e scrittori russi – anche dissidenti o emigrati – per il solo fatto di essere nati sotto la bandiera sbagliata. Beninteso: criticare un governo è lecito; analizzare una guerra, doveroso; difendere un popolo aggredito, legittimo. Ma cancellare Čajkovskij dai cartelloni, sospendere le collaborazioni universitarie con accademici apolitici, diffidare di ogni cittadino russo come potenziale agente del Male, non è un gesto politico. È isteria ideologica. Si è così verificato un fenomeno ben noto agli studiosi dei conflitti: la costruzione di un nemico collettivo, non più solo politico ma quasi biologico. Il russo, in quanto tale, è divenuto sospetto. E chi, in Europa, cercava di mantenere uno sguardo complesso, veniva accusato di “putinismo interno” – il nuovo marchio d’infamia nei salotti buoni dell’Occidente liberale.
La russofobia ha prodotto un curioso effetto collaterale: ha rivelato quanto fragili siano le fondamenta culturali del cosiddetto universalismo europeo. I campioni del dialogo si sono scoperti monologanti; i difensori del pensiero critico hanno imboccato la via del conformismo. La cultura, da ponte tra civiltà, è diventata frontiera. Un luogo di esclusione.
Che cos’è Dostoevskij se non un europeo che grida l’abisso morale della modernità? Che cos’è la sinfonia russa se non un’estensione dell’anima europea in forma musicale? Rinnegare tutto questo in nome della guerra significa confondere la geopolitica con l’ontologia: non è Putin il nemico, ma l’essere russo. Come se il peccato del potere potesse lavarsi solo con la dannazione culturale.
Il clima culturale e mediatico in Europa si è imbarbarito. Gli intellettuali sono stati spinti a firmare dichiarazioni, a scegliere da che parte stare, a condannare senza riserve. Il sospetto è diventato criterio epistemico. Il dubbio, sintomo di tradimento. Ogni tentativo di articolare una posizione complessa è stato accusato di “putinismo”. Come se la fedeltà all’Europa coincidesse con l’adesione cieca alla sua propaganda.
Nel frattempo, le piattaforme mediatiche russe sono state oscurate. Non per falsità dimostrabili, ma per principio. L’Occidente liberale ha deciso che la libertà d’espressione è un diritto condizionato: valido solo se si dicono le cose giuste. Così facendo, ha reso il proprio spazio pubblico un’eco della logica che dice di combattere. Nel rigetto della Russia come entità culturale, l’Europa non ha solo tradito i suoi principi: ha rivelato il proprio impoverimento. L’umanesimo critico, l’universalismo, il dialogo interculturale – quei tratti che l’Europa ama vantare come suoi – sono stati sacrificati sull’altare della nuova ortodossia bellica.
Chi oggi rifiuta la russofobia, non per simpatia verso Putin ma per rispetto della complessità, viene percepito come traditore della civiltà. La libertà intellettuale è stata sostituita da un patriottismo culturale a senso unico, mentre la stampa si è trasformata in un bollettino morale più che in uno strumento di analisi.
Il punto non è difendere la Russia: è difendere l’Europa da sé stessa. Dalla tentazione perenne di credere che, per vincere contro il Male, tutto sia lecito. Anche cancellare la propria tradizione.
A rendere ancora più grave la russofobia europea è l’evidente doppio standard applicato nella lettura dei conflitti internazionali. E il doppiopesismo, si sa, è il primo rifugio del moralista. Basta guardare al trattamento riservato ad altri conflitti: mentre si esige dalla Russia il rispetto del diritto internazionale, si chiudono entrambi gli occhi – e a volte anche le orecchie – quando a violarlo è Israele, nel corso delle sue operazioni militari a Gaza. In quel caso, il linguaggio si fa improvvisamente cauto, la condanna diventa “preoccupazione”, e la retorica dei diritti umani si dissolve come nebbia al sole. Nessuno ha pensato di bandire musicisti israeliani, di censurare Amos Oz o di chiedere ai cittadini israeliani di firmare dichiarazioni di disconoscimento del proprio governo. Al contrario: chi critica Tel Aviv troppo apertamente viene spesso accusato di antisemitismo.
Là si chiama “legittima difesa” ciò che dura da decenni, qui si grida al tradimento culturale per ogni balbettio non bellicista. Il messaggio, implicito ma fortissimo, è questo: non è l’azione che conta, ma l’identità di chi la compie. I crimini di guerra non hanno lo stesso peso se li compie un alleato.
La russofobia, dunque, non è solo un riflesso emotivo, ma anche una scelta politica selettiva. Una forma di razzismo travestita da principio.
Sul piano strategico, la russofobia europea ha accelerato il disancoraggio della Russia dal continente e ha chiuso ogni spazio di dialogo rendendo l’Europa ancora più dipendente dalla NATO e dagli Stati Uniti. Espulsa simbolicamente dall’Europa, Mosca ha consolidato la propria postura asiatica. Cina, Iran, India, Sud globale: è lì che la Russia ha trovato ascolto e spazio. L’Occidente, nel tentativo di contenere il nemico, ha contenuto solo la propria influenza.
La spinta verso l’unanimismo euro-atlantico ha inoltre rafforzato il blocco avversario: chi non si è allineato, è stato trattato come complice. In Africa, Asia e America Latina, la narrazione europea è apparsa come il solito moralismo selettivo: molto vocale sulle guerre altrui, assai più discreta su quelle proprie. Questi paesi vedono l’ipocrisia occidentale – la facilità con cui si colpisce Mosca e la riluttanza con cui si denuncia Tel Aviv o Washington – e scelgono altre alleanze. Il prezzo della russofobia non è solo morale: è geopolitico.
In questo contesto, l’Unione Europea ha vissuto una mutazione quasi darwiniana. Nata come progetto di riconciliazione e interdipendenza, è diventata uno spazio di mobilitazione ideologica e militare. La russofobia ha agito come catalizzatore di una nuova identità: non più fondata sulla cultura e sul diritto, ma sull’allineamento strategico e sulla produzione di nemici.
Nel nome della libertà, si è giustificata la censura; nel nome della pace, la militarizzazione; nel nome della diversità, l’unanimismo. L’Europa, che doveva essere l’anti-impero, si scopre replica minore dell’Impero stesso, senza però la sua potenza.
Il tratto più tragico – e in un certo senso grottesco – di questa deriva è la confusione simbolica tra la cultura russa e la sua attuale classe dirigente. Un continente che cancella Čechov per punire Putin è un continente che ha smarrito non solo il senso delle proporzioni, ma quello della storia.
La russofobia non è la giusta risposta alla guerra: è una forma di autodistruzione culturale, un gesto compulsivo con cui l’Europa si punisce da sola per la sua impotenza geopolitica. Un continente in declino che, non sapendo più incidere sulla realtà, preferisce distruggere i simboli.
La russofobia non è solo un errore etico. È un suicidio politico e culturale. Ha privato l’Europa di una parte di sé, l’ha consegnata all’autocensura, l’ha resa meno credibile nel mondo e meno viva dentro sé stessa. Ha permesso ai suoi dirigenti di trasformare la complessità in slogan, il pensiero in sospetto, la differenza in colpa.
Invece di contenere la Russia, l’Europa ha confinato la propria intelligenza. E lo ha fatto con impeccabile eleganza burocratica, con linguaggio inclusivo e delibere perfette. Un suicidio, certo. Ma eseguito con stile.