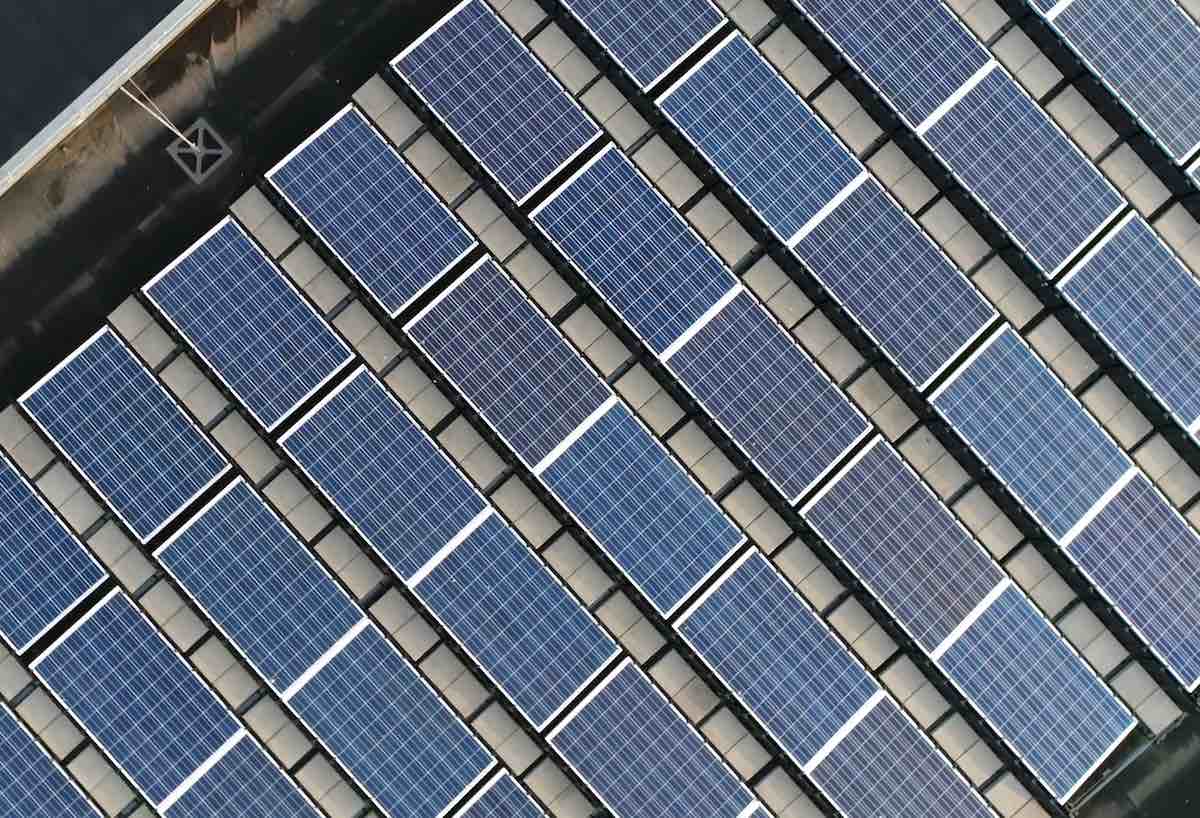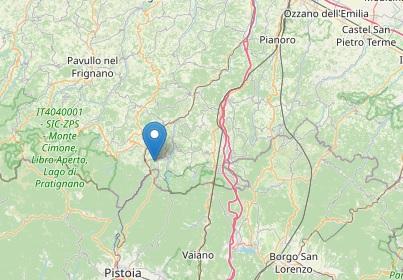In “Ari” si compie il raro miracolo in cui parole e sentimenti si sovrappongono
In un epoca in cui, per cercare di resistere al mondo, invece di mitigare le nostre resistenze ci irrigidiamo, “Ari”, film di Léonor Serraille presentato alla Berlinale, ci permette di specchiarci per ciò che siamo, nella nostra fragilità e nella nostra forza favolosa. Nella pellicola sembra compiersi il raro miracolo in cui le parole e i sentimenti, le bocche e gli sguardi si sovrappongono, per tendere una mano, non sempre con esiti felici, ma sempre con esiti concreti. L'articolo In “Ari” si compie il raro miracolo in cui parole e sentimenti si sovrappongono proviene da THE VISION.

Ci sono film che ti si infilano sotto la pelle, senza bisogno di grandi capitali, trucchi o effetti speciali, è facile che questi film si appoggino sulla scrittura, e sulla parola (veicolata per forza di cose dall’interpretazione attoriale), sul suo potere di accordare le immagini, il modo di traghettare le storie. Ari, presentato alla Berlinale di quest’anno e che sarà proiettato venerdì 9 maggio, alle 20.30, al Cinema Godard di Fondazione Prada a Milano, è uno di questi film, è non è un caso che la sua regista, Léonor Serraille, che sarà presente alla proiezione, abbia proprio studiato lettere. Si tratta di un film delicato, che non sarebbe corretto definire in sordina, perché i suoi volumi narrativi, e le sue sfumature emotive sono organizzate sapientemente, in modo da comporre una successione mirata di colori, dal pianissimo al forte, e di ritmi, dal lento al rarefatto, al concitato, intenso. A questo proposito appare evidente come la sceneggiatura sia stata scritta da Serraille su misura per un gruppo di attori dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica di Parigi.

“Quando mi è stato proposto questo progetto […] mi sono presa un po’ di tempo per conoscere la classe che mi era stata affidata. Scrivere una sceneggiatura dopo aver incontrato il cast era una prima volta per me. Mi dissero anche: ‘Sono un gruppo sensibile, vedrai, piuttosto suscettibili’”, ha dichiarato la regista. “In quella fase, anche se la mia idea iniziale era scrivere una storia sulle difficoltà dei giovani insegnanti, non ero affatto sicura di voler trattare quel tema quando incontrai gli attori: mi dicevo che volevo solo conoscerli, che nulla era deciso”. E non a caso uno dei temi cardine che sostiene tutto il film è proprio questo, quello della potenza dirompente dell’avvicinarsi all’altro, non per ottenere qualcosa di lui, ma per conoscerlo, appunto, scoprirlo, con una curiosità e attenzione così potenti da essere confuse, o sfociare, nell’erotico, nell’amore.

Il protagonista, Ari – un ventisettenne dalla fisicità forte eppure al tempo stesso sofferta, quasi fastidiosa da osservare, nel suo essere dolente, e dagli occhi di cristallo, altrettanto difficili da sostenere – dopo essere stato cacciato di casa dal padre, in seguito a una crisi avuta sul lavoro e il successivo desiderio di abbandonarlo, inizia ad andare ramingo di casa in casa di vecchie conoscenze, come in una sorta di rilettura di Broken Flowers, di Jim Jarmusch. Così Ari entra di volta in volta nelle vite degli altri coetanei, e mano a mano che i giorni passano è come se questo errare, di esistenza in esistenza, osservandole come spettatore di passaggio, eppure con uno sguardo profondamente intimo e sensibile, quasi da veggente, insopportabile per alcuni, lo guarisse, lo avvicinasse di giro in giro a se stesso, rappresentasse un incontro col suo senso del sé, con le sue emozioni negative, celate, soppresse, con i suoi valori, col suo bisogno di tenerezza, e con la consapevolezza che tutti, anche se in diverso modo, soffrono, che tutti hanno paura, soprattutto in questa epoca.


Per questo non mi ha sorpresa leggere queste parole della regista: “Sono stata colta di sorpresa dai colloqui con loro, durati tutti circa un’ora. Ho posto a ciascuno le stesse identiche domande, nello stesso ordine. Abbiamo parlato del passato, del futuro, della loro vita, dei sogni, dei ricordi dei momenti cruciali, dell’infanzia, del rapporto con il presente, del lavoro; abbiamo discusso delle loro speranze, aspettative, e di come si vedono tra dieci anni. Queste domande mi hanno fatto percepire in modo molto vivido, e in una forma molto concentrata, qualcosa che non riuscivo a nominare, qualcosa di generazionale, una sorta di angoscia, una mancanza di radicamento, note discordanti intrise di disillusione, e un bisogno di vivere con grande intensità”.
Impossibile non farsi venire in mente il cinéma-verité, con tutto il suo fascino, e più in particolare le domande che Edgar Morin e Jean Rouch ponevano in Chronique d’un été: “Come vivi? Che lavoro fai? Sei felice? C’è qualcosa in cui credi? Com’è la tua vita quotidiana?”. Sembra che faccia questo Ari, di volta in volta, ritrovando le sue conoscenze. Si avvicina agli altri in cerca di se stesso, attraverso il primo strumento che abbiamo in dotazione per rivolgerci agli altri, e comprenderli, la parola. C’è uno scambio indimenticabile in Pierrot le fou, di Godard, in cui Belmondo chiede a Karina: “Perché sei triste? Perché tu mi parli con delle parole, e io ti guardo con dei sentimenti”. Ecco in questo film sembra compiersi il raro miracolo in cui le parole e i sentimenti, le bocche e gli sguardi si sovrappongono, per tendere una mano, non sempre con esiti felici, ma sempre con esiti concreti, a differenza di quello che nella maggior parte dei casi viviamo oggi, in cui il potere delle nostre parole, e del nostro parlarci, sembra essersi completamente sfaldato, anche a causa dell’avvento del digitale, e dell’accelerazione del mondo (è inutile raccontarsela a riguardo).

Non fatevi ingannare da questo film, che – soprattutto all’inizio – sembra effettivamente rischiare di essere il classico film francese da festival, in cui, per ammissione della stessa regista “apparentemente non succede quasi nulla”, classica espressione che fa storcere le orecchie al pubblico, e in particolare al pubblico italiano. Scavalcate il pregiudizio, perché ben presto il film, proprio come Ari, inizia ad acquistare solidità, a definirsi, come una ferita che si rimargina, a essere più sicuro di sé, forte, presente, fino a trovare il coraggio di ricominciare a desiderare, a porsi come soggetto, responsabile delle proprie azioni, dei propri gesti, finché al finale ci si sente davvero guariti da qualcosa, insieme al protagonista, in pace, nonostante tutto, cambiati. La parola, lentamente, usata sapientemente, riporta in vita un animo.

“Quando si gira un film, le intenzioni evolvono lungo il percorso. Stavo facendo questo film per afferrare qualcosa,” continua la regista. “Era un po’ come una caccia al tesoro; non potevo controllare tutto e sarebbe una bugia dire che avevo un ‘piano preciso’, perché a volte ci vogliono uno o due anni per capire veramente quale sia la propria intenzione più profonda. Quello che so con certezza, però, è che volevo realizzare un film che seguisse da vicino il suo protagonista, che prendesse forma attraverso l’energia stessa dell’attore. Sentivo il bisogno di riconnettermi a certe emozioni perdute, di lavorare a un ritratto maschile che, da spettatrice, non riesco a trovare spesso nei film. Volevo anche riflettere sulla gentilezza, dopo aver letto La forza della dolcezza di Anne Dufourmantelle. E da tempo pensavo alla particolare dinamica padre-figlio in Il bambino bruciato di Stig Dagerman”.
Ari, orfano di madre, è infatti portatore di un maschile solo apparentemente fragile, estremamente sensibile, materno, eppure autentico, anche nel suo essere ferito. E mostra quanto possa essere schiacciante avvertire il peso della leggerezza del mondo, per dirla con Lucio Corsi. Ari è un bambino con un doloroso bisogno di vicinanza e dolcezza, come tutti i bambini, per questo non se l’è sentita di diventare padre quando era il momento, eppure continua a lavorare come maestro di scuola materna, circondato da bambini, incapace di resistere al bisogno di stare tra loro, perché proprio come lui, o forse lui è così perché è rimasto come loro, sono piccoli veggenti, capaci di uno sguardo limpidissimo, di vedere tutto. “Ai bambini non puoi nascondere niente,” dice Ari a suo padre. Così lo stesso Ari vede la sofferenza degli altri, le loro goffe difese – a volte rabbiose o violente –, per cercare di farle fronte, solo perché incapaci di guardarsi dentro, e poi di rivolgere lo stesso sguardo, compassionevole agli altri, unica possibile cura alla frantumazione del nostro sé, unico modo per comprendere il mondo, e di starci dentro, anche nel senso di contenerlo ed esserne contenuti, come insiemi concentrici.


“Le riprese sono state condotte con una troupe ridotta e leggera, simile a quella di un documentario ma seguendo un’impostazione da fiction classica. Un film, tra gli altri, il cui processo produttivo mi ha ispirato, è lo splendido Mai raramente a volte sempre di Eliza Hittman, girato nel 2020 per le strade di New York su pellicola 16mm. All’epoca ho rivisto Il fuoco fatuo di Louis Malle, e sono rimasta colpita dal semplice percorso ad anello del protagonista, dal suo vagare pieno di domande, dall’atmosfera e dalla possibilità di esplorare un’epoca, il presente. L’idea era anche di usare scenari reali come sfondo, quasi senza scenografia. Io e la mia troupe abbiamo cercato di creare un’organizzazione flessibile che mettesse al centro gli attori, per permettere loro di reinventare e arricchire continuamente i propri personaggi, con grande libertà, fino alla fine delle riprese. Mentre giravo, mi sono resa conto che ciò che per me era davvero più importante era filmare un attore o un’attrice mentre si avvicina sempre di più al proprio personaggio, ciò che trasferisce in esso e ciò che questo gli risveglia in cambio, in modo dialettico e imprevedibile”. I personaggi appaiono così come i paesaggi stessi del film, in maniera simile a quella che succede agli strumenti musicali nella musica da camera, o per esempio in certi film di Bergman.

Anche lo studio dei colori asseconda questo movimento centripeto, se all’inizio ci sentiamo schiacciati dai tipici cieli bianchi invernali del nord della Francia – il film è ambientato a Lille – piano piano emergono dei colori, in primis l’azzurro, colore di cui il padre di Ari, anche lui in un moto di guarigione, dipinge un vecchio muro in mattoni faccia a vista, poi il piccolo dettaglio rosso del vino e del dipinto L’uomo addormentato di Carolus-Duran, che Ari si sofferma a osservare per ore, diventando amico di un custode, e poi i tanti colori diversi dei cartoncini che alla fine del film Ari ritaglia insieme a lui, in cui i colori finalmente sono liberi di sparpagliarsi e di essere usati per creare la vita.

Sono innumerevoli poi le scene in cui Ari piange, dinamica narrativa che mi ha ricordato un’altra recentissima opera narrativa italiana, il romanzo di Enrico Dal Buono Il male maschio, che allo stesso modo si immerge nel racconto sul maschile contemporaneo, offrendone una visione fragile e al tempo stesso estrosa, a metà tra l’adulto e il bambino. Anche Andrea Occasi, proprio come Ari, piange spesso, in maniera incontenibile. Questi uomini piangono, e dormono. Come se da un lato per restare presenti a se stessi dovessero restare vigili, insonni, come se non gli fosse dato un luogo sufficientemente sicuro per riposare. Poi l’illusione, della realtà e del loro stato, si trasforma sempre di più in una visione, un modo di avvicinarsi al reale quasi da rabdomanti, finché non si passa al sogno, il rientrare in contatto con una memoria inconscia, perdonarsi, ricucendo le parti di sé, e infine spegnendosi completamente, riposando, per poi rinascere.


Così Ari, anche metaforicamente sembra ripercorrere una sorta di sviluppo amletico, metanarrativo. E in questo orizzonte, ogni contatto con gli altri, in quella particolare disposizione d’animo ultra-ricettiva in cui si trova, e in cui si trova ogni artista mentre crea, fa sì che ogni piccolo evento apra uno spazio nuovo, dia vita a un lieve spostamento che lo trasforma, e al tempo stesso gli dia l’occasione di specchiarsi nell’altro, e lasciare che l’altro si specchi in lui. Ed è questo che succede anche allo spettatore, lasciandolo senza fiato, bouleversé, si direbbe in francese, sconvolto, ma in maniera positiva, emozionato, ribaltato, e quindi diverso, che è poi ciò che ogni grande amore ci fa, e che ogni opera d’arte dovrebbe fare. Così ci arriva questo dispositivo cinematografico, come un farmaco salvavita in un epoca in cui, per cercare di resistere al mondo, invece di ammorbidirci ci irrigidiamo. Ari porta luce su tutto questo, permettendoci di specchiarci per ciò che siamo, nella nostra fragilità e nella nostra forza favolosa.
L'articolo In “Ari” si compie il raro miracolo in cui parole e sentimenti si sovrappongono proviene da THE VISION.