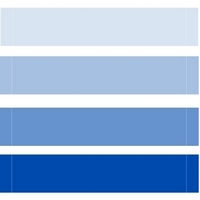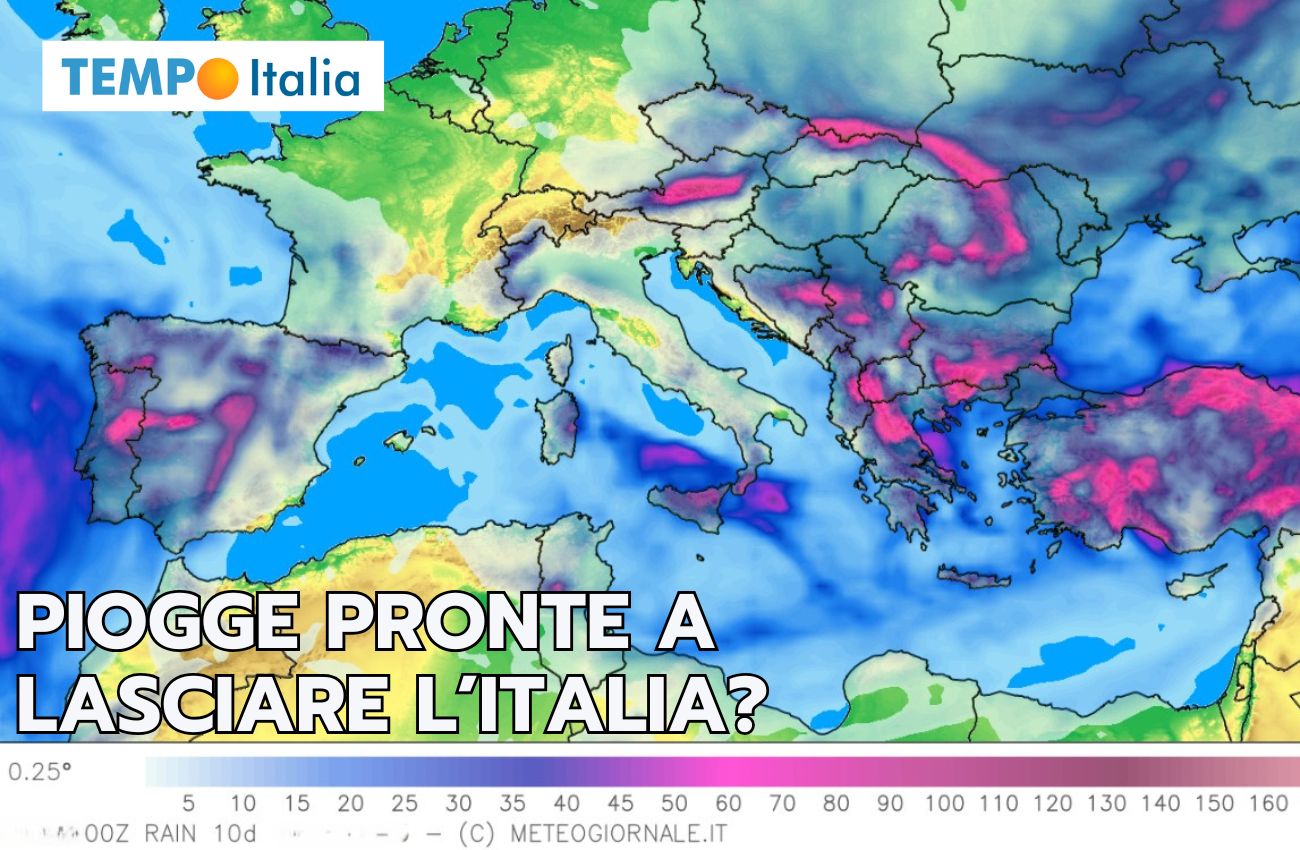Dopo anni a lamentarsi che “non si può più dire niente”, ora con Trump non si può più davvero farlo
L’amministrazione Trump ha eliminato più di duecento parole dai documenti ufficiali delle agenzie federali americane – legate a temi come la disabilità, le donne, le minoranze e il Golfo del Messico – e vietato di celebrare alcuni eventi come il Pride. Dopo anni di lamentele da parte della destra che “non si può più dire niente”, ora con Trump assistiamo alla vera cancel culture. L'articolo Dopo anni a lamentarsi che “non si può più dire niente”, ora con Trump non si può più davvero farlo proviene da THE VISION.

Quando si parla di cancel culture, spesso si crea una confusione di fondo tale da inserire il fenomeno in un macrosistema di quelli che potremmo definire i fantasmi creati dalla destra in tutto il mondo. Così, cancel culture diventa inevitabilmente “non si può più dire niente”, politicamente corretto, cultura woke o addirittura ideologia gender. In pratica un mischione di concetti, per lo più astratti o distorti, inseriti in un’unica sfera. L’intenzione della destra è quella di considerare la cancel culture, anche semanticamente, una deriva autoritaria, le cesoie che tagliano i rami della storia poco graditi ai progressisti. C’è chi è arrivato a mettere in mezzo l’iconoclastia, la damnatio memoriae, addirittura metodi dittatoriali. In realtà, analizzando il fenomeno nell’ultimo decennio, gli episodi più significativi si ricollegano a una domanda che si sono posti in tanti negli Stati Uniti: per quale motivo dovremmo avere nelle nostre piazze le statue del Robert Edward Lee di turno, ovvero di un generale razzista che durante la guerra civile americana guidava l’esercito sudista a favore della schiavitù?

Così, parecchi cittadini statunitensi, afroamericani ma non solo, hanno iniziato a manifestare chiedendo l’abbattimento di certe statue o “facendo da sé”. Negli Stati Uniti il suprematismo è ancora ben radicato nella cultura e nella società, dunque si è creata un’opposizione a una proposta più che sensata. D’altronde nessun tedesco si sognerebbe di avere una statua di Adolf Hitler ad Alexanderplatz. La rimozione di queste statue non ha “cancellato” Robert Edward Lee: resterà comunque presente su tutti i libri di Storia, ma come un generale schiavista, dunque non adatto a essere celebrato con una statua in suo onore. La vera cancel culture, se come teme la destra è legata a una deriva autoritaria, non può quindi nascere dal basso, ovvero dai cittadini che imbrattano una statua rivendicando i propri diritti identitari, ma dalle stanze del potere. E dunque colui che per anni si è autoproclamato la nemesi di questo fenomeno, Donald Trump, sta portando avanti la più grande operazione di cancel culture della storia degli Stati Uniti. E in questo caso, purtroppo, non c’è nulla di astratto.
Come documentato dal New York Times, l’amministrazione Trump ha eliminato più di duecento parole dai documenti ufficiali delle agenzie federali americane. Sono termini considerati da Trump troppo vicini alla cosiddetta cultura woke. Scorrendo l’elenco di questa Inquisizione del terzo millennio, possiamo notare che tra le parole incriminate sono presenti anche women, disability, equity, cultural differences, health disparity, pregnant person, sexuality e victim. Una distopia orwelliana non raggiunge tali vette di oscurantismo. Ovviamente sono presenti anche tutti i termini che causano più di un prurito alla destra: transgender, promote diversity, non-binary, Native american, LGBTQ, minority, intersectionality, inclusivity, immigrants, Gulf of Mexico, gender, feminism, climate crisis e anti-racism. In questo caso è il potere stesso a scegliere un linguaggio da adottare e ciò che invece va inesorabilmente censurato. Dopo anni di narrazioni basate sul nulla, possiamo dire in modo ufficiale che con la destra al potere, nello specifico con Trump negli Stati Uniti, “non si può più dire niente”.

Questo non è altro che il sogno bagnato della galassia MAGA. Non a caso l’ordine di Trump si è esteso ad altri campi. Per esempio al Pentagono, con il segretario alla Difesa Pete Hegseth che ha vietato nelle sfere militari la celebrazione del Martin Luther King Day, del Giorno della memoria e del Pride Month. Hanno seguito a ruota queste indicazioni anche i multimiliardari a sostegno di Trump. Per esempio Jeff Bezos, che ha così spiegato la nuova linea editoriale del Washington Post: “Scriveremo ogni giorno in sostegno e in difesa di due pilastri: le libertà personali e il libero mercato. I punti di vista contrari a questi pilastri saranno lasciati alla pubblicazione da parte di altri”. Meta di Mark Zuckerberg non poteva di certo sottrarsi, e dunque ha eliminato sia il programma di fact-checking dai suoi social sia quello legato alla sensibilizzazione su diversità, equità e inclusione. Le principali aziende statunitensi si stanno quindi allineando al profilo ideologico di Trump e Musk, quello per cui se non sei un uomo bianco, cristiano ed eterosessuale vieni considerato alla stregua di un eretico o di un eversore.
Pochi giorni fa, Trump se l’è presa anche con i media che lo criticano. “Scrivono il 97,6% di cose negative su di me, devono essere illegali”. Se un elettore di destra non si accorge della pericolosità di certe parole, o è in malafede o è totalmente ipnotizzato dalla propaganda. Per anni c’hanno ammorbato con la cancel culture e con il vittimismo basato sul nulla. In realtà, negli Stati Uniti come in Italia, alla destra dava fastidio non poter esternare i loro discorsi razzisti, omofobi o misogini. A parte che l’hanno ahinoi fatto lo stesso, ma poi non si può parlare di censura se ci si indigna di fronte a frasi contro gli immigrati in cui vengono descritti come merci da sbolognare o all’inneggiamento all’odio e al fascismo. Pronunciare la parola negro o frocio non è sinonimo di libertà d’espressione, bensì un tentativo di sdoganare l’insulto e la discriminazione. L’equivoco dietro il concetto di libertà di parola risiede nella volontà di certi soggetti di oltrepassare il limite etico, morale o della decenza comune per poter tirare fuori tutte le grettezze che un tempo venivano tenute dentro. Ad esempio, in nome della libertà di parola, un paio d’anni fa un candidato di Fratelli d’Italia, Antonio Di Vietri, ha scritto sui social: “Sono nazista, gli immigrati nei forni crematori”.

Adesso, per fortuna, è una frase che universalmente consideriamo vergognosa, al punto che lo stesso partito ha scaricato Di Vietri. Però fino a qualche anno fa credevamo fosse impossibile che certi politici pronunciassero altre frasi, certamente meno gravi di questa ma altrettanto discriminatorie. È come se, un passetto alla volta, venisse legittimato tutto. Magari tra qualche anno qualcuno potrà giustificare la frase di Di Vietri appellandosi a una “sua opinione”. E che facciamo, censuriamo le opinioni? Dove sta la libertà di parola in un Paese democratico?
In realtà l’unica pretesa della destra è il diritto all’odio. Hanno montato per anni l’impalcatura della cancel culture associata alle battaglie progressiste contro le discriminazioni, e adesso l’uomo più potente del mondo, nonché alleato del nostro stesso governo in carica, esclude parole legate alle minoranze dai documenti governativi. Se non volete chiamarla cancel culture possiamo benissimo usare il termine fascismo: a voi la scelta. Se invece vogliamo restare alla cancel culture indicata dalla destra in questi anni, non possiamo che notare l’ipocrisia alla base del concetto portato avanti dai soggetti in questione. Come per esempio quando si critica l’abbattimento di una statua. Eppure, uno degli atti fondativi degli Stati Uniti è legato proprio a questo gesto, quando il 9 luglio del 1776, a New York, i rivoluzionari associarono la nascita della nazione alla distruzione della statua del re d’Inghilterra Giorgio III. Quindi non si capisce perché, oggi, la rimozione della statua di uno schiavista sia deplorevole. Questo fenomeno è giunto anche in Italia, e forse il caso più eclatante riguarda alcuni episodi in cui è stata imbrattata la statua di Indro Montanelli a Milano, nei giardini che portano il suo nome.

Spesso la destra si giustifica dicendo che è necessario contestualizzare un evento ai suoi tempi, ma in quei casi la protesta contro la statua di Montanelli non era per i suoi legami giovanili con il Partito Fascista. Quelli li hanno avuti anche altri giornalisti come Giorgio Bocca e persino uomini di sinistra come Eugenio Scalfari. Non è nemmeno una questione di valore professionale, visto che si può considerare Montanelli una grande penna pur non condividendo le sue opinioni. Quella statua è stata imbrattata perché Montanelli ha comprato e sposato una bambina eritrea di dodici anni. E anche nei decenni successivi ne ha parlato senza pentimento, definendola addirittura “un animalino docile”.
Bisogna separare l’arte dall’artista, si dice spesso. Su questo sono d’accordo, considerando che tra i miei registi preferiti figura Roman Polanski, condannato per abuso sessuale su una ragazzina di tredici anni e che da decenni vive evitando di entrare negli Stati dove rischia l’estradizione. Leggo spesso, e con piacere, opere di Céline, Pound e Heidegger, tutti e tre con simpatie naziste e sentimenti antisemiti. Eppure, se mi trovassi davanti casa una statua con le loro fattezze sarei il primo a chiederne la rimozione. Quindi non ho cancellato artisti con pensieri “mostruosi” o che si sono macchiati di crimini di vario tipo. I loro libri e film devono continuare a circolare, ma non deve esserci un elogio alla loro persona con un monumento sul suolo pubblico. Mi sembra una posizione moderata, ma per la destra è cancel culture. Per me lo è eliminare le minoranze dai documenti governativi. Ovvero qualcosa di reale che si contrappone alle fantasie dei sovranisti che creano nemici immaginari. Iniziamo dunque a chiamare le cose con il proprio nome: nel 2025 il più grande alfiere della cancel culture si chiama Donald Trump, e il mondo ne sta pagando le conseguenze.
L'articolo Dopo anni a lamentarsi che “non si può più dire niente”, ora con Trump non si può più davvero farlo proviene da THE VISION.