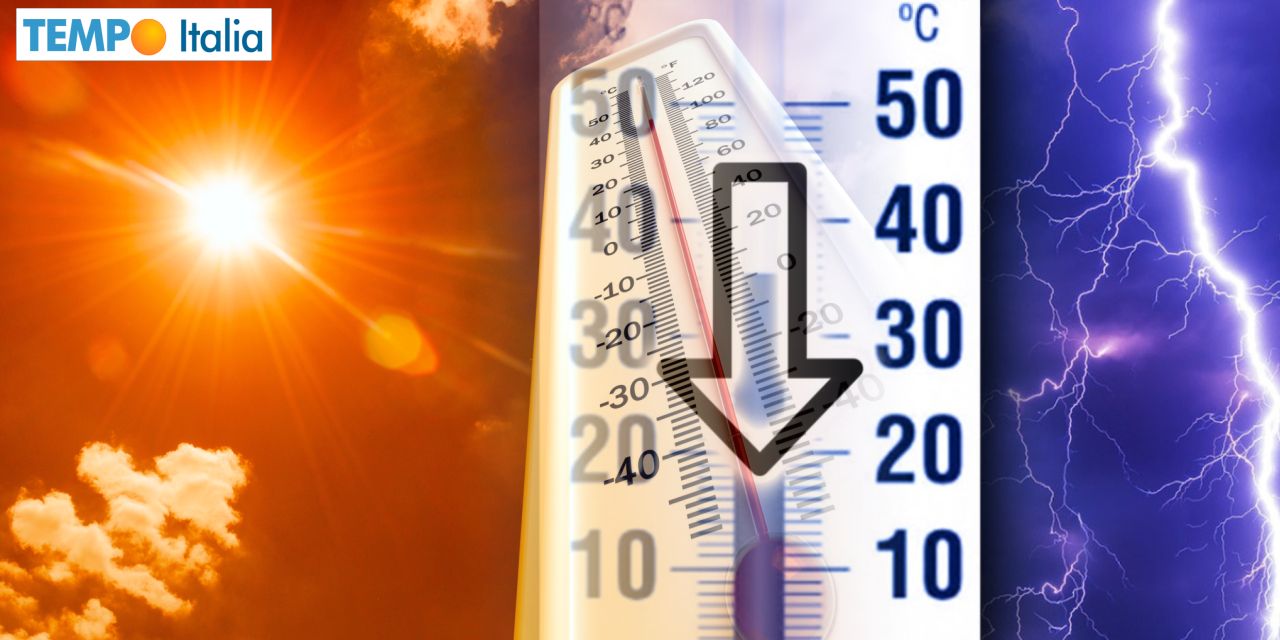Ai figli bada sempre la mamma
La cura dei figli resta a tinta rosa. Infatti, le mamme che fanno ricorso al congedo parentale (ex astensione facoltativa) sono il 57% delle lavoratrici dipendenti aventi diritto contro appena il 4% dei padri lavoratori dipendenti con lo stesso diritto. I dati sono dell’Inps, fanno riferimento al 2023 e sono suffragati dall’uso del congedo di […] L'articolo Ai figli bada sempre la mamma proviene da Iusletter.
La cura dei figli resta a tinta rosa. Infatti, le mamme che fanno ricorso al congedo parentale (ex astensione facoltativa) sono il 57% delle lavoratrici dipendenti aventi diritto contro appena il 4% dei padri lavoratori dipendenti con lo stesso diritto. I dati sono dell’Inps, fanno riferimento al 2023 e sono suffragati dall’uso del congedo di paternità da parte dei padri, introdotto da 10 anni proprio al fin di favorire, insieme al congedo parentale, una maggiore condivisione tra i genitori della conciliazione tra i tempi di lavoro e cura della famiglia. L’utilizzo del congedo di paternità è cresciuto nel tempo, spiega sempre l’Inps, passando dal 19,2% dei papà nel 2013 al 64,5% nel 2023; ma all’appello mancano ancora due papà su cinque e, soprattutto, non c’è l’atteso indotto sull’uso dell’astensione facoltativa. Insomma, la ricetta sembra non funzionare. L’Inps suggerisce di guardare altrove, approfondendo l’identikit del papà che fruisce, o meglio, che “può” fruire del congedo di paternità, perché ha caratteristiche precise: vive al Nord, ha un contratto di lavoro stabile e redditi tra 28mila e 50mila euro. Per esempio, a fruire del congedo di paternità è il 70% dei papà assunti a tempo indeterminato, contro il 40% di quelli assunti a tempo determinato e al 20% degli stagionali.
Per la parità di genere. I due congedi – paternità obbligatorio e parentale – sono stati individuati quali strumenti per favorire la conciliazione tra i tempi di lavoro e cura della famiglia, nell’ottica di una maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli tra i genitori. Tutto prende avvio dalla Convenzione Onu sui diritti del fanciullo del 1989, la quale prevede, tra l’altro, che la responsabilità «di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe a entrambi i genitori», che devono lasciarsi guidare dall’interesse superiore del fanciullo.
Con la direttiva n. 2019/1158, relativa a tale convenzione, l’UE si è dotata di nuove norme sull’equilibrio (conciliazione) tra attività professionali e vita familiare, finalizzato a contribuire al raggiungimento della parità di genere, promuovendo la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e all’equa ripartizione, tra uomini e donne, delle responsabilità di cura e assistenza familiare. Il dlgs n. 105/2022 ha dato corpo alla direttiva UE e recepito i nuovi principi, con alcune modifiche al T.U. sulla maternità (il dlgs n. 151/2001), relativamente alle discipline del congedo di paternità obbligatorio e del congedo parentale.
Il ricorso al congedo di parentale. Il congedo parentale consiste del diritto, riconosciuto ai dipendenti, sia pubblici sia privati, di assentarsi dal lavoro: alla mamma dopo il congedo di maternità; al papà dalla nascita del figlio o dopo l’eventuale congedo di paternità alternativo (questo congedo, da non confondere con il «congedo di paternità obbligatorio», spetta quando la mamma non può fruire del suo congedo di maternità). Il congedo parentale spetta finché il figlio non compie 12 anni, in base a durate (fino a un massimo di 11 mesi) e modalità prestabilite dalla legge. Stessa tutela spetta in caso di adozioni e affidamenti. Tutti gli 11 mesi sono indennizzati al 30% della retribuzione: 9 mesi senza condizioni; 2 mesi se il reddito individuale del genitore che ne fruisce non arriva a 2,5 volte il minimo dell’Inps. Questa è la «tutela minima» fissata dalla legge (TU sulla maternità), ma può essere migliorata dai Ccnl. Caso emblematico è il settore pubblico dove, in genere, per il primo mese è prevista l’integrazione della retribuzione al 100%.
Su questa tutela minima le ultime leggi di Bilancio (anni 2023, 2024 e 2025) hanno inserito maggiorazioni dell’indennità. Dall’anno 2023, la legge di Bilancio 2023 ha previsto un mese di quelli fruiti entro 6 anni di vita del figlio indennizzato all’80%. Da quest’anno, la legge di Bilancio 2024 ha replicato la misura: un altro mese, fruito sempre entro 6 anni di vita del figlio, indennizzato al 60% (80% nel 2024). In Manovra 2025 c’è stato un terzo mese, sempre fruito entro 6 anni di vita del figlio, sempre indennizzato al 60% (80% solo nel 2025).
I dati Inps di dicembre 2023, gli ultimi pubblicati, spiegano che, dopo il triennio 2020/2022 caratterizzato ancora dagli effetti dei provvedimenti per il Covid, i beneficiari di congedo parentale sono stati circa 361mila tra i dipendenti del privato. Rispetto al 2022 c’è stato un aumento del 2,5% (il 2022 è stato comunque l’ultimo anno in cui si poteva fruire ancora del congedo Covid). Confrontando il dato 2023 con quello del 2019 (entrambi gli anni esenti dai provvedimenti Covid) l’incremento è del 9,4%. Qui il dato si fa interessante, perché nel 2023 gli uomini che hanno fruito del congedo sono quali 97mila con un incremento del 41%, rispetto all’incremento delle donne, pari all’1%.
Il ricorso al congedo di paternità. Dal 13 agosto 2022 (dlgs 105/2022) è operativo il nuovo congedo di paternità obbligatorio, a favore dei papà dipendenti, che ha sostituito due analoghi congedi: di paternità obbligatorio e facoltativo, previsti dalla riforma Fornero (legge n. 92/2012). Il nuovo congedo è obbligatorio, cioè vincola i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, compresi domestici e agricoli a termine, ad assentarsi dal lavoro per 10 giorni collocabili tra i due mesi prima della data presunta del parto e i cinque mesi successivi al parto. Per garantire l’utilizzo del diritto al nuovo congedo, il dlgs 105/2022 ha previsto una sanzione che colpisce anche alcune prerogative sulla parità: «Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti di assenza dal lavoro (…) sono puniti con la sanzione da euro 516 a 2.582 e, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere (…), impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni».
I dati Inps di dicembre 2023, gli ultimi pubblicati, spiegano che nel 2023 i padri che hanno fruito del congedo di paternità sono stati 183.052, il 5,2% in più rispetto all’anno precedente 2022 (174.053). L’Inps stima che rappresentano il 64,5% dei potenziali beneficiari e, quindi, che il numero è destinato a crescere. Il take-up (la crescita dell’uso) è aumentato nel corso del tempo, dal 20% dell’esordio nel 2013 all’attuale 64,5%, ma con un piccolissimo incremento tra il 2022 e 2023 (0,5%). Il 47% ne fa uso nell’arco di un solo mese, il 32% lo distribuisce su due mesi, il 12% su tre mesi e il restante 6% e 3% in 4 e 5 mesi rispettivamente. Il sentore è che l’utilizzo sia mero assolvimento di un obbligo piuttosto che la realizzazione del desiderio o necessità della cura dei figli.
Parità ancora lontana. La cura dei figli, dunque, è ancora a tinta rosa. Stando all’Inps, l’uso del congedo di paternità dovrebbe creare un indotto, invogliando i padri ad aumentare l’utilizzo di altri strumenti per le attività di cura dei figli. Ciò per vari motivi, tra cui il fatto che l’uso del congedo da parte dei padri può contribuire a cambiare le norme sociali sul coinvolgimento paterno nella cura dei figli, inducendoli a responsabilità più paritarie con le mamme. Ad esempio, il padre in congedo di paternità potrebbe rendersi conto delle difficoltà nelle attività quotidiane di cura e sentirsi motivato a dare il proprio contributo. Inoltre, il periodo di congedo potrebbe servire ai padri a stabilire un legame più stretto con i figli così da desiderare più tempo da trascorrere con loro usando il congedo parentale.
Questi traguardi, tuttavia, ancora non si vedono come i dati sembrano confermare, anche se non univocamente. È vero che i padri che utilizzano il congedo di paternità sono anche più inclini a usare il congedo parentale; ma questa maggiore propensione ad usare il congedo parentale è di appena 4 punti percentuali.
L'articolo Ai figli bada sempre la mamma proviene da Iusletter.