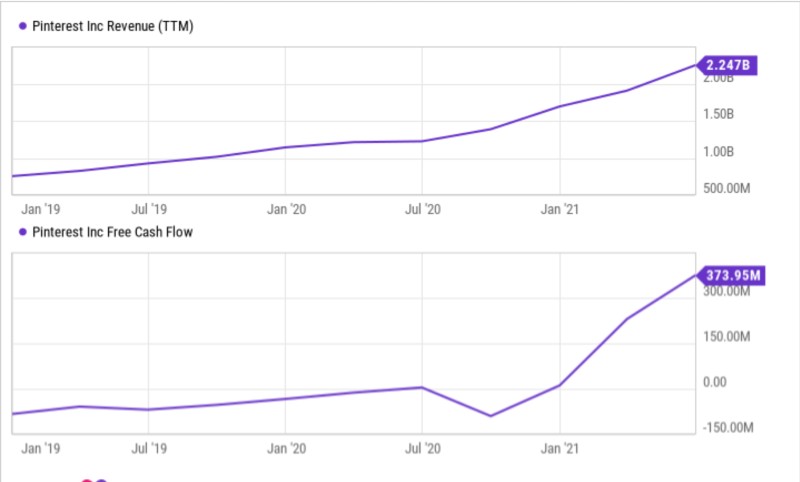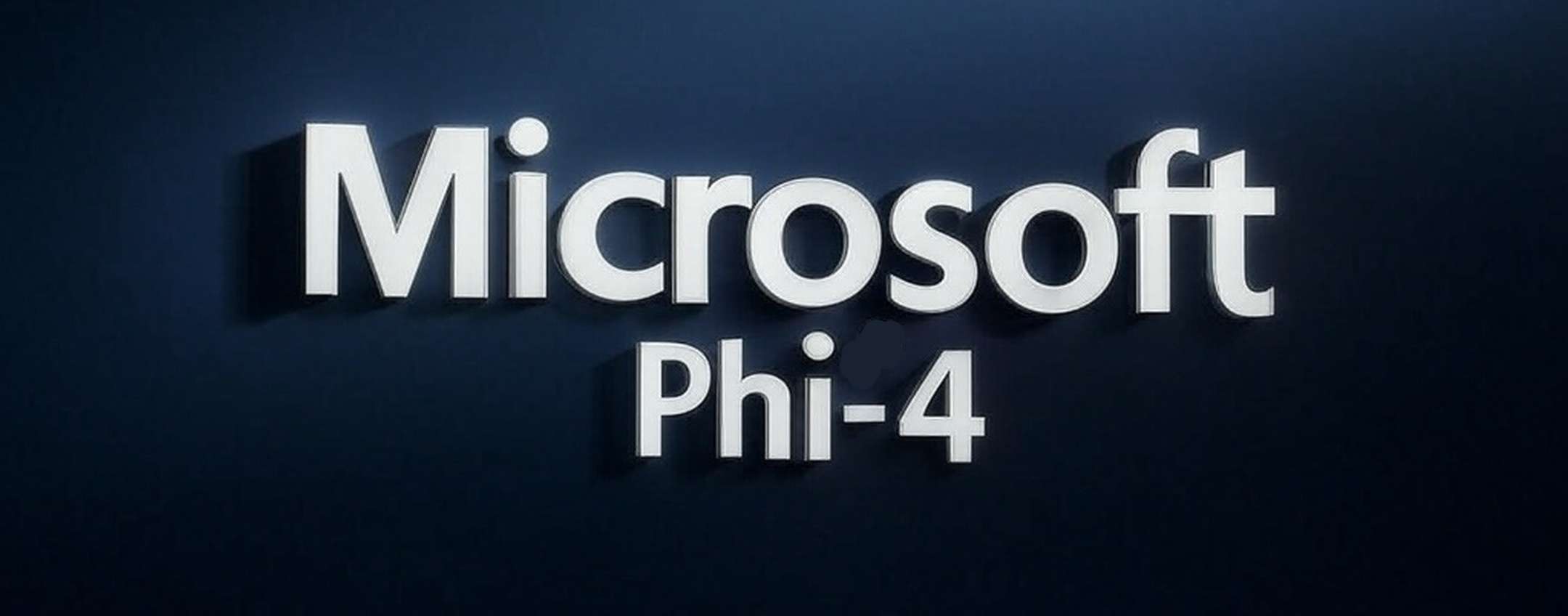Taddei, Economika: «I conti dell’Italia tornano, il problema è che non li guardiamo»
Scarsa produttività, debito pubblico ai massimi storici e crescita da anni ferma allo zero virgola. Sono solo alcuni dei malanni più annosi che affliggono l’economia italiana. «Il bello di questi temi è che alla fine sono un po’ tutti collegati» dice Massimo Taddei, Founder e Direttore di Economika, che nel suo primo saggio I conti […] L'articolo Taddei, Economika: «I conti dell’Italia tornano, il problema è che non li guardiamo» proviene da ilBollettino.

Scarsa produttività, debito pubblico ai massimi storici e crescita da anni ferma allo zero virgola. Sono solo alcuni dei malanni più annosi che affliggono l’economia italiana.
«Il bello di questi temi è che alla fine sono un po’ tutti collegati» dice Massimo Taddei, Founder e Direttore di Economika, che nel suo primo saggio I conti non tornano, edito da Rizzoli, prova ad andare alla radice di questi problemi.
«La bassa produttività dipende dalla piccola dimensione d’impresa, che a sua volta dipende anche dal basso numero di occupati rispetto alla popolazione. E l’incentivo a evadere, per esempio, aumenta o diminuisce a seconda del numero di occupati».

Quali sono i conti cui si accenna nel titolo del libro e soprattutto cosa non torna?
«In realtà i conti tornano benissimo, il problema è che non li guardiamo. La media delle persone non ha veramente idea di come stia andando la nostra economia e si ferma a paragoni stereotipati con gli altri Paesi, rimanendo convinta – e rassegnata – che l’Italia sia sempre ultima della classe. Questo libro vuole un po’ mettere insieme i conti e i dati più rilevanti. Da un lato, l’obiettivo è mostrare chiaramente come i conti non tornino effettivamente, perché le risorse che abbiamo a nostra disposizione non bastano per crescere. Allo stesso tempo, però, anche se non sono così semplici da risolvere, la lezione da trarre è che i macro-problemi che affliggono il nostro Paese sono piuttosto chiari».
Il focus principale del libro sono le ragioni per cui l’Italia non cresce più. Se le chiedessi di riassumere queste ragioni, cosa direbbe?
«Direi quasi la cultura, ma si può essere ancora più precisi: il nostro difetto è il familismo amorale. Si tratta della mancanza di una vera idea di cooperazione accompagnata a un fortissimo individualismo, che non è però personale, bensì familiare. In altre parole, le persone guardano solo al proprio orticello. Io credo che la maggior parte delle cose che sono contenute nel libro siano in qualche modo riconducibili a questo atteggiamento. Attenzione, non è che negli altri Paesi non ci sia l’attaccamento alla famiglia. Ma magari altrove non si è disposti ad andare oltre a qualsiasi principio di giustizia, legalità o moralità pur di coltivare i propri interessi. Lo si vede in ogni singolo capitolo del libro: dalle pubbliche amministrazioni colpite dal nepotismo alle baby pensioni degli anni ’70 e ’80, che hanno contribuito a creare i problemi che oggi affliggono il sistema della previdenza pubblica».
Quali sono gli ingredienti più importanti per invertire la rotta?
«Questo è quello che provo a raccontare nell’ultimo capitolo del libro. Parlando con alcuni colleghi, qualcuno a volte dice che l’educazione finanziaria in fondo non è così importante. In parte è vero: non è che insegnando cos’è il tasso d’interesse alle persone si risolvano i problemi di politica economica del Paese. Allo stesso tempo, io credo che la medicina più grande sia la conoscenza. E non tanto perché bisogna essere tutti competenti, ma perché la cosa di cui abbiamo più bisogno è la fiducia. In generale, manca totalmente la fiducia nell’economia e nei temi sociali, perché non li si conosce. Da questo punto di vista, l’educazione è importante come soluzione non tanto perché sapere queste cose ci aiuti a risolverle, quanto perché ci insegna a ragionare consapevolmente di fronte a decisioni – anche politiche – cruciali per il nostro futuro, senza farsi ingannare e senza rinunciare a dare un contributo al dibattito. Insomma, io credo che la fiducia sia la base. Assieme ovviamente, a tutti gli strumenti che l’economia ci offre».
C’è un collegamento tra la nostra generale carenza di educazione finanziaria e la scarsa crescita del Paese?
«I fattori culturali sono fondamentali. Bisogna essere svegli, curiosi, propensi all’innovazione. L’esempio più classico che si fa è l’Irlanda. Un Paese quasi allo sbando che, grazie a politiche fiscali di un certo tipo e soprattutto grazie a una forza lavoro poco costosa, ma che parlava inglese, si è trovato ad avere tassi d’innovazione e di crescita della produttività altissimi. Ora, a prescindere dal fatto che queste statistiche sono in parte “drogate” dalla presenza di numerose multinazionali per questioni fiscali, oggi i giovani irlandesi stanno molto meglio di quelli italiani. Dipende dall’input e da ciò che hai a disposizione, ma credo che anche la cultura possa frenare parecchio l’innovazione. Un’azienda con più addetti è più produttiva, quindi dovremmo spingere le imprese a far crescere la loro dimensione. Ma per arrivare a capirlo, bisogna abbattere luoghi comuni come “piccolo è bello”, delle piccole e medie imprese come spina dorsale dell’economia e così via. Ci sono tante verità che purtroppo politicamente sono difficili da somministrare».
Qual è il numero che l’ha sorpresa di più, nella stesura del libro?
«Sono dati su cui lavoro da anni, per cui venire sorpresi diventa più difficile. La cosa che ci ho messo più tempo a capire è l’andamento del nostro PIL. Un bel giorno ho pensato di fare un confronto tra la capacità di ripresa delle varie economie in seguito alla crisi del 2008. Io per primo non me ne ero reso conto, ma nel momento in cui leggevo quel dato, l’economia italiana non si era ancora del tutto ripresa dalla crisi. E non lo era neanche quando è arrivata la pandemia, ad affondarci di nuovo».
«Gli italiani lavorano troppo poco», si legge nel libro. D’altra parte, il Paese è storicamente afflitto da un problema di scarsa produttività. Come si intersecano questi due temi?
«Questo può sembrare un grande dilemma: in teoria, visto che siamo un Paese con un’economia molto grande, anche se con una crescita stagnante, il fatto che così poche persone lavorino può far pensare che lavorino molto bene. E in parte è così, o almeno lo era: la produttività oraria dei lavoratori italiani partiva da una base abbastanza alta, solo pochi anni fa. Il problema è che poi ha smesso di crescere, e infatti abbiamo perso terreno. Credo però che il più grosso legame – anche se indiretto – che si può fare tra scarsa produttività e occupazione, sia legato alle questioni femminile e giovanile. Sono tantissimi i fattori per cui la produttività non cresce e ovviamente non si tratta solo di questo. Ma avere un Mercato del lavoro dove ci sono pochi giovani e poche donne vuol dire, tra le tante cose, avere un Mercato meno innovativo, che di conseguenza funziona anche peggio. Non perché le donne siano più innovative degli uomini, ma perché un sacco di studi dimostrano che la diversità all’interno delle aziende aiuta, soprattutto nella catena di comando. Tende a migliorare i processi decisionali e a far raggiungere risultati migliori».
Si può legare questa disparità di genere a differenze nei livelli di conoscenza finanziaria?
«Io credo che la parte più interessante del divario consista nella cosiddetta discriminazione indiretta, la parte più implicita. Quella esplicita esiste, certo, ma una buona parte del gap è dovuta a questioni culturali. Per lo più alle donne italiane non è esplicitamente vietato di lavorare, sulla carta lo possono fare liberamente. Ma appunto per ragioni culturali ci si aspetta che stiano a casa a prendersi cura dei figli. Nonostante ci siano caratteristiche innate, differenze naturali tra i sessi, anche a livello di capacità cognitive, la maggiore differenza è questa: le donne sanno meno di economia e finanza rispetto agli uomini proprio per via della diversa educazione che hanno ricevuto».
Dallo scambio con la vostra community, in questi anni avete notato qualche progresso sul piano delle conoscenze finanziarie nel Paese?
«Sì, si sono fatti sicuramente dei passi avanti. C’è anche un problema: la comunicazione social raggiunge tante persone, ma poi dovrebbe essere accompagnata da ulteriori approfondimenti, che a volte mancano. Comunque, penso che qualche progresso ci sia: dei 200mila che raggiungiamo con un post, una quota va verso un approfondimento maggiore. Non lo fanno tutti, ma avviene. E io credo che faccia parte del nostro ruolo non solo avvicinare all’economia chi non l’ha studiata, ma anche aiutare chi la conosce a calarla nel contesto reale. È una cosa che anche all’università non si insegna».
Qual è il più grande errore che i media tradizionali fanno quando parlano di economia e finanza?
«Difficile dirlo, ce ne sono tanti… Sicuramente una cosa molto grave è l’incapacità di interpretare le medie. Se lo stipendio medio è di 20mila euro, non significa che quello sia il reddito del cittadino tipo; sono dati che vanno guardati con più cautela. E le retribuzioni non sono nemmeno il caso più grave. In generale, il punto debole è l’elaborazione dei numeri. I giornalisti italiani riportano molto quello che leggono, ma spesso non elaborano».
In generale, l’Italia continua a scontare un gap di educazione finanziaria rispetto ad altri Paesi europei. Quali sono gli strumenti a disposizione per cambiare la situazione?
«Il primo è senza dubbio internet. Oggi è sicuramente il modo più adatto per migliorare le proprie competenze, grazie alla grande quantità di informazioni di qualità che fornisce. Ed evitare le truffe è abbastanza facile, se si affrontano le cose con lo spirito giusto. Se l’idea di fondo non è quella – irrealizzabile – di diventare miliardari investendo, ma semplicemente di investire al meglio possibile, sarà più difficile incappare in “fuffa guru” che ti offrono rendimenti del 1000% in un giorno. In generale, internet è una fonte pazzesca: qualcuno è arrivato perfino a ipotizzare che i social network possano diventare i nuovi broker della Generazione Zeta».
In compenso, la rete ospita anche moltissimi contenuti imprecisi, errati o perfino malevoli. Come vagliarli?
«Alla fine i criteri sono gli stessi con cui si sceglie un bravo medico, o un avvocato. Sì, ovviamente ci sono gli albi professionali, però se non sono esperto di qualcosa, come faccio a capire se chi ho di fronte ne sa davvero più di me? Ci vuole senso critico personale e un sistema di fiducia basato su una capacità dei media tradizionali e delle istituzioni di far capire a chi dar credito e a chi no. Dovremmo riuscire ad arrivare a un ecosistema in cui gli attori autorevoli siano chiaramente identificabili. Non è semplicissimo, perché più si va verso la disintermediazione, più è difficile avere un filtro. Per fare un esempio, un giornalista in televisione è stato assunto da qualcuno, ma un ragazzo che fa un video su TikTok potenzialmente raggiunge milioni di persone senza ricevere alcun vaglio. Penso che la soluzione passi attraverso una validazione da parte di chi ha già un certo livello di autorevolezza. In questo senso, s’è una grossa responsabilità da parte di alcuni “campioni” dell’informazione e della politica».
L’auspicio, dunque, è quello di creare nuovi legacy media riconosciuti da tutti, ma in questo nuovo spazio?
«Sarebbe bello. Chi sta in quest’industria adesso spera in una progressiva concentrazione del Mercato. Nel 2020 chiunque faceva informazione sui social, perché eravamo tutti chiusi in casa. Adesso noi stessi, con Economika, facciamo parte di un gruppo editoriale più grande, quello di Starting Finance. La speranza è quella di crescere ancora, ma non è per niente facile. Con queste trasformazioni è difficile capire cosa sarà permanente e cercare di stare al passo dell’industria».
©